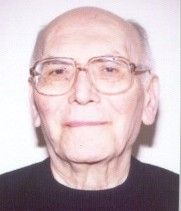Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Rebucini Battista
Sul registro dei defunti che si trova nella parrocchia di Berbenno, Bergamo, accanto al nome della mamma di P. Battista – Caterina Anconetti – ivi deceduta nel 1975, c’è una nota che non si trova per nessun’altra defunta e che contrasta con l’uso dei parroci di mettere aggettivi o attributi accanto al nome di chi era passato a miglior vita. Ebbene, questa umile mamma è chiamata “Piissima donna”. Nel cuore di questa creatura trovano origine le vocazioni missionarie di P. Battista e poi del fratello, P. Riccardo, anche lui Comboniano, morto ad Arco nel 1992.
Benché nato, battezzato e cresimato a Gerosa, P. Battista frequentò la scuola elementare di Brembilla: tre anni a Cavaglia e due a Brembilla-centro nella cui chiesa ricevette la prima comunione.
Fin da piccolo, accompagnato dalla mamma, andava ogni giorno a pregare e a fare il chierichetto nella chiesa di Cavaglia e talvolta anche nella chiesa prepositurale di Brembilla dove, fresco di sacerdozio, andrà a fare il parroco per quasi due anni.
Il papà, di nome Battista, era commerciante di legnami e carrettiere. Acquistava dei boschi, faceva tagliare gli alberi e mandava i tronchi agli artigiani di Brembilla o li trasportava a Bergamo. Al ritorno portava le merci per rifornire del necessario il paesino di Gerosa. Era un gran lavoratore per cui riuscì a sostenere dignitosamente la sua famiglia anche nel periodo della guerra.
Il patto con Dio
La mamma era nata a Parigi dove la sua famiglia si trovava per motivi di lavoro. A 15 anni rientrò a Gerosa e qui sentì la chiamata alla vita religiosa ma l’opposizione paterna fu tale che dovette desistere dal suo proposito. Prima di tornare in Francia, il futuro papà di P. Battista, le manifestò i suoi sentimenti d’amore in vista di formare una futura famiglia, ma la ragazza gli rispose che nel suo cuore aveva fatto un’altra scelta: voleva farsi suora.
Di fronte all’opposizione del padre, convinto anticlericale, si consigliò con il suo confessore il quale le chiese se non avesse mai avuto proposte di matrimonio. La ragazza rispose di sì, ma avendo opposto un netto rifiuto, il pretendente non si era più fatto vivo. “Se in questi giorni riceverai una sua lettera, è segno che il Signore ha stabilito per te la via del matrimonio e non quella della vita religiosa”, le rispose il sacerdote. Pochi giorni dopo, infatti, inaspettatamente giunse a Caterina una lettera di Battista nella quale il giovane rinnovava la sua richiesta. Caterina capì chiaramente qual era la volontà di Dio nei suoi riguardi, tuttavia, nel segreto del suo cuore, chiese al Signore due cose in cambio della sua rinuncia alla vita di verginità: primo, che almeno uno dei figli che il Signore le avrebbe dato, diventasse sacerdote; secondo, che suo padre si convertisse alla pratica della religione.
Il Signore, che non si lascia mai vincere in generosità, chiamò non uno, ma due dei suoi figli, non solo alla vita sacerdotale, ma anche a quella missionaria, e suo padre, il nonno di P. Battista per intenderci, si convertì così radicalmente che per molti anni fece parlare di sé tutto il vicinato.
Quando arrivò il momento di lasciare questo mondo, mamma Caterina si trovò accanto i due figli sacerdoti. Scrive P. Battista: “L’indomani mattina, venerdì, mi portai in ospedale presso la mamma che fu assai felice di vedermi. Dopo averla incoraggiata e consolata, le proposi di amministrarle i sacramenti durante la Messa che avrei concelebrato con mio fratello nella cappella dell’ospedale. Lei accettò con entusiasmo. Pur comunicandosi tutti i giorni, per una miglior preparazione volle che la confessassi. Il giorno dopo, presente il papà e tutti i fratelli e sorelle (due erano venuti dalla Svizzera), le conferii il viatico e l’unzione degli infermi. La mamma era seduta su una poltroncina. Alla fine ci disse: “Ora non m’importerebbe morire, anzi ne sarei felice”.
Mamma Caterina, tutte le mattine, incurante delle intemperie e della notevole distanza (3 km) era alla prima Messa e poi rincasava svelta per accudire i sei figli che il Signore le aveva dato.
P. Luigi Varesco, parlando della spiritualità di questa donna durante il funerale di P. Battista, ha ricordato quando, trovandosi in casa del confratello per il cinquantesimo di matrimonio dei suoi genitori, ad un certo punto la mamma disse: “P. Luigi arrendiamoci all’immenso amore di Cristo”.
Accanto alla Madonna della Foppa
In questo clima la famiglia cresceva sana di corpo e di spirito. Intanto Battista entrò nel seminario di Bergamo e il 4 marzo 1944, a 23 anni, divenne sacerdote e fu inviato a Roma dal suo vescovo per laurearsi in vista dell’insegnamento in seminario. Contemporaneamente ebbe il titolo di parroco di Brembilla. P. Battista Zanardi, che fu suo compagno di seminario, scrive: “In seminario Rebucini fu subito notato per la sua intelligenza e memoria formidabile. Riteneva a mente lezioni di filosofia, che a passeggio ripeteva con me. Così pure imparava tutto ciò che il professore spiegava. Per questo, dopo il liceo, fu mandato a Roma per studiare all’Università”.
Celebrò alcune delle sue prime Messe nel santuario della Madonna della Foppa di cui era particolarmente devoto. Fin da piccolo, infatti, con la mamma e i fratelli frequentava quasi quotidianamente questo santuario vicino alla sua casa, dove la Madre di Dio era apparsa a due pastorelli e aveva fatto scaturire una sorgente d’acqua miracolosa durante un lungo periodo di siccità. Inoltre considerava quella Madonna come la protagonista del suo sacerdozio, colei che lo aveva aiutato a raggiungere la meta tanto agognata, pur tra tante difficoltà.
Il santuario della Foppa rappresenterà una meta ideale anche durante gli anni seguenti. Lo constatiamo dalle numerose lettere nella quali parla spesso di questa Madonna sempre larga di benedizioni e di favori nei confronti dei suoi devoti.
Da tempo Battista sentiva in sé la vocazione missionaria e il rettore del seminario scrisse che il suo vescovo “gli ha già detto che non intende creare difficoltà di sorta alla sua vocazione missionaria”. Così, il 12 novembre 1945, entrò nel noviziato di Venegono dove il 19 marzo 1947, festa di San Giuseppe, emise la professione temporanea.
P. Antonio Todesco, suo padre maestro, scrisse di lui: “Dimostrò subito buona comprensione religiosa e grande generosità. Ama assai la sua vocazione ed è attaccato all’Istituto e alle Regole. Pietà soda e molto zelo nel ministero sacerdotale. Molto obbediente. Carattere vivace, attivo, socievole, intelligente, schietto e soggetto ai superiori. Salute buona”.
Stima della vocazione
Da alcune lettere scritte da P. Battista rileviamo i suoi intimi sentimenti a proposito della vita religiosa e missionaria: “Sento imperioso il bisogno di radicarmi profondamente nella vita interiore e di lavorare infaticabilmente all’acquisto delle virtù destinate a formare in me un santo religioso e missionario per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Già fin d’ora protesto di mettermi nelle sue mani e sotto la sua direzione con perfetta docilità, di null’altro desideroso che di fare la santa volontà di Dio. Abbia, Padre, la bontà di aiutarmi ora e sempre con le sue orazioni che ricambierò di cuore (2 novembre 1945)”. Il suo parroco, Don Giacomo Toti, aggiunse: “Attesto che non ho mai avuto motivo di alcun richiamo riguardo a Don Battista. È ottimo di carattere e di buon comando. Saprà rendere molto anche nel loro noviziato”.
E altrove P. Battista scrive: “Innanzitutto non posso sottrarmi al dovere di esprimerle il più vivo grazie per la paterna accoglienza fattami nel giorno memorabile in cui sono venuto a Venegono. Spero che presto mi si spalancheranno definitivamente le porte della Congregazione onde potermi dedicare incondizionatamente, sotto l’usbergo dell’obbedienza, alla gloria di Dio e all’opera di conversione dei poveri infedeli dopo aver, beninteso, ritoccata e santificata la mia anima nel periodo del noviziato”.
“Imploro, istantemente la paterna benedizione affinché mi sia sorgente e pegno di quella larga effusione di grazie che mi abbisognano per corrispondere sempre e in tutto e con grande generosità alla mia alta vocazione” (11 marzo 1947).
“Il sottoscritto sacerdote di voti temporanei, sempre più entusiasta della sua vocazione religiosa missionaria, chiede che venga ammesso alla rinnovazione per un altro triennio o all’emissione dei voti perpetui. Esprimendo con effusione di cuore la propria riconoscenza per il tanto bene che V. Paternità gli ha sempre fatto e voluto ne implora la paterna benedizione che gli ottenga tutte le grazie necessarie per non rendersi mai indegno, anzi per corrispondere nel migliore dei modi alla sua santa vocazione” (4 gennaio 1950). Il superiore, P. Alessandro Medeghini annotò: “Da parte mia e dei RR. Padri, approvazione ex toto corde per i voti perpetui”. Senza aspettare i sei anni di voti temporanei gli fu concesso di emettere quelli perpetui.
Il vescovo avrebbe detto ai superiori dei Comboniani: “È uno dei miei migliori sacerdoti per santità, intelligenza e zelo; vi prego, però, di non farlo mai superiore perché non ne porterebbe il peso, essendo un tipo troppo preciso ed esatto in tutto”. I superiori ne tennero conto.
Nel 1949, anche il fratello Riccardo fece domanda per entrare tra i Comboniani. La sua richiesta fu inoltrata proprio dal fratello Battista, sacerdote da 5 anni e che da due aveva terminato il noviziato. Accompagnò la domanda del fratello al Superiore Generale con queste parole: “Ho il piacere e la soddisfazione di spedirle la domanda di ammissione al noviziato di mio fratello Riccardo...”.
Sempre disponibile all’obbedienza
Lasciato il noviziato, P. Battista fu inviato a Brescia come aiutante provvisorio nel ministero. In quel periodo si dedicò alle Giornate Missionarie, alla predicazione, ai ritiri e alle Quarantore nella diocesi di Brescia.
Tutte cose che P. Battista fece con molta cura, preparandosi scrupolosamente. A Brescia rimase 13 mesi perché nel settembre del 1947 passò a Verona come insegnante di teologia agli scolastici. Quando questi andarono a Venegono (1948) e il noviziato si trasferì a Gozzano, P. Battista seguì gli scolastici, insegnando teologia morale a Venegono dal 1948 al 1951. Ma non si limitava solo alla scuola: era disponibile per le Giornate Missionarie, frequentava i raduni dei sacerdoti, si prestava a risolvere i casi di morale e teneva conferenze. Insomma, oltre che un esimio professore era un padre e un pastore.
Nel giugno 1951, in vista di una prossima partenza per la missione, fu mandato a Londra, per studiare l’inglese, e vi rimase fino al maggio 1952. Dopo le vacanze a Valdiporro (VR) e a Verona, partì per l’Uganda.
Fu a Kitgum dall’ottobre al dicembre del 1952 per lo studio dell’acholi; a Nyapea, dal dicembre 1952 al gennaio 1953 per lo studio dell’alur. Quindi passò al seminario di Lacor dal gennaio 1953 all’ottobre 1956 come vice-rettore, insegnante e cancelliere del vescovo.
“Di ministero ne ho avuto abbastanza quest’anno – scrisse da Lacor nel 1966 – e ne ringrazio il Signore. In maggio e in agosto, dietro richiesta dei superiori regionali, tenni gli esercizi spirituali ai confratelli sacerdoti rispettivamente ad Ombaci e a Gulu. Lo scorso dicembre avevo predicato due corsi di esercizi spirituali di otto giorni in inglese nei noviziati di Alokolum e di Ladonga e parecchi ritiri alle suore del seminario e di Gulu. Durante l’anno scolastico, quattro giorni alla settimana, talvolta cinque, uscivo per ministero nella chiesa di Lacor, nell’ospedale, nei collegi e nei conventi. In particolare ogni domenica, nel nostro ospedale, posso amministrare molti santi battesimi a neonati e a bambini ammalati”.
Di nuovo a Venegono
Dall’ottobre del 1956 lo troviamo nuovamente a Venegono come insegnante di teologia morale e vice-superiore. Vi rimase fino al 1965, anno in cui andò una seconda volta a Lacor in Uganda.
Nel 1971 frequentò il Corso di Rinnovamento a Roma e poi tornò al suo insegnamento in Uganda, fino al 1975. Qui fu colpito da una strana malattia per cui dovette rientrare in fretta in Italia. Passò quasi sei mesi ammalato, prima al Policlinico Gemelli di Roma (in febbraio) e poi presso l’infermeria di Verona: era in corso un fatto encefalitico che gli provocava una paresi agli arti inferiori con momenti di confusione mentale e febbre alta.
Nel dicembre del 1975, essendosi leggermente ripreso, ripartì per Gulu come confessore in cattedrale e vi rimase fino all’aprile del 1976 quando, in seguito ad una ricaduta, dovette tornare in Italia. Fu ricoverato all’ospedale di Verona, poi fece la convalescenza in Casa Madre, ad Arco e in famiglia. Rientrato a Verona, a settembre fu mandato a Londra per un check-up presso l’ospedale di malattie tropicali. Abitava ad Elstree, dove rimase fino al novembre 1976.
Scrivendo al Superiore Generale disse: “Non è stato riscontrato alcun germe patogeno o virus: questo risultato, però, non mi soddisfa appieno in quanto si voleva conoscere la natura e l’origine del male che mi ha colpito per ben due volte a distanza di un anno. Tornare in Africa e ricadere di nuovo, con enorme disturbo per tante persone e spese rilevanti di viaggio, non è incoraggiante, a prescindere anche dal pericolo di finire al cimitero, il che, però, non mi mette paura. La scarsa sensibilità ai piedi non mi permette di guidare l’auto. I vari istituti dovrebbero venirmi a prendere per le confessioni. Alcuni di essi, come i due seminari di Lacor e di Alokolum mi lasciano indisturbato, ugualmente le studentesse infermiere e anche quelli che potrebbero venire a prendermi, molte volte si dimenticano. Comunque io rimango a sua completa disposizione per qualsiasi destinazione, pur continuando a sognare l’Africa.
Il soggiorno in Inghilterra mi ha giovato molto perché sono stato a contatto con una comunità di giovani ben affiatati dove regna grande serenità. Ho rinfrescato l’inglese e ho letto parecchi libri di spiritualità soprattutto biblica e pastorale, a partire dalla Bibbia stessa. Intanto cerco di tenermi occupato applicandomi più a lungo alla preghiera e andando tutte le domeniche fuori per varie Messe e predicazione. Comunque mi abbandono docilmente al divino volere che mi verrà manifestato dai superiori”.
Dal novembre 1976 lo troviamo a San Tomio dove rimase fino al giugno 1989. Dal 1990 al 1991 fu a Rebbio in cura. Da questa data fino alla morte rimase presso il Centro Ammalati di Verona, in Casa Madre.
Esimio professore di morale
P. Battista era un professore minuzioso, chiaro, preciso, paziente. La sua preoccupazione era quella della salvezza delle anime, perciò temeva di non preparare abbastanza i futuri sacerdoti al ministero della predicazione e della riconciliazione. E allora si sforzava di applicare i principi generali della morale ai casi particolari della vita. Ripeteva molto spesso che, nel ministero delle confessioni, bisogna saper ascoltare: “Ascoltare e trovare le scusanti in modo da dare serenità e fiducia al penitente”.
Possiamo ricordare un fatto che gli è accaduto quando era neolaureato e che dimostra la sua capacità di applicare i principi generali ai casi della vita. In paese c’era stato un caso di suicidio. Secondo le leggi vigenti non si poteva celebrare la Messa per il defunto e nemmeno portarlo in chiesa. Ma la famiglia era buona e onorata e anche il suicida era stato un cristiano esemplare. Il parroco disse: “Se interpello il Vescovo, mi dirà di applicare il canone; se lo porto in chiesa disobbedisco andando contro la legge. Che fare?” Allora chiese un parere a P. Battista. Questi, dopo una lunga serie di distinguo e di precisazioni, disse al parroco che poteva portare il defunto in chiesa e celebrargli la Messa”. Cosa che il parroco fece molto volentieri. Il neodottore aveva visto e giudicato bene e la Chiesa, in seguito, gli avrebbe dato ragione facendo lo stesso in casi analoghi.
Come insegnante era buono, comprensivo, sempre pronto ad aiutare chi faticava un po’. In qualche sua lettera parlò anche di questo aspetto.
“Anche la scuola mi ha riservato molte e inattese soddisfazioni: grande diligenza e impegno da parte dei chierici. Per venire incontro al loro desiderio, ho dovuto aggiungere diversi periodi di scuola extra: i sette sudanesi del IV corso dovevano, quest’anno, svolgere la parte di due anni e mezzo di morale, per finire, ora, non soltanto loro ma anche gli studenti del terzo corso teologico. Tanto sudanesi quanto ugandesi vollero prendere parte a quelle lezioni nelle ore pomeridiane e fuori orario scolastico. Finita la scuola mi hanno detto: ‘Tante e tante grazie reverendo padre’ ed è poi venuto nella mia stanza il loro rappresentante per esprimermi più effusamente la comune riconoscenza. In particolare mi ha commosso assai il neo ordinato P. Joseph Zingorani (Mupoi) il quale, dopo la sua prima Messa al convento delle suore indigene in Gulu, tornati in sacrestia mi disse: ‘Padre, mi permetta di darle la mia benedizione sacerdotale in segno della grande riconoscenza che le porto per tutta la pazienza e carità usata verso di me in quest’anno e mezzo che mi ha avuto alla sua scuola’”.
In un altra lettera scrisse: “Con gli studenti mi trovo a meraviglia, la scuola si svolge in un’atmosfera di serenità, di rispettosa docilità e di fraterna, amichevole comprensione che, anziché distogliere, sprona gli studenti a sempre maggior impegno e serietà nello studio”.
In Uganda, come insegnante di morale ai seminaristi di Gulu, raddoppiò il suo impegno anche perché temeva di non possedere abbastanza la lingua inglese o di non farsi capire dagli studenti. Così ha formato generazioni di sacerdoti africani. Tra Italia e Africa P. Battista ha contribuito a formare più di mille sacerdoti.
Consigliere, confessore e padre
Non potendo più servire la missione come professore, divenne confessore a San Tomio, Verona. Vi rimase dal 1977 al 1989, 12 anni. Era chiamato “il teologo”. La sua messa era sempre frequentatissima, grazie anche al bel modo di predicare e alla chiarezza della sua esposizione: Soprattutto il suo confessionale era sempre assiepato da fedeli, sacerdoti, religiosi e religiose che, nel suo giorno di riposo, andava a confessare nei loro conventi in città.
Poi subentrò la malattia: dal 1989 alla morte, 16 anni, trascinandosi a fatica nel corridoio degli ammalati del secondo piano in Casa Madre e poi immobilizzato in carrozzella. Il suo, fu un lungo calvario, eppure era sempre contento, sempre ottimista. A chi gli chiedeva come stava, rispondeva: “Bene”. E mai un lamento, mai, mai.
Ha combattuto la buona battaglia
P. Battista può ben dire con San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al traguardo, ho conservato la fede. Ora aspetto la corona che Dio riserva ai suoi servi”. L’uomo dal lungo cammino era arrivato al traguardo, un traguardo guadagnato a prezzo di lotte non comuni. Ma la grazia di Dio non gli è venuta meno. La liturgia del funerale ci presentava la lettura del Vangelo che diceva: “Ti ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e ai sapienti e le hai manifestate ai piccoli”. Pur essendo un uomo di grande intelligenza, P. Battista si considerava un piccolo, un semplice, davanti a Dio. Per questo ha potuto sentire dalla voce del Signore il “Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò”. Tanti anni di immobilità, in gran parte su una sedia a rotelle, sono stati una battaglia lunga e faticosa, ma P. Battista ce l’ha fatta senza mai perdere la sua serenità e il suo buon umore.
“È stato il classico ammalato modello – ha detto il direttore del Centro Ammalati. Finché ha potuto, ha voluto esercitare il ministero e alla sera non andava a dormire finché non aveva sentito e annotato il programma del giorno dopo, in modo da alzarsi con la giusta predisposizione. Il Signore lo ha anche premiato con una morte serena e senza dolori, pochi minuti dopo aver celebrato la Messa e ricevuto il Corpo di Cristo”. Un collasso cardiocircolatorio lo ha stroncato la sera del 9 maggio 2006. P. Battista era molto amato dalla sua numerosa famiglia, era considerato un patriarca. Una nipote ha voluto dirglielo, leggendo un commovente saluto durante la cerimonia funebre.
I funerali di P. Battista, prima in Casa Madre e poi a Berbenno, sono stati come una festa di Pasqua. Numerosi i sacerdoti che si sono riuniti sull’altare per celebrare l’Eucaristia in suffragio del confratello. Poi la salma è stata tumulata tra i sacerdoti della parrocchia per essere segno di benedizione e luce per tutti sulla strada dell'eternità. Molti Missionari Comboniani lo ricorderanno con riconoscenza e affetto e, certamente, dal paradiso egli continuerà a proteggerli e ad aiutarli come faceva sulla terra.
(P. Lorenzo Gaiga, mccj)
Da Mccj Bulletin n. 232 suppl. In Memoriam, ottobre 2006, pp. 60-69.