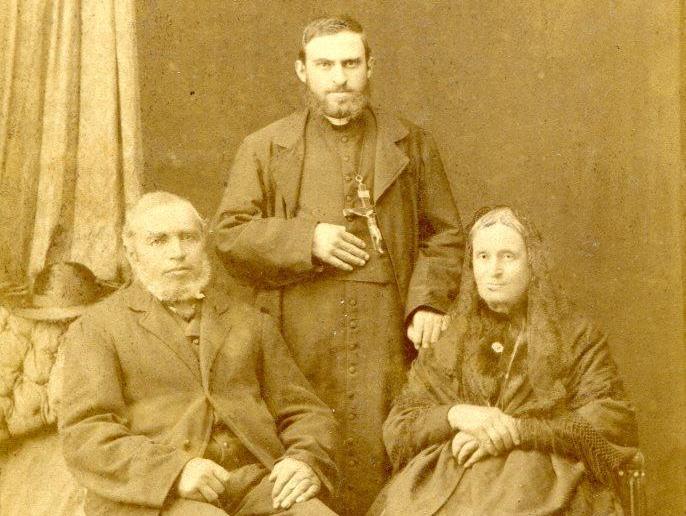Nato a Montagna, Sondrio, nel 1909 compì gli studi nel seminario diocesano, maturando nel cuore una sicura vocazione missionaria che, nel 1926 lo portò tra i Comboniani. Entrato nel noviziato di Venegono Superiore, dopo la professione religiosa andò a Trento come assistente dei seminaristi missionari e poi come insegnante. Essendo dotato di una fine vena poetica e umoristica, in quegli anni collaborò al Piccolo Missionario con poesie battute e pagine divertenti.
Nel febbraio del 1937 partì per l’Uganda, destinato a Kangole, la prima missione incipiente tra i karimojong, dove c’erano due confratelli. Imparò con relativa facilità quella difficile lingua che, ben presto, riuscì a possedere alla perfezione tanto da comporre una grammatica e un vocabolario. Erano i primi documenti scritti in quella lingua di pastori seminomadi e guerrieri.
Infaticabile nelle visite ai villaggi anche più lontani, si fermava a parlare con la gente, specie con gli anziani dai quali si faceva raccontare le usanze dei karimojong. In un tempo relativamente breve, divenne l’amico di tutti. Ciò gli facilitò l’evangelizzazione di quel popolo.
Prigioniero
Nel 1940 la guerra impose anche a lui di lasciare il suo posto per il campo di concentramento di Katigondo, dove gli giunse la notizia che la sua missione di Kangole era stata distrutta.
Con la guerra, gli italiani che si trovavano nei territori inglesi, furono ritenuti nemici dell’Inghilterra e perciò imprigionati. Grazie al suo carattere sempre allegro, p. Felice riuscì a rendere meno pesante ai confratelli il tempo della prigionia inventando scenette e commedie che tenevano allegre perfino le severe guardie inglesi.
Con la fine della guerra, non solo non fu permesso l’entrata di nuovo personale missionario in Uganda, ma circolarono voci di un allontanamento di tutti i missionari cattolici. P. Felice, sebbene malato, riuscì ad andare a Gulu dove diede inizio alla scuola di Lacor, nel nord Uganda, che ebbe subito un grande sviluppo.
Solo nel 1949 le autorità britanniche gli concessero di tornare tra i karimojong. Poté aprire la missione di Morulem, poi fu la volta di Nadiket, a poche miglia dal vecchio posto di Kangole. Mancava tutto: acqua, strade, paglia per i tetti e fango per le costruzioni. P. Felice non si perse d’animo e insisté presso le autorità finché gli diedero il permesso di riaprire Kangole; fu una vittoria della sua pazienza e costanza.
Un punto di riferimento
Data la sua conoscenza della lingua locale divenne il punto di riferimento per le autorità che si rivolgevano a lui per consigli e suggerimenti. Tra la meraviglia di tutti, il Padre riuscì a portare in seminario due bravi giovani che diventeranno i primi sacerdoti di quella tribù.
La sua ulcera allo stomaco, intanto, peggiorava. Nel 1956 scrisse: “La mia salute va di male in peggio. Il mio cruccio è di non poter fare quello che vorrei”. Il Padre, però, non si risparmiava e la gente, attratta dalla sua bontà, chiedeva il battesimo.
Sorsero scuole, chiese e dispensari. Quando non ne poteva più dal dolore, si chiudeva in stanza e traduceva in karimojong il Vangelo, la Bibbia e il catechismo. “Lavoro con assiduità – scrisse – perché sento che il mio tempo sta per finire”.
Per cambiare aria andò ad Arua dove gli fu affidata la responsabilità del seminario diocesano, ma quando, nel 1959 gli arrivò la nomina a superiore di tutti i Comboniani d’Uganda, la rifiutò immediatamente: “Qui me la cavo in qualche modo, come superiore regionale farei pietà”.
Vescovo mancato
Nel 1961 dovette rientrare definitivamente in Italia. A Verona diede esempio delle sue virtù, in particolare della sua serenità e bontà. Pur tra i dolori lancinanti, teneva allegra la comunità con canti, poesie e facezie. Ebbe tutto il tempo per rivedere i suoi appunti, la sua grammatica e il vocabolario karimojong.
Nel 1963 gli fu proposto di diventare Prefetto Apostolico e poi Vescovo del Karamoja. Ma proprio allora, una violentissima emorragia interna diede il verdetto finale. Al chirurgo che lo seguiva disse. “Mi operi; anche se muoio le sarò riconoscente per tutta la vita”. Pareva morire ogni giorno, invece tirò avanti grazie al suo carattere sempre allegro e faceto. Qualche settimana prima di spirare scrisse al vescovo di Gulu, in Uganda,: “Mi dica qualche preghiera per ottenere pazienza e, possibilmente, gioia nel portare la mia croce. La mia salute è sul filo del rasoio e sto aspettando da San Pietro il “visto” sul mio passaporto”.
All’alba del 15 settembre 1966 spirò lasciando il ricordo di un vero padre nella fede per i karimojong, felice di portare la croce per la sua missione. Ha unito il lavoro alla sofferenza e alla gioia che furono le direttive sulle quali ha impostato la sua vita di appena 57 anni.
(P. Lorenzo Gaiga)
 Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.