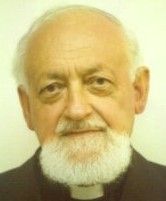Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Zanardi Giovanni Battista
I primi anni
Ultimo di 12 figli, otto maschi e 4 femmine, P. Giovanni Battista Zanardi era nato a Brembilla, Bergamo, il 26 settembre 1920. La sua era una famiglia profondamente cristiana dove la fede era vissuta e praticata senza compromessi e mezze misure. Il papà, dopo il matrimonio, acquistò una casa a Brembilla e si dedicò al commercio del carbone e della legna, che già esercitava nel suo paese d’origine. Era un lavoro duro, che lo obbligava a trascorrere giornate intere nei boschi: per non sentire la stanchezza, canticchiava i salmi che aveva imparato dal fratello sacerdote. Uomo intraprendente, onesto e capace, venne ripetutamente eletto sindaco del paese. Alla sua scuola, dove il sacrificio non faceva paura, crebbero anche i figli i quali, diventati adulti, crearono una notevole industria che poi si estenderà in altri rami del commercio.
In questa grande famiglia, dove la voglia di lavorare e l’intraprendenza erano diventate ormai caratteristiche tradizionali, Giovanni Battista cresceva vispo, intelligente e buono. Essendo il più piccolo era anche il più “coccolato” della casa. Le sorelle, soprattutto, lo circondavano di attenzioni e di premure, e ognuna voleva essere la sua maestra nell’insegnargli le preghiere e il catechismo. E quando faceva qualche marachella, trovava in loro degli avvocati difensori abilissimi di fronte ai fratelli e al papà. Giovanni Battista frequentava la chiesa e divenne un chierichetto molto zelante. A scuola, si distingueva per intelligenza e profitto.
Prete... col camion
Alla fine della quinta elementare, il suo parroco gli disse: “Senti Battista, non ti piacerebbe andare in seminario a studiare? Credo che potresti diventare un bravo sacerdote. Già da tre generazioni nella tua famiglia, c’è un sacerdote. Voi siete nove maschi: mi pare che tu saresti il più adatto a continuare una tradizione così bella”. Battista rispose: “A me piacerebbe andare in seminario, ma mi piace anche guidare il camion”. Proprio in quel periodo, infatti, il primo autocarro era entrato nell’azienda paterna. Il parroco sorrise e, facendo una carezza sulla testa del ragazzino, aggiunse: “Verrà il tempo in cui anche i preti potranno guidare i camion, non aver paura”. “Allora vado in seminario”, rispose deciso il ragazzino.
Lacrime sotto le lenzuola
Nell’autunno del 1931, Giovanni Battista, a bordo del camion dei fratelli che andava a Bergamo a portare un carico di legname, arrivò nel seminario diocesano per iniziare il ginnasio. Il saluto alla mamma, al papà, ai fratelli e alle sorelle fu particolarmente doloroso, perché Battista era molto sensibile e affettuoso, e poi nella sua famiglia tutti si volevano un gran bene. Ma il ragazzo aveva letto più volte quelle parole del Vangelo che dicono: “Chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me”. E siccome si era proposto di essere degno di Gesù, si sforzò di non piangere o, almeno, di non farsi vedere piangere, specialmente la prima sera quando nel grande dormitorio del seminario si spensero le luci e si trovò solo nel suo lettino. Sapeva, però, che quella sua sofferenza realizzava una segreta preghiera della mamma che aveva chiesto a Dio un figlio sacerdote.
La vocazione missionaria
Nel seminario di Bergamo, di tanto in tanto passavano dei missionari per parlare ai seminaristi di missioni, di Africa, di Cina. A quel tempo i seminaristi erano numerosi (solo i compagni di classe di Giovanni Battista erano più di sessanta) per cui i superiori li lasciavano partire volentieri se volevano entrare in qualche Istituto missionario o Ordine religioso.
Don Angelini, il padre spirituale del seminario, che conosceva il desiderio di Giovanni Battista di farsi missionario, gli diceva: “I Comboniani sono l’Istituto giusto per te: vanno tutti in prima linea, hanno una vita dura ma bella, perché vivono l’esperienza degli apostoli che predicavano e vedevano nascere e crescere la Chiesa. Però aspetta ancora un po’, in modo che tu possa pensarci bene e fare le tue scelte con responsabilità”. Finalmente Mons. Morstabilini, vice rettore e futuro vescovo di Brescia, lo rassicurò: “Vai a farti missionario comboniano, quella è la tua strada”.
Al termine del secondo anno di teologia, don Angelini diede il via al suo seminarista che ormai scalpitava. La mamma e le sorelle, alla notizia della partenza per il noviziato dei missionari, ebbero un po’ di esitazione, di sorpresa, ma poi lo abbracciarono e lo incoraggiarono. Nel settembre del 1942 Giovanni Battista entrò nel noviziato comboniano di Venegono Superiore, Varese, dove era maestro dei novizi P. Antonio Todesco. Fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1946 da Mons. Macchi, vescovo di Como.
Nella terra di Comboni
P. Giovanni Battista chiese ai superiori di poter partire per la missione. Fu esaudito e nel 1948 arrivò a Mboro in Sudan. Trovò i confratelli che erano lì da prima dell’inizio della guerra. Il novellino arrivò come la manna perché li sollevava da un eccesso di stanchezza accumulata in anni di isolamento, senza ricambio di personale e senza gli aiuti che dall’Italia arrivavano normalmente in missione. Subito si tuffò nello studio della lingua e poi, con la bici, percorse la missione che da una parte si estendeva per 100 chilometri e dall’altra per 70. Lavorò con entusiasmo, preparando al battesimo gruppi sempre più numerosi di ragazzi, visitò tutti i villaggi intrattenendosi con la gente, specie con gli anziani, che dimostravano di gradire la conversazione di un giovane cordiale e sempre contento, che aveva già imparato così bene la loro lingua e se ne intendeva dei loro costumi. Puntò soprattutto sulla formazione dei catechisti nei quali vedeva gli aiutanti indispensabili del missionario. Aveva una cura particolare per gli anziani, gli ammalati e, in particolare, per i malati di lebbra che nella zona erano abbastanza numerosi. Uomo attivo e intraprendente, realizzò anche alcune opere materiali, come un paio di chiese nei villaggi lontani dal centro, una delle quali finanziata dalla sua famiglia in memoria del papà, della mamma e del fratello defunti.
Tra peccatori ci si capisce meglio
Nella missione P. Giovanni Battista trovò la situazione matrimoniale di tanti cristiani piuttosto compromessa. Pur dichiarandosi saldi nella fede, facevano “scricchiolare” parecchio la morale. Molti, infatti, erano ritornati alla poligamia.
Volendo sanare quella piaga, chiamò tre ferventi cattolici che non mancavano mai alla Messa e alle preghiere, ma che non potevano accostarsi ai sacramenti perché avevano più mogli. “Sentite – disse – voi dovreste diventare gli apostoli del matrimonio cristiano, cioè con una sola moglie. Naturalmente dovreste dare l’esempio, tenendo soltanto quella legittima e sistemando le altre e i loro figli”.
I tre accettarono e cominciarono a visitare le famiglie dei loro “simili” dicendo che per il giorno stabilito ognuno avrebbe dovuto rimandare le mogli non legittime e tenere soltanto la prima. Il loro argomento era questo: “Anche noi siamo peccatori come voi, ma abbiamo deciso di tornare all’insegnamento del Vangelo”. La loro predicazione ebbe successo. In occasione di una festa, una trentina di coppie si presentarono nella chiesa centrale, accompagnati da figli, parenti e nipoti, si accostarono alla confessione e rinnovarono il loro primo matrimonio cristiano. Alla celebrazione religiosa seguì una festa alla quale parteciparono tutti.
I missionari delle altre missioni, che si trovavano ad avere situazioni analoghe, pensavano che sarebbe stato un fuoco di paglia, invece la conversione durò nel tempo. E quando chiedevano a P. Giovanni Battista come avesse fatto per ottenere un simile miracolo, rispondeva: “La grazia di Dio e i missionari adatti: tra peccatori ci si capisce meglio”.
Tra gli arabi di Raga
Dopo cinque anni di ministero missionario a Mboro, Mons. Edoardo Mason, vescovo di Wau, lo mandò a Khartoum, per sei mesi, a studiare l’arabo, per mandarlo nella missione di Raga.
Così nel 1954, fu mandato nella missione di Raga, a maggioranza araba, in un clima piuttosto ostile ai cattolici per cui bisognava muoversi con circospezione. Inoltre, nel 1956 il Sudan aveva acquistato l’indipendenza dall’Inghilterra e portava avanti la sua politica ispirata al Corano. Per la Chiesa cattolica era già iniziata la persecuzione da parte del governo musulmano, che tante sofferenze procurò ai cristiani e che ebbe il suo culmine nell’espulsione in massa di tutti i missionari dal Sudan meridionale.
Come testimonianza di carità, che doveva essere la caratteristica dei cattolici, P. Giovanni Battista, incoraggiato da Mons. Mason, costruì una maternità aperta a tutti, musulmani compresi. Anzi le donne musulmane erano le frequentatrici più abituali. Un giorno il mudir, cioè il governatore locale, un musulmano che dava parecchio filo da torcere ai missionari, mandò due soldati alla missione chiedendo della suora infermiera, perché una delle sue mogli stava per partorire ed era in difficoltà. P. Giovanni Battista, terminata la Messa, disse alla suora ostetrica diplomata di andare con i soldati. Tutto andò per il meglio, sia per la mamma che per il bambino, e da quel giorno il mudir si mostrò più benevolo con la missione.
Intanto, l’ulcera che tormentava i giorni e le notti di P. Giovanni Battista si era acutizzata ed erano già passati dieci anni di missione, per cui non era un “delitto” chiedere di rimpatriare per un po’ di vacanza e di riposo.
In Italia
Ritornò in Italia dove poté curare l’ulcera senza bisogno d’intervento chirurgico e fu inviato ad Asti come superiore del seminario minore comboniano. Dopo Asti, fu la volta di Thiene. C’era da costruire la casa per le vacanze di Asiago. Mentre un’impresa portava avanti i lavori aiutata da alcuni fratelli comboniani, P. Giovanni Battista si lanciò in giro per l’Italia a cercare e predicare Giornate missionarie. Fu poi mandato a Brescia dove svolse anche la mansione di economo provinciale.
Da una destinazione all’altra
Nel 1962 P. Giovanni Battista, libero ormai dagli “affari” in Italia, fu inviato nuovamente in missione, con destinazione Uganda, nelle missioni di Aliwang e Alanyi (diocesi di Lira). Nel 1966 fu mandato a Kampala e l’anno dopo rientrò in Italia, a Roma, come procuratore delle missioni, un lavoro che lo mise in contatto con tanti vescovi delle diocesi in cui lavoravano i Comboniani e con i confratelli di tutto il mondo. Rimase in Italia sette anni, risiedendo a Milano ma soprattutto ad Asti.
Nel 1974 fu mandato di nuovo in Uganda, a Kampala, ancora per curare l’amministrazione. Vi rimase solo un anno perché c’era bisogno di lui in Kenya presso la Congregazione degli Apostoli di Gesù, in fase di espansione, e si doveva costruire il seminario. P. Giovanni Marengoni, infatti, aveva bisogno di un amministratore capace e P. Giovanni Battista si disimpegnò benissimo: dal 1975 al 1977, fu un amministratore fedele e saggio.
Nel 1977 fu richiamato a Roma – dove rimase fino al 1986 – nel suo vecchio incarico di procuratore, essendo partito per la missione P. Antonio Rizzato, che lo aveva sostituito. Nel 1986 fu dirottato in Inghilterra, ancora una volta come amministratore della provincia. Dopo quattro anni a Londra e un periodo a Roma in cui fece l’anno sabbatico e si occupò dei confratelli studenti, nel 1992 era di nuovo a Brescia, come economo e animatore missionario. Nel 1995 tornò in Kenya – per due anni – come amministratore per il Sud Sudan. Nel 1997 fu nuovamente assegnato a Brescia.
Ancora in Kenya per il Sud Sudan
Era appena stato nominato vice superiore a Brescia, quando dovette ripartire per Nairobi, per cercare ancora una volta di rimettere in sesto le finanze del Sud Sudan, che si trovava in una costante situazione di bancarotta.
In un’intervista del 1999, spiegava perché amministrava la diocesi di Rumbek (Sudan meridionale), della quale era vescovo Mons. Cesare Mazzolari. “La diocesi di Rumbek è di 58.000 chilometri quadrati (un quinto dell’Italia) con due milioni di persone che non hanno il minimo indispensabile per vivere. I morti per fame sono moltissimi perché gli uomini sono costretti, dico costretti, sotto pena di essere uccisi, ad andare in guerra. I raccolti prodotti dalle donne vengono sistematicamente bruciati dai soldati del Nord, anche i villaggi vengono incendiati e la gente è sempre in fuga. Oltre alla fame, ci sono anche le malattie, i bombardamenti da parte degli aerei militari governativi, le mine. La gente accorre alla Chiesa che rappresenta l’unica ancora di salvezza nella presente emergenza. Mons. Mazzolari non ha l’episcopio, non ha la cattedrale, perché tutto è stato bombardato. Vive in una capanna, così come può. Quella è la sua Curia e il suo episcopio. Un po’ alla volta gli costruiremo una casetta. Il personale della diocesi è ridotto al suo vicario generale, un sacerdote sudanese e al suo amministratore, il sottoscritto. I preti, tra africani ed europei, sono una dozzina per una diocesi grande come il Piemonte, la Lombardia e la Venezia Giulia. Io posso portare avanti il mio lavoro da Nairobi, in Kenya, perché a Rumbek non c’è neppure la luce elettrica, non ci sono banche, né uffici, né distributori di benzina”. Rimase in Kenya quattro anni.
Gli ultimi anni
Rientrato definitivamente in Italia nel 2003, fu mandato a Brescia per ministero e vi rimase cinque anni. Nel 2010 passò in cura a Milano, dove è morto il 18 marzo 2013. I funerali si sono svolti il 20 marzo nel suo paese natale – dove è stato sepolto – e sono stati presieduti da Mons. Lorenzo Ceresoli, vicario apostolico emerito di Awasa, che ha ricordato l’intensa vita di P. Giovanni Battista.
Da Mccj Bulletin n. 258 suppl. In Memoriam, gennaio 2014, pp. 47-53.