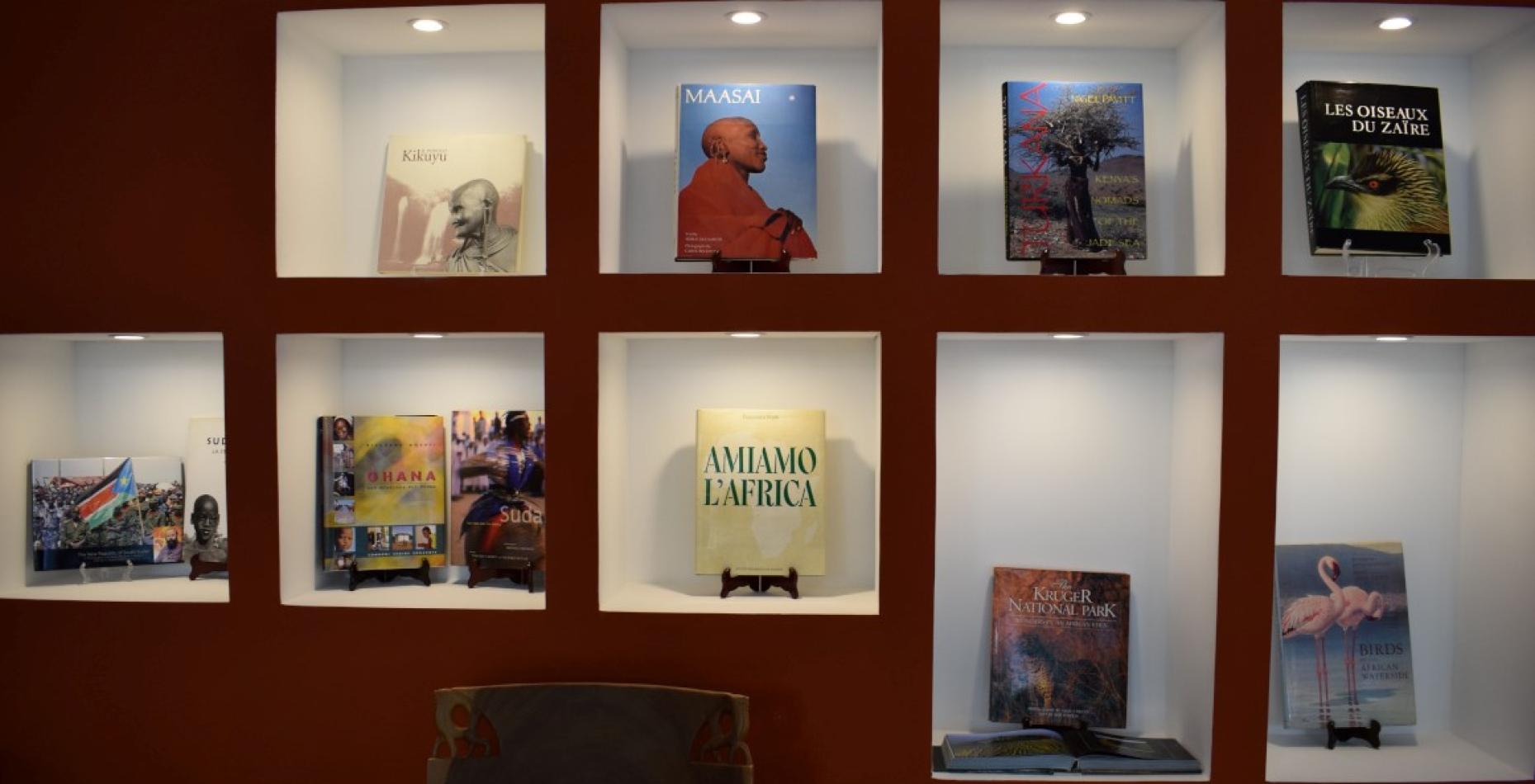L’Africa costituisce circa il 18 per cento della popolazione mondiale, quota che si prevede salirà al 25 per cento entro il 2050. Inoltre, l’età media della popolazione nella macroregione subsahariana è di circa vent’anni. Stiamo parlando di un continente che possiede il 30 per cento delle risorse minerarie mondiali e il 60 per cento delle terre coltivabili inutilizzate a livello planetario.

Pur essendo oggetto di un progressivo interesse da parte di vari player internazionali, l’Africa ha un Pil complessivo di appena circa 3 trilioni di dollari,una cifra di gran lunga inferiore rispetto a quelle che sono le reali potenzialità del continente. Per avere un confronto, basti pensare che la ricchezza prodotta dall’Unione europea (Ue) è di 16 trilioni e mezzo. Oltretutto il 50 per cento del Pil africano riguarda solo 5 Paesi: Nigeria, Egitto, Sud Africa, Algeria e Marocco. Come scritto ripetutamente su questo giornale, gli investitori stranieri rivolgono solitamente la loro attenzione al cosiddetto settore primario, quello delle commodity, con particolare riguardo all’estrazione ed esportazione di materie prime minerarie e fonti energetiche, nonché alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali. Le sfide derivanti dalla continua fluttuazione dei prezzi delle materie prime e dal limitato valore aggiunto del continente alle sue risorse naturali rendono comunque l’Africa subsahariana vulnerabile agli stress esterni derivanti dalla dipendenza dalle esportazioni. Recentemente, gli investimenti stranieri si sono estesi anche alle energie rinnovabili, alla green economy , ma anche al manifatturiero e ai servizi, ma il cammino, inutile nasconderselo, è ancora lungo.
Il comparto industriale è ancora molto debole e condizionato in alcuni casi da inefficienze e shock esterni, esacerbati da politiche a volte inadeguate, corruzione e dall’azione invasiva potentati predatori stranieri più o meno occulti. Da questo punto di vista, è fondamentale l’implementazione dell’African Continental Free Trade Area (AfCFTA), vale a dire l’Area continentale africana di libero scambio all’interno della quale si potranno trasferire beni e servizi tra gli Stati membri dell’Unione africana senza restrizioni di sorta. L’AfCFTA mira a stimolare il commercio intra-africano fornendo un accordo globale, reciprocamente vantaggioso tra gli Stati membri, che copra il commercio di beni e servizi, gli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e la politica di concorrenza.
Secondo la Bank for International Settlements (Bis) di Basilea il debito estero africano ha già superato il 30 per cento del Pil. Si tratta di una cifra rilevante, pari a circa 1.140 miliardi di dollari, se rapportata al valore assoluto della ricchezza generata a livello continentale. Basti pensare che il Pil africano equivale pressappoco a quello francese, motivo per cui pur essendo il debito inferiore al Pil — come noto, in Italia per esempio è nettamente superiore — non è in grado di rassicurare i creditori. Inoltre nell’attuale congiuntura, con la speculazione sui mercati finanziari internazionali, i prezzi dei beni al consumo hanno subito una drastica impennata. Sta di fatto che dopo i default del Ghana, dello Zambia e dell’Etiopia, sono 9 le economie nazionali in grande sofferenza, 15 ad alto rischio e altri 14 a rischio moderato. Lo scorso anno l’inflazione media nell’Africa subsahariana è stata del 18 per cento e la svalutazione delle monete locali del 20 per cento rispetto al dollaro. I tassi d’interesse alti e un dollaro forte penalizzano fortemente le economie nazionali.
Al riguardo gli analisti ritengono che lo sviluppo del continente africano debba passare attraverso l’apporto del credito internazionale, nonché di un’ampia politica di ristrutturazione dei debiti sovrani di interi Paesi. Si tratta di temi importanti che non possono prescindere dalla cosiddetta economia sommersa. Ogni anno quasi 90 miliardi di dollari, equivalenti a poco meno del 4 per cento del Pil africano, vengono trafugati sotto forma di flussi finanziari illeciti (Iff), vale a dire movimenti illegali di denaro e beni attraverso le frontiere che risultano, alla prova dei fatti, illegali nella fonte, nel trasferimento o nell’uso del denaro. Se a tutto ciò aggiungiamo i devastanti effetti del global warming, il continente rischia la marginalizzazione.
Per quanto concerne i processi di stabilizzazione politico-istituzionale di cui l’Unione africana si è fatta garante, le difficoltà non mancano: dal Sahel al Corno d’Africa passando per la Regione dei Grandi Laghi. Essi sono ancora caratterizzati da discontinuità e non sempre guidati da modelli democratici. Per quanto vi siano Paesi che garantiscono una progressiva diminuzione del rischio politico, le aree di aperta conflittualità sono ancora molte (Somalia, Sudan, Nord del Mozambico…).
Nel contesto geopolitico l’Africa nel suo complesso è sempre più espressione del Global South, sperando di guadagnare spazi di iniziativa e influenza sul palcoscenico internazionale. Ma è ormai evidente che i principali decisori politici africani guardano ad oriente più che ad occidente. Il carattere fortemente competitivo tra gli attori internazionali, impresso dalle crisi che interessano l’Europa orientale, il Medio Oriente, unitamente alle turbolenze sullo stretto di Taiwan, sta disegnando nuove traiettorie geopolitiche.
In particolare, la gerarchia emergente, quella dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), con l’ingresso al proprio interno di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Egitto e Etiopia, tende ad espandere la propria area d’influenza. La conseguente modificazione del tradizionale tessuto multilaterale rispetto agli equilibri del passato influenzerà comunque sempre più il futuro dell’Africa. Non è infatti da sottovalutare che oltre a Sud Africa, Etiopia e Egitto, vi siano altri Paesi africani che vorrebbero entrare nei Brics: ad esempio la Nigeria, il Senegal, l’Algeria, la Repubblica Democratica del Congo ed altri.
Com’è noto, l’Unione europea ha lanciato il proprio piano strategico d’investimenti, il Global Gateway, di cui la metà, pari a circa 150 miliardi di euro, è stata destinata al continente africano; mentre gli Stati Uniti, a seguito del “US-Africa Leadership Summit” dello scorso anno, si sono impegnati a investire 55 miliardi di dollari in Africa per il triennio 2023-25.
Ma non v’è dubbio che sia ormai la Cina a fare la parte del leone. Da ormai diversi anni principale partner commerciale del continente africano, sta sempre più implementando la carta della Belt and Road Initiative (Bri). In questo contesto, i Paesi africani sono quelli che hanno attirato i maggiori investimenti cinesi lo scorso anno e con un totale di 21,7 miliardi di dollari, hanno superato l’area mediorientale. Da rilevare che negli ultimi due decenni le società cinesi hanno effettuato oltre 150 miliardi di dollari di investimenti.
Naturalmente ci sono altri attori internazionali che stanno venendo alla ribalta in Africa, come la Russia i cui investimenti però, rappresentano meno dell’1 per cento di quelli diretti esteri nel continente. Mosca comunque coltiva un forte interesse per lo sfruttamento delle commodity africane e sta cooperando militarmente con alcuni governi. A ciò occorre aggiungere il tema d’interesse globale legato alla sicurezza marittima (vedi Corno d’Africa) e di contrasto alla minaccia jihadista, veri filrouge dell’interesse occidentale nello scacchiere africano. Ma è proprio su questo versante, fortemente dialettico tra oriente e occidente, che si gioca la partita del futuro in Africa, evitando di assecondare la polarizzazione di un confronto che produrrebbe solo disastri. Pertanto celebrare la Giornata mondiale dell’Africa troverebbe significato autentico solo nel volere davvero la pace e perseguirla con il cuore e con la mente.
Giulio Albanese – L’Osservatore Romano
 Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.