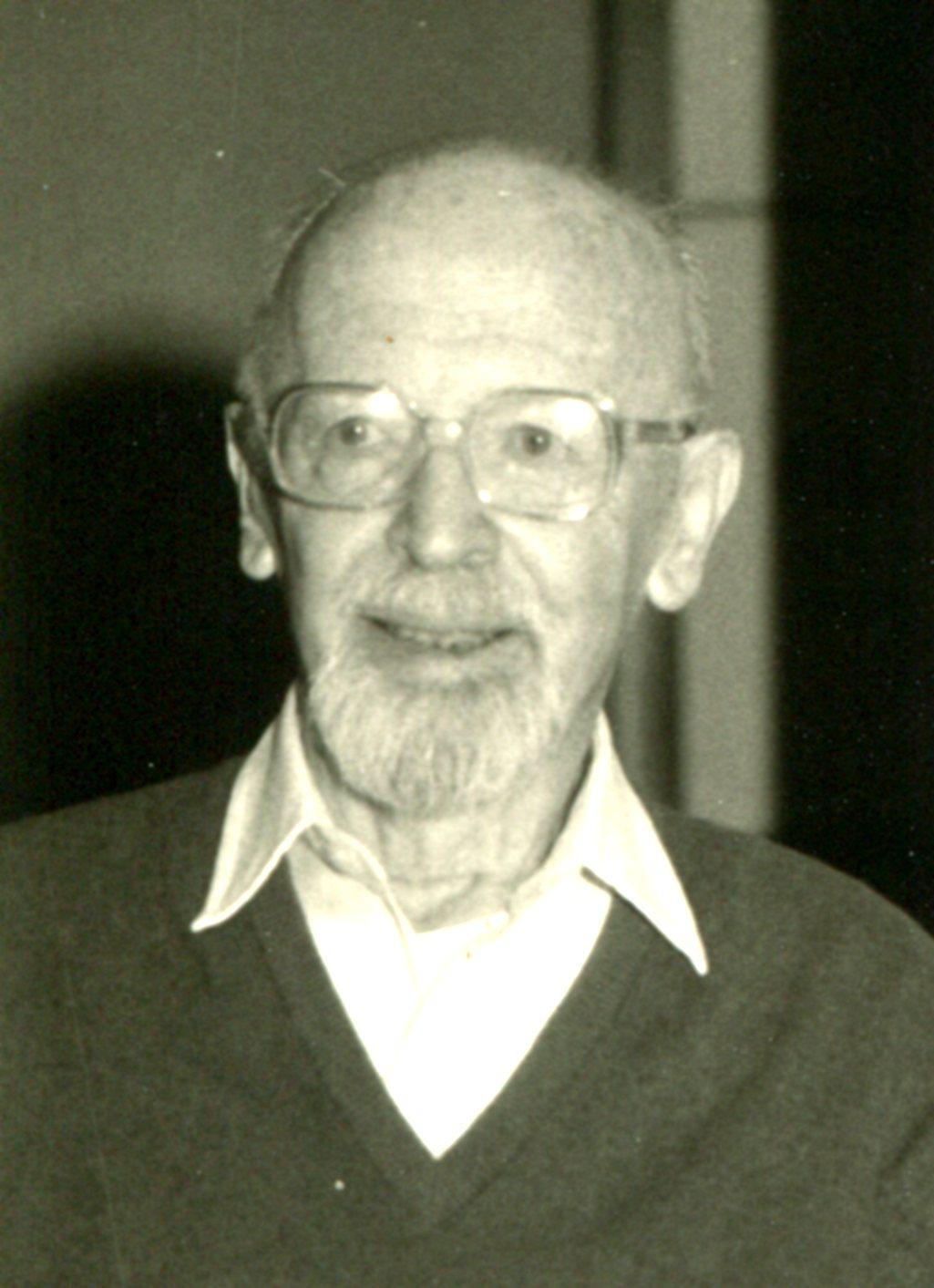Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Marigo Zelindo
Mi auguro di vedere presto pubblicato il Diario della Campagna di Russia scritto da padre Marigo. è un lavoro al quale ha dedicato l'ultimo periodo della sua vita a Verona e che ha fatto mettere in buona lingua da una esperta, dato che il suo italiano risentiva ormai di qualche "spagnolismo". Il Diario, che è stato redatto su note dell'epoca, è, in un certo qual modo, un inno alla carità e alla Provvidenza. Inoltre mostra la nobiltà d'animo del popolo russo nei confronti dei soldati italiani, in ritirata tra nevi, bufere e ghiacci. Quest'opera dà anche la statura umana e spirituale di padre Marigo, anche se è scritta con estrema modestia e semplicità.
Chierichetto del Duomo
Ottobre 1921. A quell'epoca non esisteva la Giornata Missionaria Mondiale (fondata nel 1926), ma i Comboniani erano soliti battere città e paesi per dire ai cristiani che, per aiutare le missioni, occorrevano soldi, preghiere e, soprattutto, buone vocazioni.
Nell'ottobre del 1921, dunque, padre Angelo Abbà andò a Piove di Sacco a predicare. Durante la messa dei ragazzi – ce n'erano più di 900 in chiesa – parlò della bellezza della vocazione missionaria e, alla fine, fece un caloroso appello.
"Ragazzi – disse – come vedete, io sono vecchio e, alla fine di quest'anno, ritornerò ancora in Africa. Non so per quanti anni, perché non posso durare molto... Attenzione! Chi di voi prenderà il mio posto? Alzino la mano i coraggiosi che mi sostituiranno". Solamente tre alzarono il braccio. E fra questi anche Zelindo Marigo, il più piccolo.
Il giorno dopo, il ragazzino si presentò al parroco per manifestargli il suo proposito e per diventare chierichetto del Duomo.
"Bene – gli disse monsignore – faremo di te un buon sacerdote padovano".
L'anno seguente Zelindo entrava nel seminario vescovile di Padova. Non ebbe difficoltà ad essere accettato ma, appena cominciò l'anno scolastico, si ammalò a tal punto da dover rientrare in famiglia. Pianse, pregò la Madonna e sant'Antonio, e si nutrì con i buoni brodini che la mamma gli preparava. Alla fine poté rientrare in seminario e terminare l'anno scolastico regolarmente.
In autunno, durante le vacanze, un compagno salesiano gli parlò delle missioni che lo aspettavano in America, e abbonò Zelindo alla rivista di padre Coiazzi, "Le letture cattoliche". Terminata la quinta ginnasio, Marigo sentiva il desiderio di farsi salesiano per andare in missione. Ne parlò con il padre spirituale il quale, con decisione, gli rispose:
"Che sogno è mai questo! Pensa ad essere un buon sacerdote nella nostra diocesi. Comincia il liceo e, se avrai vera vocazione, andrai nel Mato Grosso, dato che matto già ci sei!" – e sorrise.
Benedicimi almeno tu, mamma
Alla fine della prima liceo, Zelindo tenne un affettuoso colloquio con sua madre, durante il quale le confidò il suo piano concludendo:
"Il Signore mi chiama alle missioni. Non posso dirgli di no. Sarei un infelice per tutta la vita".
"Qui in diocesi?" – chiese con voce tremante la mamma.
"No! In America o in Africa".
"Vorresti dire che mi lasci per sempre e non potrò più vederti su questa terra?" Zelindo si mise in ginocchio e cominciò a supplicarla con le lacrime agli occhi dicendole che tutti dobbiamo fare la volontà di Dio. Alla fine aggiunse:
"Benedicimi almeno tu, mamma, e siimi alleata nella mia scelta, dato che troverò opposizioni da parte del papà e degli altri".
"Non mi oppongo alla volontà di Dio. Solo che avevo sempre sognato di passare la mia vecchiaia con te per amare più da vicino il Signore. Ora tutto è svanito. Un giorno, triste quel giorno, dovrò morire sola, senza la tua benedizione. Intanto, però, ti do la mia".
Il papà e i fratelli gli fecero un'opposizione tremenda. Non volevano rassegnarsi a "perderlo" lasciandolo andare così lontano e in mezzo a tanti pericoli. Ma alla fine lo benedissero.
Desiderio di martirio
Il 25 luglio 1929 il seminarista Zelindo Marigo si rivolgeva ai superiori dei missionari comboniani con una lettera che mette in evidenza la sua scelta per le missioni dell'Africa.
«Le missioni - scrive - sempre mi affascinarono: da bambino mi commossero, da ragazzo mi entusiasmarono e ora che sono giovane mi attraggono tanto da non poter resistere. Sono già passati cinque anni da che udii i primi inviti a correre a redimere gli infedeli. Facevo la quarta ginnasio e non sapevo ancora decidermi. Terminata la quinta, avevo tutto stabilito per entrare in un altro Istituto missionario, quando il padre spirituale mi obbligò ad attendere maggior maturità. Andai avanti deciso ormai di non più pensare alle missioni, pronto a scacciare questo pensiero come una tentazione. Ma ecco che, nel giorno dell'Epifania del 1927, la voce cominciò a farsi udire per non più smettere. Da principio resistei, ma poco dopo mi diedi per vinto perché troppo manifesta conobbi la chiamata divina.
Ed ecco ora che, giovane di 20 anni, già ammesso al primo corso di teologia, non potendo più resistere alla chiamata celeste, umilmente prostrato a sua paternità, le presento l'istanza per poter entrare fra i suoi figli, fra quella schiera eletta, scelta dal divin Cuore di Gesù per redimere quelle popolazioni da tutti abbandonate.
Non può immaginare come ora, giorno e notte, ringrazi Dio per tanta grazia ricevuta. Ma nello stesso tempo ho un continuo motivo di umiliarmi: chi sono io da essere scelto a tanto? Ma se impotente mi veggo a tutto per la mia gran miseria, pure tutto spero con l'aiuto di quel Cuore di cui diverrò figlio.
Già da tre anni offro continuamente la mia esistenza, i miei dolori, le mie gioie e le mie azioni per la redenzione degli infedeli. Ella, padre reverendissimo, non voglia non accettare questo povero giovane, pronto a qualsiasi sacrificio anche per salvare una sola anima, e pronto anche, Dio lo voglia, al martirio da tanti anni vagheggiato.
Ottenuto il permesso dai superiori del seminario e da sua Ecc. Mons. Vescovo, ottenuto pure il consenso dalla famiglia, ora mi manca soltanto la sua parola di accettazione...".
Pochi giorni dopo, scrivendo dalla famiglia, poiché era in vacanza, parla dei documenti che ha spediti e delle regole dell'Istituto che ha ricevuto, poi prosegue:
"E fino a quando dovrò aspettare il suo invito per entrare tra i suoi figli? Quanto sono stanco di rimanere a casa! Nei giorni passati ho letto il regolamento che gentilmente ella mi ha mandato. Come è bello! Una frase mi colpì in modo particolare. “I giovani, ad una sana costituzione fisica, devono aggiungere una condotta esemplare ed una pietà soda, congiunta col proposito di farsi santi”. Sì, proprio questo, da tanti anni, io cerco, perché ne sento urgente il bisogno. Mi vedo povero, piccolo, un niente, incapace di tutto, pieno di difetti, eppure ho il pensiero fisso di diventare santo. La mia preghiera in tutta la mia vita di seminario fu sempre questa: “O santo sacerdote o la morte”. Ed ora: “O santo missionario o la morte”. Il Sacro Cuore esaudirà il mio voto?»
Solo missionario d'acqua dolce?
Il 12 settembre di quel 1929 Marigo poté finalmente entrare in noviziato a Venegono Superiore. Il suo impegno nell'acquisto delle virtù religiose e missionarie fu pari al desiderio che lo animava per andare il più presto possibile in missione.
A quel tempo era maestro dei novizi padre Bombieri, un tipo piuttosto severo. Zelindo fece un po’ di fatica ad abituarsi al suo metodo di formazione. Più di una volta si nascondeva a piangere pensando all’affetto della famiglia in contrasto con il sistema della nuova vita. Nei giorni amari andava dal padre maestro ad esternargli la sua pena. Questi si sforzava di consolarlo come poteva.
Nel frattempo i famigliari, pur approvando la sua vocazione, pregavano perché ritornasse nel seminario diocesano di Padova. Egli, tuttavia, sostenuto dall'amore alla missione, trovò la forza di superare ogni difficoltà e sacrificio. In questa lotta gli fu di aiuto la lettura e la meditazione della vita di Mons. Comboni.
Ma una tribolazione ancor più grave era alle porte. Verso la fine del secondo anno di noviziato, il padre maestro lo chiamò e gli disse:
«La settimana scorsa ti mandai per una visita medica. Mi dispiace molto, ma il verdetto del dottore su di te è assai chiaro: “Giovane molto debole e gracile di costituzione; non adatto ai climi dell'Africa e ai duri sacrifici della vita missionaria"». Marigo si sentì venir meno e cercò di reagire intensificando le preghiere al Sacro Cuore.
Alcuni giorni dopo il padre maestro lo chiamò di nuovo e gli chiese se avesse scritto alla famiglia per un eventuale rientro nel seminario di Padova. Con le lacrime agli occhi il novizio rispose:
«No!» Dopo un lungo silenzio padre Bombieri riprese:
«Ti ammetto ai Voti solo se sei disposto a servire la Congregazione in Italia. Abbiamo bisogno anche in patria di missionari».
«Ciò sarebbe a dire che io devo rassegnarmi ad essere missionario di acqua dolce», rispose Zelindo. Seguì un dialogo come tra padre e figlio al termine del quale il novizio dichiarò la sua disponibilità a restare in Italia. Poi aggiunse:
«E se un giorno mi facessi più forte e robusto, potrei lavorare in Africa?»
«Te lo auguro», fu la risposta.
Il 7 ottobre 1931, Marigo poté consacrarsi al Signore e alla missione con i tre Voti di povertà, castità e obbedienza.
Tra le paludi di Tonga
Completata la teologia a Verona, padre Marigo venne ordinato sacerdote il 31 marzo 1934. Nello stesso anno questo "pesce d'acqua dolce" fu inviato a Mboro, nel Sudan meridionale. Al momento dell'addio un cugino gli disse:
«Se tu fossi mio figlio, preferirei vederti morto... Non è una cosa umana ciò che fai!» Al che Marigo rispose:
«Hai ragione, perché ciò che faccio è una cosa divina».
Dopo due anni trascorsi a Mboro, passò a Tonga dove fu superiore dal 1936 al 1939. Di tanto in tanto faceva delle capatine anche a Lul.
Ogni comboniano conosce, o dovrebbe conoscere, queste prime missioni che furono croce e gloria per tanti nostri confratelli. Padre Beduschi, fratel Giosuè Dei Cas, padre Arpe (solo per citare qualcuno di cui è stato detto qualcosa) hanno scritto pagine eroiche in queste zone spesso invase dalle piene del Nilo, abitate da genti ostili al Vangelo, isolate da ciò che noi chiamiamo comunemente mondo civile, infestate da ogni tipo di insetti e di animali, con un clima impossibile e dalla tomba facile.
Qui padre Marigo lavorò molto bene. Uomo di intelligenza spiccata, cominciò a osservare gli usi e i costumi degli abitanti della zona. "La Nigrizia" degli anni 1938-39 porta una dozzina di begli articoli sulla tribù Scilluk, tutti improntati a simpatia per quel popolo che era diventato il suo popolo. Continuerà a scrivere, e non solo articoli (ci sono infatti anche alcune biografie), per le nostre riviste e in vista dell'animazione missionaria.
Padre Marigo, traducendo opere di illustri etnologi, contribuì a far conoscere la gente, la flora e la fauna di quella parte dell'Africa. Grazie ai suoi servizi contribuì all'incremento degli abbonamenti a "La Nigrizia".
Padre Bombieri non aveva avuto tutti i torti quando aveva preventivato per padre Marigo una "missione" tutta italiana. Infatti il Padre si ammalò di febbre nera in maniera così grave da essere giudicato definitivamente spacciato, tanto che i confratelli gli prepararono la cassa da morto. Miracolosamente si riprese e poté ritornare in Italia a rimettersi completamente.
Giornalista e cappellano
La prova che aveva dato come scrittore dalla penna facile e dallo stile scorrevole, convinse i superiori ad assegnargli l'incarico di redigere, a Verona, i periodici "La Nigrizia" e "Il Piccolo Missionario" (allora si chiamavano così). Diede una mano anche agli scolastici per curare "Combonianum" che a quel tempo vedeva la luce.
Si dedicò alla traduzione di articoli di qualche studioso ed etnologo per far conoscere ai lettori gli usi, i costumi, la flora e la fauna dell'Africa centrale. Questi servizi contribuirono a far aumentare notevolmente il numero degli abbonati alle nostre riviste. Scrisse anche qualche biografia che diede un buon contributo all'animazione missionaria. Sarà fedele a questo suo carisma, anche se in maniera saltuaria, fino agli ultimi anni della sua vita.
Lavorò ai nostri periodici fino al 1941, anno della sua nomina a cappellano militare dei soldati italiani in partenza per la Russia. Nel 1940, infatti, l'Italia era entrata in guerra a fianco della Germania e del Giappone contro l'Inghilterra, la Francia, la Russia e gli Stati Uniti.
In Russia padre Marigo meritò la medaglia di bronzo per la sua dedizione eroica in favore dei soldati. Durante la ritirata di più di mille chilometri, a piedi, tra bufere di neve e ghiaccio, portò in spalla i feriti e i congelati, incoraggiò chi si disperava, assolse i morenti e raccolse dalle loro labbra le ultime parole che poi porterà ai famigliari in Italia. Perché avessero da mangiare elemosinò il cibo presso le famiglie dei russi che incontrava sulla strada. Per i suoi soldati fu non solo il sacerdote, ma il padre, l'amico, il medico, il consolatore. Egli stesso ebbe un principio di congelamento al piede che sarà, poi, la causa ultima della sua morte. Rischiò anche la vita. Caduto sotto un bombardamento nemico, fu dichiarato morto dal comando militare. I confratelli gli celebrarono le tre messe allora di regola per ogni defunto.
Rientrato in Italia con i resti del 108 Artiglieria, Divisione Cosseria, venne dirottato a Cinisello Balsamo, vicino a Milano. L'8 settembre 1943 i tedeschi disarmarono i soldati italiani e li invitarono a far parte del costituendo esercito fascista della Repubblica Sociale di Salò. Quei poveri ragazzi, stremati e stanchi di guerra, si rifiutarono. Allora furono intruppati per essere internati in un campo di prigionia in Germania.
Alla stazione ferroviaria, muti e avviliti, salivano sul carro bestiame. Quando l'ufficiale tedesco, che leggeva i nomi da un lungo elenco, giunse a padre Marigo, alzò gli occhi e disse:
«Lei no! Lei è libero e può tornare a casa». Forse quell'ufficiale era un cattolico e, sapendo che fine avrebbero fatto quei ragazzi, voleva risparmiare la vita a un sacerdote, oppure voleva evitare a un graduato una simile umiliazione... Il Padre ebbe un sussulto di gioia, ma quando vide i volti dei soldati che, dallo sportellone del carro, lo guardavano in lacrime, disse:
«Mi lasci andare con loro. Sono il loro pastore». L'ufficiale lo guardò sbalordito, poi, accompagnando le parole con un gesto della mano, soggiunse:
«Vada pure. La capisco». E gli fece un cenno di saluto.
Il parroco di Balsamo, don Piero Carcano, che era presente alla scena, raccontò l'episodio ai superiori di Verona. Al termine della lettera disse: «Il suo fu un atto di eroismo che ha lasciato un'impressione favorevolissima presso la popolazione civile».
In Germania padre Marigo, essendo cappellano e graduato, poteva recarsi presso le famiglie e la Croce Rossa a questuare cibo e medicine per i suoi soldati, proprio come aveva fatto durante la ritirata di Russia. Alle volte fu preso a pugni da qualche tedesco. Un giorno un fanatico nazista, irritato perché il Padre portava la medaglia della Madonna al collo, lo ferì con la baionetta e gli sparò un colpo che, fortunatamente, non andò a segno.
Dopo questa durissima esperienza, al termine del conflitto, il Padre riuscì a rimpatriare con un buon gruppo dei suoi.
In America con entusiasmo
Dal 1946 al 1948 padre Marigo fu negli Stati Uniti, a Cincinnati, come vice parroco. Il 19 settembre di quel 1948 ricevette l'ordine di unirsi al primo gruppo di Comboniani che erano da poco partiti per la Bassa California. Padre Sassella lo accolse a braccia aperte e gli affidò la cura delle anime di La Paz. Non era parroco, ma la gente lo chiamava con questo nome perché Sassella gli aveva lasciato mano libera in tutto. In qualche mese imparò molto bene lo spagnolo e poté gettarsi in un'attività che ha del prodigioso e che cercheremo di seguire a grandi linee con l'aiuto di padre Mario Menghini.
La Paz a quell'epoca aveva 15.000 abitanti. Una buona percentuale erano poveri. I ragazzi praticamente abbandonati a se stessi non si contavano. Il 12 dicembre, appena tre mesi dopo il suo arrivo, padre Marigo organizzò il Natale del povero. Con un carro a due ruote trainato da un asino, visitò le botteghe dei commercianti chiedendo aiuti per i poveri. Poi, vestito da babbo natale, cominciò a distribuire quei doni ai poveri. Fu un successo travolgente. Finalmente c’era un prete moderno e pieno di buone idee per aiutare la gente. Dal governatore all'ultimo della città ci fu un’ondata di simpatia per padre Zelindo e per i missionari.
Nel 1949, sull'onda della sua popolarità, fondò un giornale cattolico intitolato adelante, quattro pagine con periodicità quindicinale che diventerà poi settimanale. Contemporaneamente dava inizio al movimento Azione Cattolica Gioventù Messicana.
Due comboniani, intanto, erano finiti in prigione (anche se per breve tempo) in quanto si erano fatti vedere in giro con la veste talare. Come si sa, le leggi messicane riflettevano (e riflettono ancora) le prescrizioni persecutorie di Calles.
Marigo, invece, riuscì a organizzare una solenne processione con la Madonna di Guadalupe, durante la quale egli, con i paramenti sacri indosso, sfilò per le vie della città. E nessuno gli torse un capello. Fu una cosa inaudita.
Il 25 marzo 1950, festa della Madonna, sul suo giornale apparve un articolo contro la Massoneria. In città i massoni pullulavano ed occupavano tutti i posti di rilievo. Fu una sfida. Ma come se ciò non bastasse, rifiutò a un massone di fare il padrino in una cerimonia di battesimo. Era troppo. Il giorno dopo qualcuno lo attese all'uscita di casa e tentò di ucciderlo. Le autorità, venute a conoscenza della cosa, tacitarono tutto. Chi avrebbe osato mettere le mani su un uomo popolare come padre Marigo? Il Padre dichiarò in privato il suo pieno perdono nei confronti dell'aggressore e andò a trovarlo quando questi, poco dopo, si ammalò.
Il 16 aprile, mise in piedi l'Associazione Aspiranti di Azione Cattolica. Come gita premio li portò a Todos Santos, 80 chilometri da La Paz.
Due fratelli sacerdoti avevano iniziato un grande santuario che era appena fuori dalle fondamenta. All'arrivo dei Comboniani se n'erano andati abbandonando l'opera. Padre Marigo lo portò a termine. Toccherà a Padre Toncini mettergli il tetto. Sempre nel 1950 diede vita al gruppo "Vanguardias Guadalupanos", giovani cristianamente impegnati che non si vergognavano di professare pubblicamente la loro fede.
Il 16 luglio fu la volta dei Boys Scouts. Tra essi si ritrovarono i ragazzi non cattolici (e anche cattolici), principalmente figli di ebrei. Per festeggiare l'avvenimento, li portò in gita a Todos Santos, come aveva fatto con gli aspiranti.
Al ritorno da quella gita disse ai confratelli che dichiarava fondata la villa de los muchacos, che per il momento era costituita da alcune tende piantate nei quattro ettari di terra che si era fatto assegnare dal governo nell'area del santuario. Tra le tende c'era la piscina e una scuoletta, nella quale un professore governativo andava a insegnare alla ventina di ragazzi abbandonati che il Padre aveva messi insieme.
15 agosto: "I paggetti della Madonna di Guadalupe" erano una realtà. Bambini dai 7 ai 9 anni con sgargianti divise, preparate dalle dame, ornavano l'altare durante le solenni celebrazioni e facevano bella mostra di sé nelle processioni... Le invenzioni in quel 1950 non erano ancora finite.
Il 10 ottobre (notare la data che sottolinea la combonianità del Padre) prese vita l’academia, una scuola commerciale dove professori governativi insegnavano ai ragazzi a leggere e a scrivere, e venivano impartite lezioni di lingua estera (Marigo si prestò per l'inglese), e buone maniere.
Parroco
Il 28 ottobre 1951 padre Marigo venne nominato parroco di La Paz. Padre Sassella, da Città di Messico, era riuscito a far restituire alla "Missione Culturale Italiana" (non alla Chiesa, ma è questione di nomi) i beni che Calles aveva sottratti durante la persecuzione. Marigo ne approfittò per fondare il "collegio parrocchiale" che venne inaugurato l'8 novembre 1951 con 47 alunni.
Quasi contemporaneamente aprì la scuola di "arti e mestieri" con annessa falegnameria diretta da fratel Arsenio Ferrari. Quindici ragazzi presero subito posto. Nel gennaio del 1952 vi si aggiunse anche il reparto di meccanica con fratel Francesco di Domenico come responsabile. Tanti giovani marinavano le scuole governative per correre a quelle della missione.
Padre Marigo, di fronte a questo vortice di opere che stupivano i confratelli, commentava:
«Non vi ricordate che noi siamo entrati in Messico non come sacerdoti (non ci avrebbero dato il permesso), ma come professori? Dobbiamo dunque esercitare questa professione!»
La città dei ragazzi
Una parola a parte merita la fondazione della "Città dei Ragazzi" che fu il fiore all'occhiello del Padre. Per questa storia si può confrontare il libro di padre Carlo Toncini "La città dei ragazzi e delle ragazze".
Una mattina del 1952, mentre usciva dalla missione per recarsi a celebrare la messa, padre Marigo vide un fagottello per terra... che si muoveva. Si avvicinò e constatò che si trattava di un bambino di pochi mesi. Lo raccolse e lo portò a casa.
«Cosa vuol dirmi il Signore con questo segno?», si domandò. Non ci pensò molto. Il 20 aprile 1952 benedisse la prima pietra dell'orfanotrofio, annesso alla "Villa".
«E per i soldi?», potrà chiedere qualcuno. È chiaro! Ci pensava la Provvidenza attraverso varie iniziative come: lotterie, pesche di beneficienza, sottoscrizioni delle dame... cose tutte nelle quali padre Zelindo era maestro.
Intanto venne eletto economo di Circoscrizione, e nel 1953 dovette andare in Italia insieme a padre Giovanni Fortuna per partecipare al Capitolo generale della Congregazione.
Al ritorno disse che anche per la Bassa California era giunto il momento di dare un aiuto economico alla Congregazione e alle missioni. Ciò significava che la Circoscrizione poteva considerarsi adulta ed esercitare uno scambio di missionarietà con il resto delle forze comboniane.
Dopo il Capitolo del 1953 padre Marigo fece cambiare posto alla falegnameria perché disturbava la scuola e la sistemò vicino all'orfanotrofio che venne inaugurato ufficialmente nell'agosto del 1954. I primi inquilini furono 6 ragazzi tirati fuori dalla prigione dei minorenni. Il caso del neonato rimase unico e servì solo per dare l'idea dell'orfanotrofio.
Da questo momento cominciò a delinearsi la vera Città dei Ragazzi costituita dalla villa e dall'orfanotrofio con scuola di falegnameria. Da questa "città" usciranno uomini veri, intellettualmente e professionalmente preparati, che oggi sono perfettamente inseriti nella società.
Arie nuove
I confratelli, parlando di padre Marigo, dicevano: «Fa di giorno ciò che ha sognato di notte». Le sue iniziative a valanga derivavano da un preciso carisma: quello di aiutare i più poveri della parrocchia. In questo si dimostrò un vero missionario che, insieme all'evangelizzazione, curava anche la promozione umana. Ma non tutti lo capirono.
Padre Marigo lavorava in maniera piuttosto autonoma. Se questo può essere un limite, oggi, non lo era certamente 30 anni fa, quando buona parte della formazione comboniana era basata sul "sapersi arrangiare". Marigo applicava questo sistema anche con i confratelli che esercitavano il loro ministero in parrocchia con lui. Pur essendo il parroco, aveva affidato i vari settori ai singoli Padri e non interveniva minimamente nel loro lavoro. Diceva: «Siete sacerdoti come me, sapete che cosa dovete fare. Sono sicuro che ognuno si sforza di dare il meglio di sé. Ho piena fiducia in tutti».
Il superiore di circoscrizione, però, temendo che le iniziative di Marigo ipotecassero il futuro degli altri missionari, pensò bene di frenarlo facendogli cambiare aria. E lo mandò a Monroe, al confine con il Canada. Era il 2 novembre 1954.
Partì senza una parola di recriminazione e con il consueto entusiasmo. Si inserì nel nuovo lavoro con grinta e spirito di iniziativa dando ottimi risultati.
Nel 1956 venne dirottato nella California statunitense dove c'erano molti messicani. Egli si dedicò particolarmente a loro, radunandoli, istruendoli, battezzandoli, sposandoli. Perché non si sentissero orfani, costruì anche un piccolo santuario alla Madonna di Guadalupe e mise in piedi una piccola tipografia per dare un lavoro e una professione ai ragazzi disoccupati.
Padre Carlo Toncini, intanto, mandava avanti la Città dei Ragazzi di La Paz e la faceva diventare anche Città delle Ragazze.
Padre Marigo, dopo un breve servizio come coadiutore a Washington (Georgia), poté finalmente tornare in Messico (che aveva nel cuore), a Santa Rosalia, come parroco (1967).
Nel 1968 lo troviamo di nuovo nella "Città dei Ragazzi e delle Ragazze" per lasciare il tempo a padre Toncini di fare le sue vacanze in Italia. Al ritorno di costui, Marigo venne trasferito a Città di Messico nell'opera sociale artesanato nazareth nella quale confluivano ragazzi dai 15 ai 18 anni, già ladri e violentatori, che la polizia raccoglieva nelle retate notturne. Fu un lavoro duro, eppure padre Marigo riuscì a ricuperare la maggior parte di quei giovani, dando loro un'istruzione e un mestiere.
Vice superiore ed economo a Verona
Nel 1972 il Padre lasciò il Messico per andare a Roma a fare il corso di aggiornamento. Poi passò a Verona Casa Madre come vice superiore, economo e incaricato delle giornate missionarie. Padre Marigo si fece subito benvolere da tutti per la sua cordialità e delicatezza nel trattare con le persone. Era preoccupato che in casa non mancasse niente di ciò che era conveniente per una comunità religiosa. Nonostante la sua età non più giovanissima, era sempre sulla breccia per cercare aiuti, per incontrare amici e benefattori, per dialogare con i sacerdoti della diocesi.
Si preoccupò di abbellire la casa dandole tinte nuove e comperando mobili e suppellettili decenti in sostituzione di quelle ormai fruste. Si notò subito, insomma, che con il suo arrivo qualcosa stava cambiando. Un confratello, per esempio, aveva fatto un grosso incidente con l'auto.
«È meglio prenderne una nuova - gli disse il Padre - perché tu sei un tipo un po' apprensivo e con una macchina che può essere compromessa nella stabilità ti troveresti a disagio». Qualcuno, naturalmente, lo giudicò "americano", ma a lui stava a cuore la serenità dei confratelli. Per i soldi, ci avrebbe pensato la Provvidenza.
Nella circostanza del cambiamento di nome della nostra Congregazione, padre Marigo si batté perché si conservasse il nome antico di Figli del Sacro Cuore. Quando, tuttavia, prevalse l'altro, lo accettò con vero spirito di obbedienza e non tornò più sull'argomento.
A Verona ha lasciato un bellissimo ricordo di un uomo premuroso, di un sacerdote zelante, di un missionario disponibilissimo sempre e con tutti. Anche gli amici e i benefattori del nostro Istituto impararono ben presto ad amarlo e a stimarlo. Un anno, per la festa dei parenti dei missionari veronesi, riuscì ad ospitare in Casa Madre più di 1.000 persone. Come abbia fatto a dar da mangiare a tutti, a far trovare tutti a loro agio, a stringere le mani di tutti, è stato un miracolo che solo un organizzatore nato come lui poteva fare.
Direttore del Centro Missionario Diocesano
Il primo marzo 1980 partì nuovamente per la "Città dei Ragazzi e delle Ragazze" di La Paz a sostituire padre Toncini che rientrava in Italia malato. Il vescovo lo incaricò anche delle opere missionarie della diocesi. Sentendosi ormai vecchio, padre Marigo ebbe cura di "tirarsi su" un giovane seminarista che cercò di infiammare di spirito missionario. Oggi questo giovane è sacerdote diocesano, è segretario del vescovo ed è abile direttore delle Opere Missionarie della diocesi.
Erano passati tanti anni dal suo primo arrivo a La Paz. La città contava ormai più di 150.000 abitanti. Ed egli, sempre attento alle necessità dei più deboli, vide che c'erano molti handicappati in giro. Bisognava che qualcuno si dedicasse anche a loro.
Nel 1984, sentendosi ormai stanco e giudicandosi inadatto a dirigere la "Città", passò l'opera nelle mani di padre Meloni ed si ritirò nella Casa Comboni, a mezzo chilometro di distanza dalla "Città". Pur essendo così vicino, non volle mai intromettersi nella conduzione del nuovo direttore. Ciò sta a dimostrare la sua delicatezza e la retta intenzione con cui si era dedicato a quell'opera.
In Casa Comboni si prestò all'assistenza dei confratelli anziani o di passaggio. Inoltre fondò e diresse un gruppo di buone signore che si offrivano volontariamente a portare aiuto materiale e morale agli handicappati della città. Egli era preoccupato di scoprirli, di accostarli, per porgere loro il conforto dei sacramenti, della sua parola e, a seconda dei bisogni, anche di qualche aiuto materiale. Contemporaneamente, per volere del vescovo (egli lasciando la "Città" aveva dato le dimissioni) portò avanti anche l'ufficio di assistente al Centro Missionario Diocesano. Si incaricò della chiesetta del Sacro Cuore, costruita da padre Menghini, che riuscì a trasformare in centro di spiritualità dove i fedeli e i sacerdoti potevano trovare un confessore sempre disponibile, e l'adorazione perpetua.
Handicappato con gli handicappati
Nel 1986, durante gli esercizi spirituali, chiamò padre Menghini, superiore della casa, e gli disse:
«Mario, domani portami all'ospedale perché mi devono tagliare un dito del piede destro».
«Un dito! Da quando tu hai male a un dito?»
«È un regalo della Campagna di Russia.»
«E tu hai sempre sofferto in silenzio e hai camminato diritto!»
Dopo il dito, che lasciò una ferita inguaribile in quanto il Padre soffriva di diabete, i sanitari dissero che era necessario amputare anche la gamba perché c'era pericolo che andasse in cancrena.
«Piano piano con la gamba – protestò padre Menghini. – Prima sentiamo altri sanitari e il padre provinciale».
«Io la taglio – protestò padre Marigo. – Se il Signore mi chiede questo sacrificio vuoi che mi rifiuti? E poi, senti, io lavoro tra gli handicappati, non ti pare che sarebbe bello che diventassi anch'io come loro? Sarei finalmente un po' più credibile». Il vecchio desiderio di morire martire si faceva avanti... e Marigo non voleva perdere l'occasione di versare un po' di sangue prima di morire. E poi la condivisione con coloro che ora serviva!
Padre Villotti, il provinciale, il vescovo stesso gli dissero di tornare in Italia in un ospedale più specializzato. Se fosse guarito, anche senza una gamba, sarebbe tornato con i suoi handicappati.
Forte di questa promessa, il Padre si lasciò portare in Italia. Il viaggio fu organizzato in due giorni, anche perché i sanitari assicuravano che se non si interveniva subito, entro due giorni, occorreva tagliare anche l'altra gamba.
Il viaggio venne organizzato con precisione cronometrica e tutto filò a puntino.
«Giunti a Milano – scrive padre Menghini – c'era l'ambulanza dell'ospedale di Borgo Trento di Verona che ci attendeva con padre Alberto Martinuzzi. All'ospedale, lo internarono subito per operarlo. Nel fare le analisi, il primario disse che, secondo lui, non c'era tutta quell'urgenza diagnosticata dai sanitari messicani. Poco a poco, con le cure adeguate, anche la piaga al piede si rimarginò e non si parlò più di tagliare gambe».
Alla fine del 1987 il Padre ebbe luce verde per tornare a La Paz. Ma no, questo non era nei piani di Dio. Il servo fedele aveva già completata la sua giornata.
Ecco riaprirsi improvvisamente la piaga. Pur di poter tornare, il Padre si fece trapiantare un pezzo della propria pelle. La ferita rimarginò, ed egli poté camminare. Già sognava La Paz quando gli comunicarono che non apparteneva più alla provincia messicana, bensì a quella italiana. Fu il crollo della sua resistenza morale. Tuttavia, obbediente, rassegnato, scorse subito il segno della volontà di Dio. Ma pianse e gemette. E non si riebbe più.
Sempre delicato, per non disturbare l'infermiere cercava di fare i piccoli spostamenti da solo. Un brutto giorno cadde e si fratturò il bacino. Si sperava ancora in un'operazione. Ma i medici non se la sentirono, perché il diabete era troppo alto e non c'era verso di farlo scendere. Gli ordinarono sei mesi di letto e di sedia a rotelle. Padre Marigo capì che era giunto il momento di incontrarsi col Signore e intensificò la sua vita di preghiera. Mise ordine nelle sue carte, nei suoi diari e consegnò tutto al superiore, padre Antonio Zagotto. Poi volle ricevere tutti i sacramenti per essere pronto alla chiamata qualora arrivasse improvvisa.
Intanto la sua situazione sanitaria si complicava con enfisema polmonare e blocco renale. La domenica notte, alle 20,15, fratel Gianni s'intrattenne con lui, quindi lo lasciò un momento per andare da un altro malato che chiamava. Tornò qualche attimo dopo, ma lo trovò già morto. Era andato a prendere il premio per la sua intensissima vita missionaria vissuta nella gioia, nell'entusiasmo, nella donazione e nella continua attenzione ai più deboli e fragili.
«Quando l'anno scorso gli recapitai la nomina del Presidente della Repubblica italiana a cavaliere d'Italia per meriti civili – scrive padre Mario Menghini – ne godette assai. Io però pensai che egli era piuttosto il Gran Cavaliere della sua vocazione missionaria. Questa infatti fu l'unica dama di tutta la sua vita. E non visse che per essa. Sua gran pena fu morire lontano dai suoi handicappati per i quali pensava di donare ancora qualche anno della sua esistenza condividendo la loro situazione».
La salma, dopo i solenni funerali in Casa Madre, è stata traslata nel cimitero di Piove di Sacco, suo paese natale. Siamo sicuri che dal cielo Padre Marigo susciterà sante vocazioni alla vita missionaria, quella vita che ha costituito la ragion d’essere della sua esistenza terrena. Padre Lorenzo Gaiga
Da Mccj Bulletin n. 161, gennaio 1989, pp.57-68