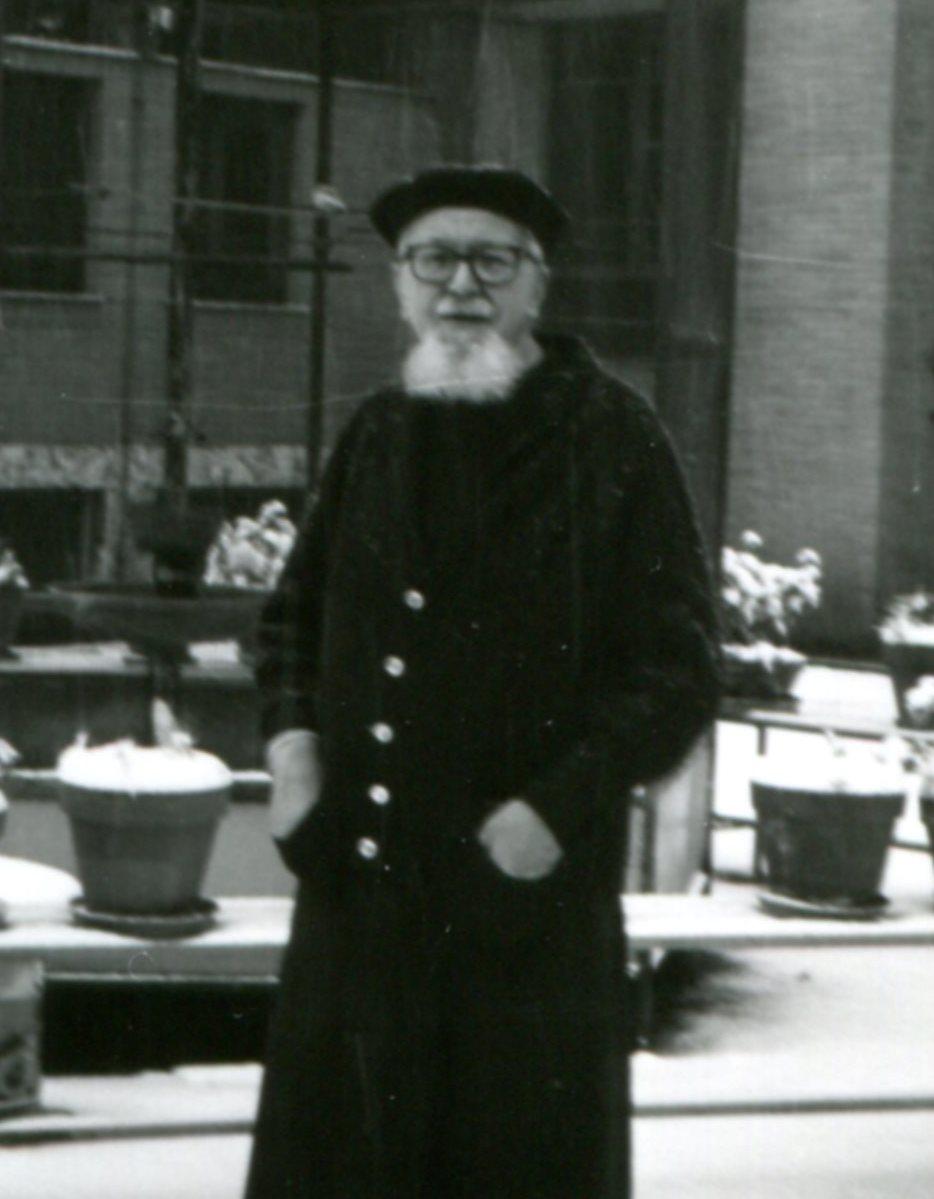Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Gasparotto Pio
Eccoci con un confratello che ha costituito la gioia delle comunità dove è passato, per il suo buon umore, la sua allegria, il suo ottimismo e l'amore sincero che dimostrava verso i confratelli. Pio è diventato un'istituzione, nell’Istituto, amato e stimato da tutti. Veramente di lui si può dire: "Dovunque è passato ha seminato il bene". A fr. Pio, insieme a p. Ramazzotti, è dedicato il libro "A scuola dal beato Daniele Comboni" scritto dal suo parente p. Pietro Gasparotto. In tale dedica Pio è ricordato come "innamorato della sua vocazione di fratello, dell’Istituto comboniano e dell'Africa".
Nato a Fara Vicentina, ancora piccolo si è trasferito con la numerosa famiglia a San Giorgio di Perlena, Vicenza, dove il papà mise in piedi un negozio di alimentari.
Pio era sesto di dieci fratelli, quattro dei quali morirono in tenera età. Ricordò per tutta la vita le paure della prima guerra mondiale, anche se aveva solo 5-6 anni. Gli rimasero impressi gli scoppi delle "bombarde" austriache, le fughe con la famiglia per trovare riparo in posti sicuri, le strettezze imposte dal conflitto bellico. La paura della guerra gli resterà nel sangue per tutta la vita.
Nei suoi racconti, fr. Pio ricordava spesso i viaggi che faceva con papà Francesco a Thiene o a Marostica per rifornire il negozio. Si usava il cavallo e il carretto, quindi bisognava partire quando era ancora notte.
"Durante quei lunghi viaggi - diceva - il papà recitava non so quanti rosari perché tutto andasse bene e non succedessero brutti incontri".
La mamma, Giovanna Guerra, era super occupata ad accudire la numerosa famiglia, ma trovava anche il tempo di servire i clienti in bottega.
La vocazione
Ecco come fr. Pio racconta l'inizio della sua vocazione. "Il mio buon papà, che mi voleva tanto bene, un giorno mi disse: 'Bisogna che anche tu cominci a venire con me a Thiene e a Marostica per imparare a provvedere per la bottega'. Risposi subito di sì e presi quell'incombenza come un dovere, un piacevole dovere.
Molto spesso, vicino a Thiene, incontravamo un fraticello col cavallino e col carretto. Io chiesi al papà che cosa facesse quel frate. 'Va a cercare il cibo per i poveri che battono alla porta del convento', mi rispose. E subito sentii una grande simpatia per i frati, perché avevano cura dei poveri e chiedevano la carità per loro. Quasi quasi volevo chiedere al papà che mi lasciasse farmi frate, ma come dirglielo, visto che mi ripeteva spesso: 'Tu starai sempre con me e imparerai bene il mestiere e io, quando sarò più avanti negli anni, ti darò il cavallo e il carretto'?
Ma ecco che un giorno, mentre eravamo in un negozio di tessuti a Thiene, entrò un missionario, salutò tutti e si avvicinò al mio papà chiedendo: 'E' vostro figlio questo ragazzo?'. 'Sì, è il mio figlio più piccolo. Me lo porto dietro perché impari il mio mestiere. Ho una piccola bottega a San Giorgio'.
I due si allontanarono un po' e parlarono da soli, poi tutto finì con un arrivederci.
'Di cosa avete parlato quando eravate soli?', chiesi al papà sulla via del ritorno. 'Voleva che tu andassi con lui a farti missionario. Ma gli ho detto che è una cosa impossibile, sia perché mi devi aiutare nella bottega, sia perché sei il più piccolo e ti voglio tanto bene... ma tu non pensare più a queste cose'.
Io invece cominciai a pensarci molto spesso. Poi, un po' alla volta, il pensiero si dileguò.
Ma ecco che un giorno, mentre eravamo alla stazione di Thiene per caricare della merce che era arrivata col treno, incontrammo ancora il missionario. Il papà aveva fretta, il missionario no. 'Finché lei carica la merce mi dia il ragazzo. Lo porto a visitare la nostra casa'. Il papà acconsentì".
Qui Pio si dilunga a raccontare la visita delle falegnamerie, delle officine e dei reparti sartoria e calzoleria dove tanti ragazzi lavoravano in silenzio, ma si vedeva che erano tanto contenti. Il padre - era padre Francesconi - spiegava cosa facevano e a che cosa si preparavano. Pio ascoltava e meditava. Poi successe anche un altro fatto.
Di tanto in tanto p. Magagnotto andava a San Giorgio per predicare e confessare. Anch'egli, vedendo Pio così buono e servizievole, e certamente d'accordo con p. Francesconi, insisteva perché entrasse tra i Comboniani. Prima di lasciare il paese il missionario andava dalla mamma del ragazzo per parlare della bellezza della vocazione missionaria. La mamma obiettava che Pio era troppo vivace per diventare missionario, che doveva prendere in mano la bottega e poi, per licenziare il Padre, gli offriva un bicchierino.
Dato che la cosa si ripeteva con una certa frequenza, Pio commentò un giorno: "Chissà se a questo Padre interessava di più la mia vocazione o il bicchierino della mamma!".
Un duro combattimento
Un giorno il papà, durante il solito viaggio a Thiene, chiese al figlio se proprio voleva ancora farsi missionario.
"Sì, papà, anche se mi viene da piangere al pensiero di lasciare te e la famiglia".
"Se il Signore veramente ti vuole, io non mi oppongo, però sento una grande sofferenza... Ormai hai 15 anni e devi decidere. Se sei contento, oggi, potremo parlare col superiore di questa tua decisione".
"Sì, papà, parliamone". Giunti a Thiene parlarono col p. Francesconi e stabilirono il giorno dell'entrata.
"Non dire alla mamma quando lascerai la famiglia, soffrirebbe troppo", disse il papà durante il ritorno.
La partenza
Pio continua: "Era l'anno 1927, il 7 maggio. Io avevo 15 anni. Come la ricordo quella mattina del 7 maggio! E come è stato doloroso il distacco dalla famiglia! La sera prima il papà aveva messo in uno scatolone da alimentari il mio corredo. Non aveva fatto la valigia per non impressionare la mamma. Al mattino alle cinque, papà ed io ci alzammo e, facendo finta di andare a fare la spesa a Thiene, neppure svegliammo la mamma e i fratelli. E via col calesse. Nessuno parlava... Mi era costato partire senza dirlo alla mamma, senza darle un bacio, ma era meglio così. L'avevo vista piangere troppe volte quando pensava alla mia partenza.
Giunti a Thiene, andammo al santuario della Madonna dell'Olmo ad ascoltare la messa, poi entrammo in un bar per fare un po' di colazione. Alle otto in punto eravamo davanti alla porta dell'istituto missionario.
'Pio - mi disse il papà stringendomi a sé - se ti accorgi che questa non è la tua strada o non ti trovi bene, torna a casa, sarai sempre accolto a braccia aperte'. 'Sì, papà'. Il cavallo sauro batté lo zoccolo per terra quasi dispiacesse anche a lui che io lo lasciassi. Volevo bene al mio cavallo.
Ci accolse il fratello portinaio e, poco dopo, il superiore. Dopo un'ora il papà si alzò per andarsene.
'Guarda di essere buono e obbediente con tutti e ama i tuoi compagni'. Quindi mi guardò con tanto affetto e mi diede un bacio. Ripeto: era il 7 maggio 1927, verso le ore nove.
Io fui condotto a visitare la casa e i laboratori. Poi il superiore mi fece entrare in stanza sua e con fare veramente paterno mi spiegò come si svolgeva la vita in quella casa, e mi assegnò al reparto falegnami. Il mio maestro era fr. Clemente.
Mi trovai subito a mio agio. Ci volevamo molto bene, pregavamo, lavoravamo e giocavamo. Era proprio una bella vita anche se soffrivo di nostalgia per la famiglia. Alla sera, quando ero solo nel mio letto, mi sorprendevo a piangere pensando alla mamma, al papà, ai fratelli.
Parlai col superiore di quella mia angustia e mi disse che era una tentazione del diavolo il quale non voleva che diventassi missionario. Sapendo che quella sofferenza era una tentazione, la superai più facilmente raccomandandomi alla Madonna.
Trascorso un mese, il papà e la mamma vennero a trovarmi. Dopo avermi abbracciato e baciato, la mamma mi chiese se volevo tornare a casa. 'No, mamma, il Signore mi vuole qui e qui sto bene', ma in gola avevo un grosso nodo. Essi se ne andarono contenti.
Per tutti i tre anni che rimasi a Thiene, non andai mai in vacanza. Allora si usava così". Fin qui Pio nel suo diario.
In una lettera al p. generale del 26 gennaio 1930, Pio esprime il desiderio di andare a Brescia insieme a p. Francesconi, suo primo superiore, per essere un po' più lontano dalla famiglia e dagli amici che "vengono un po' troppo spesso a farmi visita e così mi disturbano nella mia vita di comunità".
Intanto anche una sua sorella era entrata dalle Suore della Misericordia e un fratello dai missionari saveriani, ma poi uscì. Diventerà sacerdote saveriano un suo figlio, padre Francesco.
La visita in famiglia
Prima di partire per il noviziato, Pio fece visita alla famiglia (20 marzo 1930); tre giorni, compresa l'andata e il ritorno. A casa trovò un lutto: era morta la figlioletta del fratello Leone. Pio mise in pratica per la prima volta il suo mestiere di falegname preparando la piccola bara bianca per la nipotina.
Il distacco rinnovò ancora tante lacrime, specie da parte della mamma, e un'intensa sofferenza da parte di Pio... ma giudicava quel sentimento una tentazione del diavolo...
Novizio a Venegono
A 18 anni, il 23 marzo 1930, entrò nel noviziato di Venegono con altri 5 compagni. In noviziato Pio ebbe qualche sofferenza; la più grande fu quella di vedersi differita la vestizione che ebbe luogo il 9 settembre, festa di S. Pietro Claver.
Sulla solida base di onestà e di fede che aveva ricevuto nella sua famiglia patriarcale, innestò la spiritualità che gli veniva comunicata dal p. maestro.
Il 7 ottobre 1932 emise la professione religiosa.
Le note dei superiori, sia a Thiene come in noviziato, ci presentano un Pio buono, cordiale, uomo di compagnia, sempre sereno e capace di creare e di diffondere tra i compagni e in comunità un clima di pace e di distensione.
La sua compagnia era cercata da tutti perché aveva un modo di parlare facile, intessuto da battute umoristiche e argute e poi "sapeva contarle bene".
Chi lo sostenne nei momenti di prova durante il noviziato, fu p. Carlo Pizzioli, aiutante del p. maestro, per il quale Pio serberà sempre un ricordo riconoscente e affettuoso.
A Troia
Dopo i Voti fu inviato a Troia. Vi rimase dal 1932 al 1936. Il primo impatto con p. Sartori, superiore, non fu dei più felici. Il Padre aveva chiesto ai superiori un fratello falegname di una certa età, esperto nei serramenti di cui la casa aveva urgente bisogno, non un novizio.
"Se vuole che torni a Verona o a Venegono, me lo ordini, e io torno subito", disse Pio.
"Ormai sei qui. E poi non è colpa tua se hai 20 anni!". Alla prova dei fatti il superiore non ebbe da pentirsi del novellino.
Nella biografia di p. Sartori si incontrano parecchie episodi che riguardano il nostro fr. Pio. Ne ricordiamo solo qualcuno più significativo. Tra gli altri uffici Pio aveva anche quello di sacrestano. Sappiamo le lotte tra p. Sartori (che non è nato santo, ma ci è diventato grazie al notevole sforzo per domare il suo carattere irruente e impulsivo) e il parroco don Spinelli.
Siccome a causa del terremoto la chiesa comboniana della Mediatrice, il cui animatore era appunto p. Sartori, doveva servire anche per la parrocchia, le battaglia tra Sartori e Spinelli erano all'ordine del giorno.
Per la notte di Natale, per esempio, il parroco aveva allestito il presepio. All'ultimo momento p. Sartori ne fece un altro sull'altare di fronte, con tanto di luci che si accendevano e si spegnevano e di statuine che si muovevano: un capolavoro rispetto a quello del parroco. Questi si sentì umiliato perché la gente sostava davanti a quello del missionario, non degnando di uno sguardo il suo. Senza dire che le donne commentavano: "C'ha fatto stanotte a Madonna? Due figli?".
Quando celebrava il parroco, Sartori diceva a Pio: "Metti solo due candelieri piccoli". Quando celebrava lui diceva: "Mettine quattro di belli grandi".
Allora Pio interveniva con discrezione e dolcezza facendo capire al suo superiore che "Mi me pare che non sia un modo da cristiani questo qua. Specialmente a Natale" (Pio parlava solo dialetto veneto). P. Sartori, andò a inginocchiarsi davanti al parroco a chiedergli perdono e poi si scusò con la gente per il suo modo di fare alquanto piratesco.
Sartori aveva così stima di Pio che lo incaricò dell'acquisto dell'automobile per la casa (una Fiat 501), mentre si trovava a San Giorgio di Perlena in vacanza.
Pellegrinaggio tragicomico
In vecchiaia Pio credeva ciecamente alle varie apparizioni della Madonna e al suo intervento nelle vicende degli uomini. Da giovane non era proprio così, pur amando moltissimo la Madre di Dio. Sentiamo questa:
Un giorno padre Sartori decise di portare i Fratelli in pellegrinaggio a Pompei per inaugurare la famosa automobile. Partirono al mattino prestissimo, in modo da trovarsi a Pompei, che è dall'altra parte d'Italia, ancora digiuni per la messa e la comunione. Arrivarono, fecero le loro pratiche di pietà, e poi visitarono gli scavi e altri luoghi interessanti.
Durante il ritorno furono sorpresi dalla notte. Per non rischiare qualche incidente, si fermarono in una radura in mezzo a un bosco. Qualcuno rimase nella macchina, mentre Pio trovò posto su una catasta di legna.
Ad un certo punto arrivarono i carabinieri e gridarono: "Chi va là". Ci fu un momento di panico, anche perché era buio pesto. Quando i missionari si fecero conoscere, furono benevolmente apostrofati dai carabinieri: "Non sapete che è pericoloso fermarsi fuori di notte? Ci sono i briganti in giro".
"Cosa vuole che facciano a noi i briganti! - rispose p. Sartori - non abbiamo niente". L'emozione fu tale, che la notte passò senza che i nostri riuscissero a riprendere il sonno.
Al mattino erano nuovamente in marcia. All'inizio di una discesa, Pio vide che in fondo c'erano le sbarre del treno che stavano per scendere. Fr. Varotto, che era al volante e lottava contro il sonno, non le vide.
"Le sbarre, le sbarre! - urlò Pio e, con la velocità di un gatto, si buttò fuori dall'auto. Varotto frenò e riuscì a fermarsi proprio mentre la sbarra calava dolcemente sul cofano della macchina. In quel momento passò il treno.
"E' stata la Madonna!", esclamò p. Sartori.
"Par mi l'è sta la notte passà sul fascinaro", fece eco fr. Pio.
Una doccia al dottore
Alcuni ragazzini di Troia avevano l'abitudine di suonare il campanello della porta dei Comboniani e poi se la davano a gambe.
"Vi insegno io a suonare i campanelli", disse Pio. Si appollaiò in soffitta e attese pazientemente. Ecco il trillo, ecco i ragazzi in fuga. Egli, allora, si preparò un secchio d'acqua e attese il secondo round. Infatti, poco dopo, si sentì la scampanellata e lui giù il secchio d'acqua. Accidenti, quella volta era il dottore che veniva a visitarlo.
Nel 1933 Pio fu operato di emorroidi col sistema del tubo di ferro e della fiamma ossidrica. Sorvoliamo i particolari e veniamo al significativo commento di Pio: "Quelli sì erano tempi!".
Carità eroica
Dopo la partenza di p. Sartori per l'Africa nel 1934, fu eletto superiore p. Luigi Urbani che era padre spirituale dei ragazzi. P. Urbani era gravemente malato di tubercolosi per cui, ad un certo punto, dovette isolarsi in stanza. Chi lo accudiva in tutto e per tutto era fr. Pio.
"Gli portavo da mangiare, gli lavavo le stoviglie e la biancheria, anche i fazzoletti pieni di sangue. Facevo volentieri quel lavoro perché il Padre era tanto buono, un autentico santo".
Ma Pio si buscò la tubercolosi sicché tutti e due finirono in sanatorio. Pio al Chievo, presso Verona (1936-1937), p. Urbani all'ospedale di Tradate (Varese) nel reparto TBC.
Da buoni veronesi, i compagni di camerata di Pio desideravano qualche bottiglia di buon vino, ma il prezioso liquido era proibito in quel luogo. Allora adoperavano la fascia della veste talare del missionario per introdurre furtivamente, attraverso la finestra, qualche bottiglia. Naturalmente erano d'accordo con un oste di fuori e, per la delicata operazione, aspettavano che le suore fossero a messa. "Per il servizio, un goccetto anche a me". diceva Pio. Quando le suore si accorsero del trucco, il missionario si prese una solenne lavata di capo. "Proprio lei che dovrebbe dare buon esempio!". E lui: "Il vino va nella pancia, non nei polmoni". Nonostante non bevesse più vino, Pio peggiorava.
A Tradate
Allora i superiori lo mandarono a casa sua in riposo per 6 mesi (1937).
"Col buon vino di Breganze annegai tutti i microbi, e i pochi rimasti li soffocai col fumo di qualche buon sigaro", commentò Pio. Non fu esattamente così, perché dovette essere trasferito a Tradate (1937-1938) per sottoporsi all'operazione al polmone.
Nella biografia di p. Urbani, scritta da p. Santandrea, è riportato un episodio singolare. Qualche giorno prima di morire, p. Urbani si trascinò a fatica fino al letto di fr. Pio che era nella stanza attigua. Si inginocchiò per terra e domandò perdono al Fratello di avergli causato, pur involontariamente, quella malattia. Allora la tbc era chiamata "il male che non perdona".
Il Padre promise che dal Cielo avrebbe pregato per lui perché potesse guarire. Pio perse un polmone, ma guarì così bene da poter andare in missione. Con una delle sue solite battute umoristiche diceva: "Avendo un polmone solo ho almeno la fortuna di non essere colpito da polmonite doppia".
Quanto alla guarigione Pio amava raccontare anche il seguente episodio: "Mentre mi trovavo all'ospedale di Tradate più morto che vivo, mi fu suggerito di fare una novena a mons. Comboni. Cosa che feci con gran devozione, tenendo la sua immagine sotto il cuscino. All'ultimo giorno, ebbi uno sbocco di sangue che spaventò i medici. Allora misi l'immaginetta di Comboni nel cassetto e la sostituii con quella della Madonna Mediatrice di Troia. E le dissi: 'E' per colpa tua se sono in queste condizioni; ora devi guarirmi'. Con sorpresa di tutti, cominciai a riprendermi molto bene. Allora misi l'immagine sul comodino, ma le suore non la volevano perché i medici esigevano ordine e pulizia (come se un'immagine della Madonna fosse una cosa sporca). Io, però, dissi:
'No, quella deve restar lì perché è la Madonna che mi fa guarire non le vostre medicine'. E me la lasciarono".
Passò qualche anno a Trento (1938-1939) in cura e come aiutante in casa mentre s'incamminava a guarigione perfetta.
Egli commentava la sua situazione fisica con la seguente rima: "La Mediatrice, i sigari, il buon vino e tanto brio restituirono la salute a fratel Pio".
Messo al muro dai tedeschi
Dal 1939 al 1942 fu a Thiene, sempre in cura e come aiutante campagnolo. Intercettato da una pattuglia tedesca mentre andava a fare la spesa in città, fu messo al muro per essere fucilato perché creduto una spia dei partigiani che, proprio in quei giorni, volevano attaccare Thiene.
La segretaria dei tedeschi, un'italiana, assicurava che aveva visto "quel prete" mentre celebrava la santa messa a un gruppo di partigiani sul Pasubio.
Fu salvato grazie all'intervento di p. Pietro Rossi. Rischiò di farsi ammazzare anche dalle bombe americane che bombardavano la stazione di Thiene vicinissima alla casa comboniana. E durante la ritirata dei tedeschi, terrorizzato dal loro passaggio, quasi si suicidò buttandosi nella grande vasca che raccoglieva l'acqua piovana per annaffiare l'orto. A chi gli diceva che il suo comportamento era esagerato rispondeva:
"Sfido chiunque ad aver tanta paura quanta ne ho avuta io!".
Ancora a Troia
Dal 1943 al 1945 i superiori lo dirottarono nuovamente a Troia dove era conosciuto e benvoluto dalla gente. In quella casa c'era ancora bisogno di un buon falegname, ma il nostro Fratello si prestò per tutti i lavori di cui la casa aveva bisogno.
Quel secondo periodo troiano si concluse con un viaggio disastroso, parte a piedi, parte su camion di fortuna, parte in treno, per risalire l'Italia, sfidando i bombardamenti americani, i rastrellamenti tedeschi e le vendette dei fascisti.
Povero Pio, proprio a lui dovevano capitare queste cose, con tutta quella paura della guerra che aveva in corpo!
Dal 1945 al 1948 fu a Padova come economo-spenditore, portinaio, sagrestano e tuttofare. Presso la fiera di Padova costruì un villaggio africano con tutti gli annessi e connessi, e poi si prestò per fare da cicerone alla gente che andava a visitarlo.
In Africa
Finalmente, alla fine del 1948 poté partire per l'Africa. Andò in Egitto dove rimase fino al 1951 come addetto alla casa provinciale del Cairo e addetto alla chiesa del Sacro Cuore. Nelle sue memorie Pio descrive in lungo e in largo la festa che gli hanno fatta a San Giorgio. "Messa solenne, discorsi da strappare le lacrime ai sassi, poesie in dialetto a rima baciata (e spesso tirata - conserviamo il testo) e perfino la banda musicale".
Uno dei primi lavori che fr. Pio eseguì fu una macchina per fabbricare le candele. La fece in legno e funzionava pure bene.
Invitato a frequentare la scuola per imparare qualche parola di francese e di arabo, Pio declinò l'invito proponendosi di imparare una frase al giorno, solo una, parlando con i ragazzi. Ma dopo alcuni tentativi, un fratello che si trovava pure in casa gli disse: "Pio, è meglio che vada io a scuola al posto vostro". Pio si vantava dicendo: "Mi, le lingue le go imparà in piazza".
Al Cairo entrò in amicizia con due anziani quasi novantenni che erano stati liberati dalla schiavitù da Comboni. Conobbe anche suor Casella che, lasciata Malcesine a 16 anni per seguire Comboni, ora si trovava, carica di anni, al Cairo.
Un giorno p. Bombieri, provinciale d'Egitto, ordinò a Pio di segare a metà una bottiglia di vetro per ricavarne un vasetto, seguendo un metodo che assolutamente non poteva funzionare. Pio ci tentò più volte, ma sempre inutilmente. Il Padre, allora, gli diceva di riprovarci, ma con più fede. E Pio, paziente come Giobbe, ci riprovava. Appena il Padre si allontanò, Pio fece il lavoro seguendo un metodo suo e in pochi minuti ci riuscì.
"Come avete fatto?", chiese il superiore stupito.
"Ci ho messo un po' più di fede, Padre", rispose il fratello.
Un'altra volta Bombieri ordinò a Pio e a p. Messori di aprire una porta in un muro portante della casa.
"E' pericoloso aprire una breccia in questo muro", disse p. Messori.
"Lei ubbidisca".
"Lasci fare a me", rispose Pio.
Appena il superiore si fu coricato per il pisolino pomeridiano, al quale teneva enormemente, i due cominciarono a menare mazzate nel muro facendo rintronare la casa. Bombieri scese in fretta e disse: "E' meglio che lasciate perdere. Forse non conviene fare una porta in questo muro".
P. Bombieri, tipo piuttosto sospettoso, ma secondo lui sempre a fine di bene, aveva l'abitudine di origliare alle porte dei confratelli. Pio e Messori, infastiditi da tale comportamento, gliene combinarono una.
Una sera, sentendo l'impercettibile passo dell'ascoltatore che si avvicinava, Pio gridò ad alta voce:
"P. Messori, venga fuori col fucile ché ci sono i ladri".
"E voi ce l'avete il bastone?".
"Sì, e sono deciso anche a picchiare forte".
Uscirono di scatto ma non videro nessuno.
"Cerca, cerca, saranno scappati in qualche stanza", e aprirono la porta più vicina. Il Padre era dentro e non sapeva come giustificare la sua presenza.
"Ma è lei? Scusi, Padre, credevamo che fosse qualche ladro colui che alla sera veniva ad accertarsi se eravamo in stanza o no". Quella volta, il povero Padre capì il suo errore e si guardò bene dal ripeterlo.
Per la festa di S. Alfonso Rodriguez, patrono dei Fratelli, p. Bombieri aveva invitato tutti i Fratelli al Cairo per un fraterno intrattenimento. Dalle varie case i festeggiandi si accingevano a partire quando una telefonata di p. Olivetti li avvisò che p. Bombieri aveva programmato una giornata di ritiro spirituale. Gli invitati, naturalmente, rinunciarono al "festoso convegno".
Quando p. Bombieri decadde dal suo incarico di provinciale, chiese a Pio di aiutarlo a preparare le valigie. Sappiamo che p. Bombieri era chiamato "sant'Antonio" per la sua spiritualità piuttosto esagerata e per il disprezzo del denaro che inculcava nei suoi sudditi. Ebbene, Pio vide che tra le pagine del breviario il Padre aveva alcune banconote. "Lei lo chiama sterco del diavolo - disse mostrandogliene una - forse lo mette nel breviario per farlo diventare 'fiore del paradiso'", disse.
Dopo quattro anni di missione Pio chiese al Superiore Generale di andare in Italia per un po' di vacanze e per riprendersi un po'. "Sono appena quattro anni che siete in missione e già parlate di vacanze!". "Quattro anni con sant'Antonio ne valgono come minimo otto", rispose Pio.
Nella terra di Comboni
L'Egitto fu la porta che lo introdusse in Sudan dove arrivò nel 1951 destinato alla comunità del Comboni College e addetto alla scuola tecnica, reparto falegnameria. Riteneva un privilegio trovarsi negli stessi posti testimoni della presenza del Comboni, ma dopo pochi giorni dal suo arrivo, dovette mettersi a letto con febbre a 40.
Chiamato il medico, questi gli diagnosticò: "Polmonite doppia". "Doppia, no! - protestò Pio con un pizzico di soddisfazione - ho un polmone solo".
I fioretti di Pio in Sudan sono una selva lussureggiante; è meglio dire un giardino fiorito. Eccone uno. Un ufficiale inglese che doveva partire per le vacanze, aveva un magnifico pappagallo. Non sapendo a chi affidarlo, pregò fr. Pio di accudirlo. Aveva notato, infatti, che il Fratello aveva una predilezione per gli animali.
Pio accettò di buon grado e fece il suo dovere con estrema precisione, ma quale fu la sua sorpresa quando una mattina, avvicinando il volatile per porgergli il cibo, si sentì dire in linguaggio pappagallesco: "Pio sei scemo".
"Ohè bestiaccia, chi ti ha insegnato a trattare così chi ti cura?". Era stato un confratello che con notevoli sforzi era riuscito a far apprendere al pappagallo quell'espressione poco cortese. La cosa divenne di domino pubblico e tutti risero allegramente, Pio per primo.
Dal 1953 al 1955 fu falegname a Delen (Dilling), la missione tanto cara a Comboni, che ora veniva riaperta e ricostruita.
Seguendo le indicazioni lasciate dai primi missionari studiò i posti dei primi fabbricati e andò anche in cerca di quel famoso crocifisso di bronzo che i missionari, portati prigionieri dai mahdisti, avevano nascosto negli anfratti del monte Kudrù. La sua ricerca fu vana. Pare, infatti, che quel crocifisso di notevoli dimensioni non sia ancora stato trovato.
Per fornirsi di acqua si dovevano percorrere 7 chilometri. Un po' troppo per rispondere ai bisogni di una futura missione. Fr. Pio, prendendo il coraggio a due mani, cominciò a scavare un pozzo insieme agli operai locali. Per evitare il pericolo di smottamenti, praticò un foro ad imbuto, partendo molto in largo.
Da Khartum, intanto, arrivò l'ordine di sospendere i lavori non ritenendo opportuno fondare una missione dove mancava l'acqua. Del resto anche Comboni si era imbattuto nella stessa difficoltà proprio a Delen, e aveva ottenuto l'acqua da una vena che ai contemporanei era parsa miracolosa.
Fr. Crivello già si avviava col camion a Delen per ritirare gli attrezzi quando, a 18 metri di profondità, il pozzo cominciò a dare acqua buona, fresca, pulita.
Fr. Crivello, allora, rivestì l'invaso di mattoni e cemento ottenendo un ottimo pozzo che funziona tutt'ora.
Pio rimase a Delen da solo per un anno, perché fr. Crivello era andato a lavorare nella missione di Kadugli, e l'attività di evangelizzazione per il momento era proibita dagli inglesi. Sicché Delen costituiva una casa di passaggio per i missionari in transito. "La solitudine mi pesava - diceva fr. Pio - perché a me piaceva stare con i confratelli. Avevo anche paura degli scorpioni e dei serpenti. Ce n'erano tantissimi e dappertutto. Ma non mi hanno mai toccato. Davvero ho esperimentato la protezione del Signore". Trovò degli ottimi amici fra la gente e i ragazzi del posto, che lo accompagnavano nelle battute di caccia per poter procurarsi un po' di carne. "Sono stato contento - concluse fr. Pio - perché Delen fu uno degli ultimi posti visitati da Comboni prima di morire".
Doppio spettacolo
Venendo da Dilling a El Obeid col camion, Pio aveva slacciato la cinghia dei calzoni "per respirare un po'". Quando scese, si dimenticò di riallacciarla. Come mise piede a terra allargò le braccia ed esclamò: "Che spettacolo!". In quell'istante i calzoni si afflosciarono a terra. "Doppio spettacolo", commentò p. Pigarella che era presente.
Fu anche a Malbes, vicino ad El Obeid, dove ai tempi di Comboni c'era una colonia di africani tutti cristiani.
Dal 1955 al 1965, per ben 10 anni, fu ad Atbara sempre come falegname, ma Pio esplicava anche tante altre mansioni come sagrestano, aiuto cuoco e addetto alla casa. Ad Atbara, grande centro ferroviario sudanese, c'era un grande collegio tenuto dai Comboniani. C'erano con lui p. Rovelli e Franco Gasparini.
Andava anche a trovare la gente nei villaggi vicini e lontani per intrecciare nuove amicizie e parlare del Vangelo. Un giorno chiese alla suora della cucina di preparargli il cibo per un safari di tre giorni.
"Solo i sacerdoti vanno in safari, non i fratelli", rispose la suora. Quindi, niente cibo. A Pio quelle parole fecero venire la mosca al naso e rispose:
"Vede suora, è vero; io non sono un sacerdote, ma se un vescovo mi unge, posso diventare anche Papa. Lei invece, anche se la buttano in un barile di olio, resterà solo una suora unta".
Una caratteristica di fr. Pio fu la capacità di dialogo con i musulmani. Molti di essi erano suoi amici ed egli era amico di tutti, specialmente degli anziani che lo capivano anche se parlava mezzo arabo e mezzo dialetto veneto.
Qualche confratello, un po' malignamente, diceva che il dialogo con la mezzaluna gli riusciva bene appunto perché lui conosceva poco l'arabo e gli altri ignoravano del tutto il dialetto di Vicenza.
Scherzi a parte, si può dire che fu uno dei precursori, pur nella semplicità della sua vita, di quel dialogo tra cristianesimo e islam (insieme a fr. Sergi e altri fratelli) che oggi sembra andare di moda e che a fatica si cerca di scoprire sui libri.
Il soggiorno ad Atbara si concluse con i noti moti rivoluzionari portati avanti dagli studenti, forse sobillati da elementi di sinistra o più verosimilmente dai "fratelli musulmani". Gli studenti rifiutavano gli stranieri come insegnanti per questo spaccarono tutto, scuola e missione prima di ogni cosa. Pio tornò in Italia, gli altri Padri andarono a Khartum.
A Verona
Dopo qualche mese a Carraia come coltivatore di funghi (un'industria comboniana di insignificante successo, come quella delle cavie a Padova, del sapone, delle galline e dei castorini a Brescia) fu dirottato a Verona. Vi rimase dal 1965 al 1971. Qui fu colpito da una brutta broncopolmonite che, data la sua situazione sanitaria, lo portò sull'orlo della tomba. Ma la sua ora non era ancora giunta per cui si riprese così bene da ricevere il permesso di ripartire per l'Africa.
In una lettera del 14 novembre 1971, così si espresse col Superiore Generale: "Ho ricevuto la sua lettera che mi dà il via per Khartum. Dato che le pratiche vanno per le lunghe, come dice lei, continuo il mio lavoro presso l'ufficio spedizioni del Piccolo Missionario. Quando arriverà il permesso, partirò con molta gioia". Quel permesso non è mai arrivato, perché i superiori, esaminando meglio la cosa, capirono che Pio non aveva più una salute da Africa.
Visse a Verona nel tempo della contestazione sessantottina. Gli scolastici portarono via le statue dei santi che si trovavano in cappella (compresa quella di san Luigi Gonzaga) e misero i quadri in soffitta.
"Sai perché gli scolastici hanno fatto sparire san Luigi dalla chiesa?", disse un giorno Pio a un suo amico. "Non saprei", rispose l'interpellato. "Non è per san Luigi ma per i gigli che tiene in mano 'i è quei che i ghe spussa a questi giovanotti qua'".
A Verona si rese utile nella spedizione dei Piccoli Missionari. Con orgoglio diceva: "P. Gaiga fa i Piccoli e io li fascio per mandarli via". E' stato davvero un caro amico che s'interessava del lavoro dei confratelli, lo seguiva e non mancava di dire una parola di incoraggiamento nei momenti difficili.
A Roma come una leggenda
Dal 1971 al 1993 fu telefonista e portinaio presso la Curia di Roma. "Ho fatto quattro Capitoli Generali dell’Istituto", diceva. A Roma divenne quasi una leggenda, molto amato ed apprezzato nonostante non fosse un poliglotta raffinato.
Sul suo diario si trovano le "regole per un buon portinaio". Sono poche ed essenziali. Le riportiamo perché lui le ha veramente vissute: "Primo: tanta carità con tutti; secondo: pazienza e rispetto per tutti; terzo: pensare sempre bene di tutti e non pensare mai male di nessuno. Solo il Signore è giudice. Per i confratelli di passaggio, per quanto è possibile, aiutarli tutti e sempre col sorriso".
Tutto qui. Ma c'è davvero tutto.
Anche a Roma i fioretti sarebbero tanti da raccontare, cominciando dal suo rapporto con i canarini che conosceva uno per uno e che chiamava per nome, e pareva che anch'essi conoscessero il padrone che portava loro il becchime, puliva la voliera e s'intratteneva con simpatici commenti. Davanti ai suoi canarini diventava una copia di San Francesco. I confratelli lo tormentavano chiedendo quali fossero i maschi e quali le femmine. Ed egli: "Se fa le uova è una femmina, se non le fa è un maschio". E rideva divertito. La portineria era il luogo di convegno dei confratelli, perché con lui si stava bene, si scherzava volentieri ed egli si lasciava prendere benevolmente in giro, anzi sembrava che ci trovasse gusto ad essere al centro delle battute dei confratelli.
Ma sapeva anche vedere le cose. I suoi giudizi sugli scolastici, per esempio, erano azzeccati. Quando, parlando confidenzialmente con qualche Padre, ne indicava qualcuno e diceva: "Quello... non ci siamo!", si poteva stare sicuri che presto o tardi l'interessato lasciava l’Istituto.
Gli dava un po' fastidio l'afflusso in refettorio di laici e laiche, amici di qualche confratello. Un giorno indicando la scritta "Missionari Comboniani" che si trova sul frontale della Casa, così commentò: "Lì sarebbe meglio scrivere 'albergo Comboni, a grati' (la esse se la mangiava lui), ma l'idea era ben chiara.
Chi non ricorda il suo "Pronto, Missionari Comboniani!" scandito con precisione al telefono, e poi via alla ricerca dell'interessato. Un prelato, commentando le risposte di Pio al telefono disse: "Voi Comboniani avete una simpatica carta di identità in portineria".
Il segreto d'ufficio era una colonna portante della sua attività. Su questo non si scherzava e non ammetteva scherzi. Quando qualcuno malignamente e per provocare la sua reazione gli chiedeva: "Pio che dicono i grandi capi?", egli diventava serio e diceva: "Qui sono una tomba" e neppure sorrideva.
Esatto e preciso nelle sue pratiche di pietà, andava e veniva dalla cappella con i suoi libri di devozione in mano. Non avrebbe smesso le preghiere che aveva apprese in noviziato per tutto l'oro del mondo. Tuttavia seppe adattarsi di buon grado alle innovazioni del Concilio Vaticano II che trovava opportune e intelligenti.
Come giornali ne leggeva uno solo: "L'Osservatore Romano" e solo a quello credeva ciecamente. Gli altri erano tutta robaccia tendenziosa. Approfittando di questa sua fiducia nel giornale del Vaticano, alcuni confratelli, con un montaggio particolare, gli fecero trovare un articolo che parlava dei marziani sbarcati sulla terra e in marcia verso Roma. Ebbe qualche dubbio, ma se lo diceva l'Osservatore!
Alla sera tardi, tuttavia, chiamò un suo amico e, preoccupatissimo, gli chiese spiegazioni. Questi, vedendolo tanto angustiato, gli disse che si trattava di un ennesimo scherzo per ridere un po' alle sue spalle. "L'ho pensato, ma era sull'Osservatore! Come avete fatto a farmela così bella?".
Il 23 giugno 1979 fu ricevuto dal Papa in udienza insieme ai Padri capitolari. Egli pensò a lungo alla frase che avrebbe detto a Giovanni Paolo II. Finalmente, quando fu il suo turno, disse: "Santità, io questa veste - e si toccò la talare - non l'ho mai tolta da quando ho fatto la vestizione 49 anni fa". Il Santo Padre sorrise divertito e gli disse: "Bravo, bravo".
Nel 1982 Pio celebrò il 50° della sua professione religiosa. Gli scolastici, che gli volevano bene come a un nonno, gli prepararono un bel cartello e poi gli chiesero che cosa voleva che scrivessero per quella felice circostanza.
Fr. Pio, senza pensarci due volte, disse: "Come mi piace vivere con te Signore". Vivere col Signore è stato il programma di tutta la sua vita. Visse col Signore la vita, la malattia, l'ultimo ricovero all'ospedale di Negrar e la morte per blocco renale.
Ultima tappa a Verona
Dopo un lungo periodo di degenza trascorsa a Roma-Eur, nel 1992 fr. Pio venne portato a Verona con l'ambulanza. La salute era in situazione preoccupante. Il cuore funzionava poco, la circolazione ancora meno e le gambe si gonfiavano. Scrisse fr. Pio: "Una crocetta arrivata dal Cielo: la gamba sinistra non cammina più. Motivo: sangue fermo. Così si è fermato anche il portinaio".
Per fargli sentire meno amara la partenza da Roma, gli avevano detto che, appena rimessosi, sarebbe tornato al suo lavoro che amava e al quale era ormai affezionato.
A Verona soffrì un po' la mancanza di quella allegra squadra di confratelli che facevano capannello attorno alla portineria per ridere e scherzare con lui, in compenso si riprese in salute tanto da sperare in un ritorno a Roma, ma questo non arrivava mai.
"Caro mio - disse un giorno a un amico - stai attento a cambiare posto, perché subito ti dicono che sei indispensabile, che, appena rimesso in salute torni... invece poi ti trovi seduto per terra. Ma io sono contento così".
In realtà anche a Roma sentirono la mancanza di fr. Pio. Glielo espresse il Superiore Generale: "Carissimo fr. Pio, sentiamo la tua mancanza qui in comunità per animare le nostre conversazioni e per godere delle tue prontissime battute spiritose ma, seguendo il tuo esempio, accettiamo ciò che il Signore dispone come la cosa migliore per te e per noi".
Col primo gennaio 1994, fr. Pio fu definitivamente assegnato alla Casa di Verona, reparto malati.
"Come è bello pensare ai 20 anni passati in portineria a Roma! scrisse. Poi - Come è bello riandare ai tanti confratelli passati per incontrare i superiori maggiori e avere da loro una buona parola, un incoraggiamento, un consiglio, un po' di conforto... in una parola: carità! Come è bello e fa bene un lungo periodo in portineria. S'imparano tante cose come: fare accoglienza con bontà e col sorriso per amore del Signore, a tutti. Per questo San Giovanni dice: 'Se non ami il tuo fratello che vedi, come puoi amare Dio che non vedi?'". Sono scarne noterelle alla fine del suo diario.
Tutti a Verona notarono la sua disponibilità nel dare una mano ai confratelli più malati di lui. Era puntuale nel tenere la corrispondenza: in essa rivelò fino agli ultimi giorni della sua vita il suo naturale atteggiamento di riconoscenza verso gli altri.
Il 60° dei voti
Il 7 ottobre 1992 celebrò a Roma il sessantesimo di professione. In quell'occasione il p. generale gli scrisse: "Ti ringrazio della testimonianza di gioia che hai sempre dato, di amore all’Istituto, di attaccamento alla vocazione di Fratello comboniano, di costante preghiera, di vita comunitaria. Ti invito, nel giorno del tuo anniversario, ad affidarti nuovamente al Signore della vita, unendoti alla croce e risurrezione di Gesù per la redenzione del mondo. Il 7 ottobre chiederò alla Madonna, madre di ogni missionario, di stare sempre vicino a te".
Riposa accanto ai genitori
Dopo i funerali in Casa Madre, la salma è stata traslata al paese. Qui i funerali furono un'apoteosi. Tutti infatti gli volevano bene. Ora riposa accanto ai suoi genitori che ha tanto amato e ha anche fatto soffrire per seguire la sua vocazione.
Scrive il nipote p. Francesco, saveriano, dal Brasile: "Gli sono profondamente riconoscente per aver avuto grande parte nella storia della mia vocazione. Ora mi restano i suoi esempi: amore profondo alla sua famiglia religiosa, povero e umile, filiale devozione alla Vergine Santa, esempio di pazienza, uomo di Dio e di molta orazione... Ricordo la sua stanza; non poteva essere più povera: solo il puro necessario. E mai che si lamentasse. Un uomo veramente sereno e contento. Chissà come avrebbe desiderato assistere per TV alla beatificazione di mons. Comboni e di mons. Conforti. Avrà assistito alla festa dal Cielo, con i due interessati presenti.
Sento il dovere di porgere un ringraziamento particolare agli infermieri e alla Comunità per le premure e attenzioni avute verso lo zio...".
Dei suoi 83 anni, 62 furono vissuti nell'Istituto. Ha amato la sua vita di comboniano ed il suo esempio ha aiutato molti confratelli ad amarla.
Che dal cielo aiuti i confratelli a vivere in quella santa semplicità e schietta allegria che lo hanno sempre caratterizzato e che hanno reso amabile la sua lunga esistenza e gradevole, anche agli occhi degli esterni, la vocazione di fratello missionario. (P. Lorenzo Gaiga, mccj)
Da Bollettino n. 193, ottobre 1996, pp. 60-73