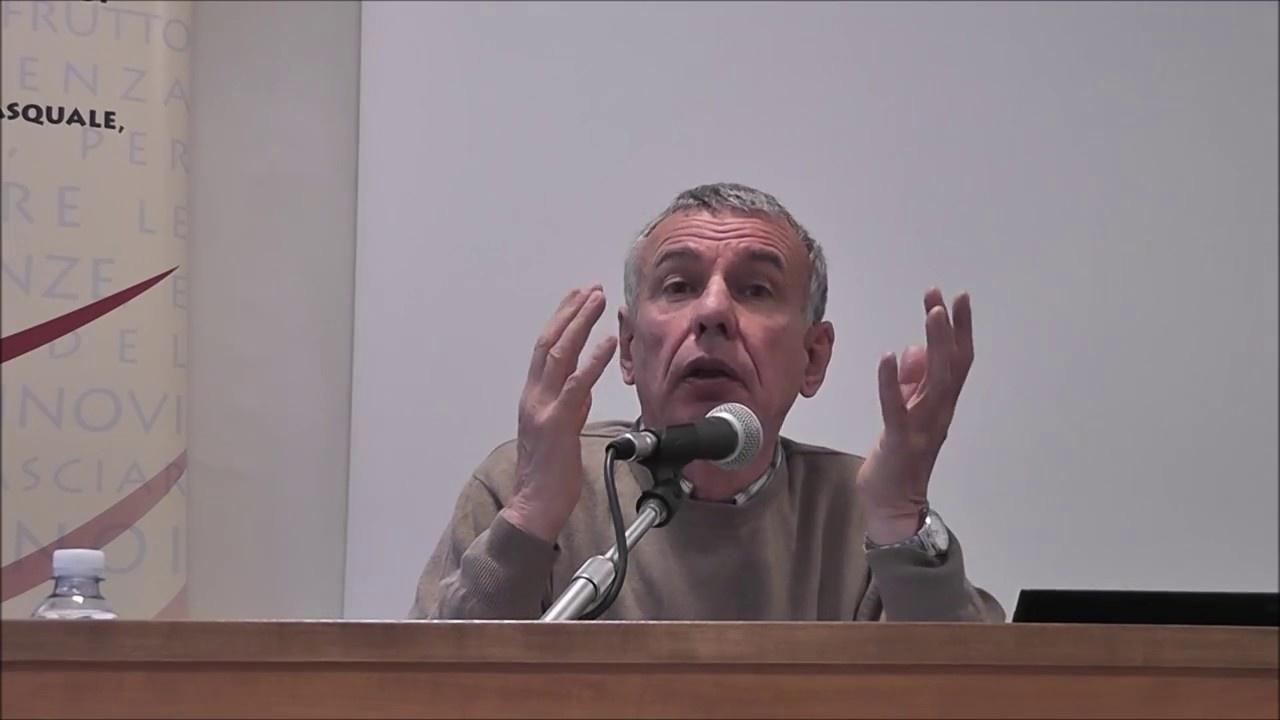Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Sabato 5 aprile 2025
Viviamo tempi di incertezza, in cui le parole sembrano smarrire forza e senso, e le relazioni si fanno sempre più fragili. I conflitti, grandi e piccoli, si moltiplicano: a livello internazionale, nei territori di guerra, ma anche nelle nostre comunità, nelle carceri, nei quartieri, nei rapporti tra persone. [Festival della Missione (FdM)]
Giustizia che ripara, pace che unisce.
Una chiamata alla responsabilità
Viviamo tempi di incertezza, in cui le parole sembrano smarrire forza e senso, e le relazioni si fanno sempre più fragili. I conflitti, grandi e piccoli, si moltiplicano: a livello internazionale, nei territori di guerra, ma anche nelle nostre comunità, nelle carceri, nei quartieri, nei rapporti tra persone.
Come Festival della Missione, crediamo che in questo contesto sia urgente non solo denunciare ciò che non va, ma promuovere visioni alternative, capaci di generare futuro. Per questo, vogliamo rilanciare due iniziative che parlano una lingua comune: quella della giustizia come riconciliazione e della pace come responsabilità condivisa. Da un lato, un percorso di approfondimento e testimonianza sulla giustizia riparativa, che realizzeremo con un podcast in uscita a settembre. Dall’altro, il nostro impegno nel promuovere e sostenere il People’s Peace Summit, l’evento internazionale per la pace che si terrà l’8 e 9 maggio 2025 a Gerusalemme, e che oggi rappresenta una chiamata aperta a tutte e tutti.
Invitiamo ciascuno a fare la propria parte, a non restare in silenzio, a sottoscrivere l’appello a sostegno di questa iniziativa.
 Basta un click per far sentire la tua voce.
Basta un click per far sentire la tua voce.
Giustizia riparativa, una realtà possibile
Negli ultimi anni, anche nel nostro ordinamento giuridico è entrata in scena una prospettiva diversa: quella della giustizia riparativa, formalizzata con il decreto legislativo n. 150 del 2022. Una prospettiva che non sostituisce la giustizia penale, ma la affianca, introducendo la possibilità di un incontro diretto – libero, volontario, protetto – tra la persona che ha subito un reato, l’autore dell’offesa e, quando possibile, la comunità.
La giustizia riparativa non nasce per cancellare il dolore, né per facilitare il perdono. Nasce per riconoscerlo. Per creare uno spazio in cui ogni parte possa essere ascoltata, nominare il proprio vissuto, trovare parole dove spesso c’è solo silenzio o giudizio.
Nel modello umanistico di Jacqueline Morineau, una delle pioniere della mediazione, il mediatore è definito “artigiano di pace”: una figura terza, formata, capace di facilitare l’incontro e l’emersione di senso. È una pratica che valorizza la dignità, anche quando ferita. E che invita a non ridurre le persone a ciò che hanno fatto o subito.
In Italia, sono già molte le esperienze che hanno preso forma in questa direzione: dai percorsi tra autori di reato e vittime promossi dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, alle pratiche attivate nei centri di giustizia riparativa, fino al lavoro condotto con le vittime, i familiari delle vittime, e i responsabili della lotta armata, testimoniato nel volume “Il libro dell’incontro”. Un incontro che è avvenuto a scadenze regolari e con assiduità sempre maggiore, con l’aiuto di tre mediatori: il padre gesuita Guido Bertagna, il criminologo Adolfo Ceretti e la giurista Claudia Mazzucato. Una via altra alla ricomposizione, ispirata all’esempio del Sud Africa post-apartheid. Come Festival, abbiamo partecipato ad alcune testimonianze di alcuni di percorsi: qui erano presenti Franco Bonisoli, Manlio Milani e Giorgio Bazzega.
Per chi volesse approfondire, è stato recentemente pubblicato un agevole saggio sul tema, "Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia" del magistrato Marcello Bortolato e del giornalista Edoardo Vigna che entra nel vivo degli incontri di giustizia riparativa, spiegando nel dettaglio come avvengono e quali regole devono rispettare.
Per raccontare tutto questo, il Festival della Missione lancerà a settembre un podcast in cinque puntate, con il contributo di giornalisti, operatori, esperti e testimoni diretti. Tra le storie al centro del percorso, anche quella di Paolo Amico, condannato all’ergastolo per aver partecipato, il 21 settembre 1990, all’omicidio del giudice Rosario Livatino, magistrato del Tribunale di Agrigento, ucciso dalla mafia a soli 38 anni.
Livatino è stato proclamato beato da Papa Francesco nel 2021, riconosciuto come “martire della giustizia e, indirettamente, della fede”. La sua vicenda è stata raccontata anche nel film Il giudice ragazzino, diretto da Alessandro Di Robilant e uscito nel 1994, che offre uno sguardo profondo sulla figura del magistrato e sul contesto in cui ha operato. Lo si può recuperare qui.