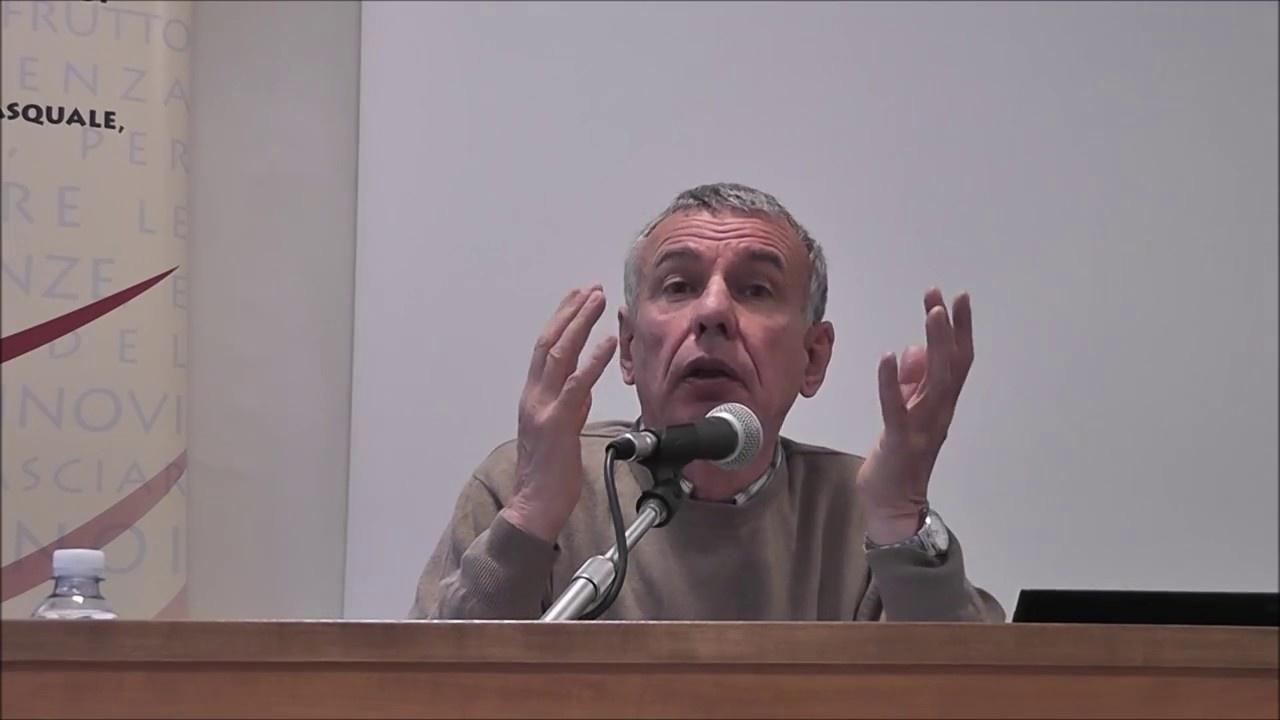Daniel Comboni
Missionnaires Comboniens
Zone institutionnelle
D’autres liens
Newsletter
Lunedì 31 marzo 2025
Ogni volta che in Africa o nel vicino Medio Oriente viene perpetrata un’azione terroristica ai danni di una comunità cristiana, la notizia riscuote solitamente una notevole risonanza sulla stampa occidentale. Tuttavia, dietro il clamore mediatico, rimane spesso inesplorata la complessità del fenomeno. Le persecuzioni, e in particolare i loro retroscena, hanno da sempre costituito una materia ostica, difficile da comporre in una visione d’insieme coerente. [Padre Giulio Albanese, comboniano – L’Osservatore Romano]
Per affrontare correttamente una realtà tanto articolata, è bene rammentarlo, occorre conoscerla nei dettagli, negli effetti, nelle cause, e non ridurla a una semplice analisi per compartimenti: il risultato finale, infatti, non coincide con la mera somma delle singole componenti.
Ciò significa, in sostanza, guardando ad esempio alla questione delle persecuzioni in senso lato, che queste, se opportunamente valutate, non possono prescindere dalle cause e concause che oggi le generano, sia nei Paesi dove esse si manifestano (ideologie dominanti, politiche perverse, legislazioni arcaiche...), sia nel contesto più generale della globalizzazione, al cui interno certe dinamiche trovano terreno fertile. Tutti questi fattori interagiscono tra loro, a volte rendendo la matassa estremamente intricata. Per tali motivi occorre operare un sano discernimento sulle scelte da praticare, se vogliamo davvero segnare la svolta, quella del riscatto, dell’affermazione dei diritti e dunque dell’agognato cambiamento.
Ma procediamo con ordine. È bene rammentare che il termine persecuzione, dal latino persequi, nel lessico italiano si applica prevalentemente all’ambito religioso, in riferimento all’azione di un determinato potere costituito, allorché esso configura come un delitto e punisce conseguentemente l’adesione a una determinata credenza religiosa e tutti gli atti che ne conseguono. In questa prospettiva, la fenomenologia persecutoria — in particolare quella di matrice islamista — è riscontrabile in diverse aree dell’Africa. Tuttavia, nel tentativo di comprenderla appieno, non è sufficiente individuare esclusivamente le parti in causa — vittime e carnefici — ma occorre anche analizzare le ragioni profonde che alimentano tali azioni criminali, responsabili ancora oggi di sofferenze indicibili. La posta in gioco è alta perché occorre evitare la perniciosa deriva del cosiddetto «scontro delle civiltà» fortemente voluto dagli estremisti. Infatti, è evidente che l’intento dei gruppi jihadisti è quello di strumentalizzare la religione per fini eversivi, eliminando chiunque si opponga al loro delirio di onnipotenza. Ridurre, dunque, la galassia delle forze d’ispirazione jihadista esclusivamente nella prospettiva di una lotta globale contro l’Occidente, sotto una struttura di comando centralizzata indicata come al-Qaida o Isis, significa non cogliere la complessità del fenomeno in cui entrano in gioco spesso questioni locali, proprie dei singoli Stati in cui operano le suddette cellule eversive. Basti pensare, ad esempio, al movimento al-Shabaab in Somalia o Boko Haram in Nigeria che hanno trovato ispirazione nei conflitti in atto nei rispettivi territori tra le oligarchie locali per il controllo del territorio e del potere.
Queste formazioni hanno sempre colpito chiunque osteggiasse il loro progetto d’imporre la Sharìa, la legge islamica: musulmani, cristiani, animisti… Peraltro, da un punto di vista numerico, i terroristi hanno ucciso in questi anni più musulmani che cristiani e ogni volta che hanno perpetrato attentati contro chiese e istituzioni cristiane (al-Shabaab in Kenya dopo che il governo di Nairobi era intervenuto militarmente in Somalia e i Boko Haram in Nigeria e nel vicino Camerun) e l’hanno fatto perché queste azioni sarebbero state riprese dalle testate giornalistiche internazionali, avendo così risonanza a livello mondiale. Messaggi mortiferi, dunque, ispirati da un’ideologia in netto contrasto con il sentimento religioso e spirituale dei grandi monoteismi.
Rimane il fatto che queste formazioni criminali operano in diversi settori del continente africano. Sono, ad esempio, molto attive nel triangolo geografico compreso tra Niger, Mali e Burkina Faso, dentro il vasto perimetro della regione saheliana. Per non parlare del settore orientale della Repubblica Democratica del Congo (Nord Kivu) o del Mozambico Settentrionale, dove a pagare il prezzo più alto è la stremata popolazione civile.
È comunque importante precisare che vi sono altri Paesi islamici in Africa in cui i cristiani si trovano spesso ad affrontare situazioni difficili, determinate, ad esempio, dalle limitazioni imposte dai vari sistemi giurisprudenziali, che riducono fortemente le facoltà dei cristiani nell’ambito lavorativo e più in generale del «diritto civile». Questo indirizzo, con varie accentuazioni e sfumature, si riscontra dal Marocco, dove la presenza cristiana è ridotta ad un «piccolo resto» senza pretesa alcuna di proselitismo, tassativamente proibito dall’ordinamento vigente nel Paese, all’Algeria, terra di martiri, dove, in questi anni, la comunità cristiana ha pagato a caro prezzo con il sangue il suo tributo contro il terrorismo accanto alla popolazione inerme. Basti pensare all’eroico sacrificio dei sette monaci trappisti di Nostra Signora dell’Atlante a Tibhirine, trucidati nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996. Anche in Egitto, il Cristianesimo copto è soggetto ai condizionamenti giuridici sanciti dalla Costituzione che, pur garantendo la libertà religiosa, proclama l’Islam come principale fonte legislativa, condannando l’apostasia alla pari di un reato per alto tradimento. Sempre in questo Paese, dove il dissenso politico viene represso, la costruzione di un luogo di culto per i cristiani necessita di un lungo e spossante iter burocratico.
Una cosa è certa: c’è una differenza abissale tra parlare di persecuzioni e viverne da vicino il dramma, guardando negli occhi chi, giorno dopo giorno, sopravvive in quella condizione estrema. Per capire davvero, bisogna esserci, vedere, ascoltare e toccare con mano. Alcuni anni fa, grazie al supporto di un’organizzazione umanitaria, mi fu possibile entrare in un Paese africano, a stragrande maggioranza musulmana, sconvolto dalla guerra e retto dalla Sharìa, la legge islamica. Per tutelare la piccola e coraggiosa comunità cristiana ancora presente, non posso tuttora rivelare nomi né luoghi. Ma non dimenticherò mai ciò che vidi. Chiesi quasi subito di poter visitare i resti di alcune chiese. La prima tappa fu la cattedrale locale: un cumulo di rovine. Più tardi, in clandestinità, raggiunsi un vecchio sacrestano in un villaggio a una settantina di chilometri dalla capitale. L’edificio della parrocchia era stato brutalmente sventrato così come il campanile. Ma fu l’altare a lasciarmi senza fiato: la mensa sacra spezzata in due, come se si volesse infrangere, simbolicamente, il cuore stesso della fede. Con dignità composta, il vecchio mi raccontò di essere riuscito a salvare i registri dei battesimi. Li custodiva gelosamente in casa, nascosti come reliquie. Gli chiesi se fosse in contatto con una piccola comunità di religiose che operava nella capitale. Mi rispose che una volta al mese riceveva da loro flaconi di medicine in cui erano celate le particole. Prima di andarmene, gli donai una coroncina del rosario. Scoppiò a piangere come un bambino che ritrova qualcosa di perduto, e mi chiese di benedirla. Poi la nascose con cura in una bisaccia, su cui spiccava la scritta Allāh Akbar. A bassa voce, quasi temesse che qualcuno potesse udirlo, mi sussurrò che, per lui, quelle parole erano dedicate al Dio dei cristiani. Nessuno lo sapeva.
E proprio per questo, non si può restare in silenzio. Le parole si fanno responsabilità. Come ammonì Papa Francesco durante la sua visita a Tirana, «nessuno può permettersi di prendere a pretesto la religione per le proprie azioni contrarie alla dignità dell’uomo e ai suoi diritti fondamentali, in primo luogo quello alla vita e alla libertà religiosa di tutti».
P. Giulio Albanese – L’Osservatore Romano