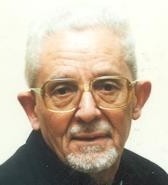Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
In Pace Christi
Bianchini Marcello Pietro
Geburtsdatum :
19/01/1928
Geburtsort :
Tartano
Zeitliche Gelübde :
07/10/1948
Ewige Gelübde :
09/09/1953
Datum der Priesterweihe :
12/06/1954
Todesdatum :
04/08/2003
Todesort :
Milano/I
“Ogni cosa che respira dia lode al Signore” (Salmo 150, 5). Queste solenni parole concludono il salterio e, oltre ad essere la sintesi di tutte le preghiere che contiene, descrivono in buona misura la parabola umana e spirituale di P. Marcello Pietro (P. Pierino): il respiro e la lode. Respirare per vivere, lodare per essere in comunione col Signore.
Nelle settimane di assistenza a Roma, durante la sua grave crisi respiratoria, le sorelle ed i familiari lo chiamavano con il nome affettuoso di Pierino che poteva maggiormente richiamarlo alla consapevolezza. Facendone memoria, useremo questo appellativo che indica quanto sentisse di appartenere ancora alla sua famiglia mentre viveva l’identità comboniana nell'Istituto.
Di fronte alla sua vita si rimane sconcertati e ci si chiede, come le anziane consorelle di S. Teresina del Bambino Gesù, “cosa si potrà dire di lei?”. Anche P. Pierino è come un iceberg: appare solo un’insignificante punta galleggiante. Per svelarne i principali valori che entreranno nel patrimonio spirituale dell'Istituto e costituiranno pure un consolante ricordo per la numerosa famiglia che ha lasciato, abbiamo due fonti. La prima sono i suoi diari e gli articoli che ha scritto per la sua amata Val Tartano. La seconda è costituita da alcune testimonianze sia documentarie che di confratelli che gli sono stati particolarmente vicini. Un'ultima premessa può essere utile. Egli è vissuto quasi nascosto e senza far sentire la sua voce, contemporaneamente si è fatto presente con i suoi servizi puntuali e perseveranti in ogni angolo dell'Istituto e a servizio di non poche Chiese locali di missione.
La trama della sua vita
Ci teneva a specificare di appartenere alla diocesi di Como, alla provincia di Sondrio, al comune di Tartano e alla parrocchia di Campo (patrono S. Agostino) ed era nato nella frazione di Dosso il 19 gennaio 1928. Era cresciuto sotto la vigile cura di mamma Rosa e papà Egidio con altri tre fratelli e quattro sorelle. Terminate le elementari, entra nella scuola apostolica di Como nel 1942 prima che fosse aperta la sede di Rebbio. Ve lo conduce lo stesso parroco, Don Siro Cabello. Prosegue la sua formazione a Crema e poi a Brescia: viene ammesso al noviziato con l'unico punto interrogativo della salute. Nel settembre 1946 è affidato alle cure di P. Stefano Patroni, a Firenze. Uno straordinario maestro spirituale che lo capisce e scrive: “Ha delle belle qualità per diventare un buon religioso e missionario. Sente molto il distacco dalla famiglia”. I superiori, successivamente, lo inviano per il secondo anno di noviziato a Sunningdale dove emette i primi voti il 7 ottobre 1948 e vi rimane per i corsi di filosofia. Ritorna in Italia, a Venegono, dal 1950 al 1954 , nel nostro scolasticato studia teologia. Emette i voti perpetui il 9 settembre 1953 ed è ordinato sacerdote dal Card. I. Schuster (ora Beato) a Milano, il 12 giugno 1954. Dal 1954 al 1960 è segretario prima di P. Antonio Todesco e poi di P. Gaetano Briani, Superiori Generali. Per la sua conoscenza dell'inglese e le sua capacità, è inviato in Inghilterra per la specializzazione in storia. Iscritto all'Università di Londra (1960-1962) deve interrompere gli studi per motivi ci salute. Da allora vivrà sempre, cioè 42 anni, nelle nostre comunità di Roma. Dal 1962, rimane per alcuni anni a S. Pancrazio dove incontra P. Armido Gasparini, superiore e procuratore presso la S. Sede... e lo aiuta. Coprirà la carica di vice superiore ed economo, ma si dovrà fermare nuovamente per curare i polmoni. La sua via crucis ha tre principali stazioni: Arco, Morbegno (Sondalo) e soprattutto Roma (Ospedale Forlanini 1964-1970). Quasi un miracolo, certo una grazia la sua guarigione che gli permette - con le dovute attenzioni - di vivere altri 32 anni. È assistente del procuratore generale: persona di assoluta fiducia e discrezione, di un instancabile servizio verso tutti. Nella primavera del 2003, quando da alcuni anni viveva quotidianamente con l'aiuto dell'ossigeno, viene colpito da una gravissima crisi respiratoria. Si riprende e può essere trasportato a Milano nella nostra comunità dove sembra rivivere ed è felice di poter concelebrare e vivere con i confratelli. Ma è una tappa molto breve: si spegne serenamente la sera del 4 agosto.
Luci autobiografiche
Senza pretesa di completezza si presentano stralci dei suoi scritti che svelano la sua storia assieme ad un indiscusso stile brioso.
Da Sunningdale scrive a P. Antonio Todesco (24.7.1948) al termine del noviziato chiedendo di essere ammesso ai voti: “Reverendissimo padre, un giorno il Signore è venuto anche a me, mi ha trovato, sperduto fra i monti, piccolo essere in preda di tanti nemici, e, come ho sempre creduto, anche a me ha rivolto le grandi parole: “Vieni e seguimi”. Di casa in casa, sempre amato ed aiutato, ho finito qui, in questo caro noviziato, che ora per me volge ormai al termine. In questi due anni, specialmente, ho potuto penetrare, sorretto dalla grazia e dai miei ottimi superiori, ciò che questa mia grande vocazione mi impone...”.
Un anno dopo sempre da Sunningdale chiede di rinnovare i voti ed ha questo significativo passaggio:
“... Amatissimo padre, mi sento tanto felice nel trovarmi su questa via, di essere Figlio del Sacro Cuore: ne ringrazio il Signore e tutti coloro che mi hanno aiutato. Ringrazio lei particolarmente per avermi ammesso nella Congregazione”.
Le montagne che aveva lasciato e le persone care restavano scolpite nella sua mente, se negli anni 1990 scriveva articoli sulla pubblicazione locale “Comunità Valtartano” che ci permettono - in brevi scorci - di ricostruirne la biografia e scoprirne i sentimenti.
Il ritorno a casa: “Il mio momento magico arriva subito dopo la stazione di Colico, quando il treno volta risolutamente verso destra: dal finestrino scruto lungo la valle fino a che non appare un costone di montagna che invade la pianura e sembra volerla chiudere. Senza scorgere i dettagli la mia fantasia galoppa. Vedo la strada che sale a zigzag, il gruppetto di case... tra queste la mia. Invisibile dal treno ma per me chiarissima: con la corte, la legna addossata alla parete, la scaletta sul lato esterno, il poggiolo…”.
Poi ricorda i fatti dell’infanzia: “Ricordo bene la strada che sale a svolte sul dorsale della montagna. L'ho percorsa tante volte e, quasi sempre con un carico sulle spalle. Assieme ai miei fratelli e sorelle si suddivideva il quintale di farina gialla riempiendo i nostri sacchi secondo il peso che ciascuno poteva portare. Il peso poggiava sulle spalle, mentre le mani sorreggevano il sacco ai due lati. Così si percorreva tutta la mulattiera: percorso duro, fatto per lo più in silenzio, i più giovani avanti...”.
Una nota gioiosa per i mesi estivi: “A giugno, la mia famiglia si trasferiva nel maggengo, cioè l'alpeggio, in Frasnì. Si portava l'occorrente per oltre due mesi: gli utensili di casa, qualche coperta, le galline, il gatto, la mucca... che era tutta la nostra ricchezza. La vita era scandita dal lavoro nei prati e dalla cura delle bestie. Di domenica si tornava al paese per la messa ed il catechismo...”.
Un commosso ricordo del papà: “Mio padre passava i mesi estivi in Svizzera per la stagione del taglio e raccolta del fieno. Tornava alla fine di agosto. Arrivava brandendo la falce come suo trofeo, indossava una camicia nuova con l'immancabile zaino in spalla. Portava sempre qualcosa, oltre ad un certo gruzzolo ben sudato e guadagnato... L'ultimo ricordo del babbo. Lo rivedo seduto sullo sgabello in mezzo alla cucina in un caldo pomeriggio. Lo sguardo assente, lontano, completamente assorto nei suoi pensieri. Terminate le sue stagioni in Svizzera, finito il lavoro di muratore in Val Gerola... Forse si sentiva ormai finito, al termine della sua vita di sacrifici, di tante rinunce, di lavoro senza ferie e senza ‘buona uscita’. Era arrivata per lui la conclusione della sua vita, un'esistenza stentata e sacrificata propria di tutto il paese fino al presente. Era giunto il tempo di concludere, di abbassare le braccia e di ritirarsi in silenzio, senza un lamento, per dare posto alla nuova generazione”.
La mamma, la ricorda per le sue premure: “Aspettavo il corredo. Preparato da mamma e sorelle e messo nel baule, sacrificato dalla famiglia per questo scopo. Arrivò a destinazione a Rebbio dopo qualche tempo. Quando mi fu consegnato lo aprii con trepidazione. Tra il vestiario trovai due paia di calze rigonfie e le accarezzai. Contenevano la noci, i buoni frutti del nostro noce sopra la casa. Li aspettavo, la mamma me li aveva promessi. Forse nel baule c'erano anche le caramelle, ma per me, in quel momento, quelle noci non ancora secche valevano più di qualsiasi dolciume”.
Infine un ricordo riconoscente al parroco: “Ricordo con riconoscenza Don Siro Cabello mio parroco e solerte sostenitore della mia vocazione sacerdotale-missionaria, fin dagli anni della seconda guerra mondiale. Fu lui che mi accompagnò a Rebbio di Como, nel lontano 1942 e mi presentò al superiore di quel nostro piccolo seminario. Più volte venne a farmi visita e mi riaccompagnò a casa per le vacanze estive, assieme al nutrito stuolo dei miei compagni valtellinesi. Durante le vacanze, per quel mesetto che potevo trascorrere a Campo il buon parroco non mi perdeva di vista. Un anno egli mi ospitò in canonica per la notte. Con lui e qualche altro seminarista ebbi modo di far visita alle montagne ed agli alpeggi. Al mattino messa all'aperto, al cospetto delle cime tutt'intorno. Curava molto la catechesi in parrocchia per ogni categoria: piccoli, giovani ed adulti. Costruì davvero una parrocchia cristiana”. Non ci si meraviglia se l'identità cristiana fosse già saldamente radicata in lui che proveniva da un simile ambiente cristiano.
Testimonianze dei confratelli
Era unanime la stima di cui godeva sia nella comunità che presso le persone che lo avvicinavano: religioso di grande pietà, servizievole fino al sacrificio, paziente nell'infermità, discreto e silenzioso. Manifestava la gioia di essere Comboniano.
Le tre testimonianze che vengono presentate sono state scritte da confratelli che, a titolo diverso, gli sono stati vicino e hanno condiviso con lui la vita di comunità.
P. Pietro Chiocchetta scrive: “I miei ricordi di P. Bianchini risalgono al periodo del mio insegnamento nello scolasticato di Venegono: 1949-1953. Venne un giorno a trovarlo suo papà che lo rievocava: fisicamente, nella modestia, nella semplicità. Si adattò all'ospitalità del 'castello' non ancora attrezzato, ma grandemente superato dalla sensibilità di accoglienza. Lo ricordo come studente molto preciso: un certo ‘stile inglese’ nel comportamento, il tatto nell'incontro e nella collaborazione anche nei lavori più umili. Certo i due scolastici inglesi Cristoforo Hierons e Stanislao Woods vennero molto aiutati da lui. Non ricordo quando si ammalò, lavorando con gli scout. Ricordo bene che a Roma P. Gabriele Bevilacqua mi chiese s e potevo motivare il curriculum di studi per l'assenza di certi esami (ero stato a Venegono prefetto degli studi). Non solo non ebbi difficoltà, ma elogiai i talenti del soggetto. Mi giunse, tempo dopo, una lettera di P. Pietro: discretamente aveva saputo del mio interessamento e ringraziava. Questo suo 'andare in punta di piedi', affrontare con coraggio la malattia, il suo riuscire a vincere fino alla fine le resistenze, e nel frattempo rispondere silenziosamente e costantemente alle richieste anche più importune, fu uno stile che mai smentì negli anni romani. Personalmente conservo ancora il foglio di riduzione ferroviaria da lui dattiloscritto per partire il 15.2.1964 per Verona, appena giunta la notizia della morte di mia mamma. Preparavo velocemente la borsa da viaggio, batté alla porta della mia stanza a S. Pancrazio: mi presentò il documento con un breve inchino e una parola di cristiano coraggio, ritirandosi poi subito. Quest'episodio sul suo stile è modello di tutto un vissuto con i vari procuratori generali (P. Armido Gasparini, P. Domenico Ghirotto, P. Antonio Valdameri, P. Romeo Ballan) con vivo senso di corresponsabilità. Ricordo com'era stimato e di lui ci si fidava pienamente presso i vari dicasteri che frequentava. Era un 'servizio' che illustrava positivamente l'Istituto. Era la 'perla silenziosa e nascosta' della casa generalizia a Roma: della sua gentilezza, qualità apparentemente poco espansiva ma franca e sempre concludente, ebbero esperienza (forse dimenticata) quanti da tutte le missioni ebbero a trattare (o meglio a ricorrere) a lui.
Quando approfittavo d'un suo servizio, nella piccola auto, sempre il S. Rosario irrigava l'andare e il venire. E chi non ricorda quella piccola figura che ogni pomeriggio si calava a lungo nelle sue pratiche di pietà? Affioravano gli insegnamenti di famiglia, del noviziato, degli esercizi annuali. E tutto questo non per consuetudine, ma a ragion veduta e con senso critico.
Ebbe modo di fare un giro in Africa (Sidamo, Etiopia): continuava e ripetere che non poteva non essere riconoscente ai superiori per questo bel dono… 'per quel poco che faceva'.
Concludo ricordando come vibrasse spiritualmente quando parlava del suo paese natale, della sua terra. In noviziato più volte l'ho visto rileggere la biografia di Fr. Giosuè dei Cas che riecheggiava luoghi d'origine. Presso i quali, dopo la morte, si vide quanto fosse ricordato. ‘Il giusto sarà sempre ricordato’. Questo l'epitaffio sul vissuto umile e forte di P. Pietro, uno di quei 'piccoli' ai quali si rivelano dall'alto i misteri del Regno”.
La seconda testimonianza è di P. Tarcisio Agostoni che, Superiore Generale, nel 1970 accolse la proposta di P. Armido Gasparini di tenere P. Bianchini a Roma. Egli, in quell'anno, lasciava dopo una lunga cura l'ospedale Forlanini di Roma.
“Si dice che il 50% del lavoro nelle curie degli Istituti religiosi è portato avanti da persone che hanno disturbi di salute. Uno di questi fu P. Bianchini. Faceva fatica a vivere, non godendo della piena funzione dei suoi polmoni. Ma la volontà di vivere e di realizzarsi come Comboniano, era la sua molla. E visse da religioso-missionario prezioso nel suo genere. Ogni mattino la sua piccola auto era piena di commissioni ricevute dalla casa e dalle missioni: librerie, banche, negozi di oggetti religiosi, benedizioni papali ecc., questo era il suo solito giro. Ogni giorno la mattinata era piena. Nel pomeriggio doveva riposarsi, è vero, ma era pure occupato ad addebitare, accreditare e scrivere ai confratelli. Questo lavoro aveva un fiume nascosto, una centralina di energia che produceva corrente continua: la sua preghiera, il suo silenzio ed il suo amore. Il silenzio nutriva la preghiera e questa il suo amore. Ascoltava ma passava silenzioso tra i chiassosi confratelli. Sembrava si isolasse: ma era con Dio e per mezzo di Lui era con i confratelli. Anche i Comboniani hanno la memoria corta e molti non si cureranno di lui. Ma chi lo ha conosciuto non si dimenticherà di lui perché vive nel ricordo della sua carità senza preferenze”.
P. Romeo Ballan è, in ordine di tempo, l'ultimo dei procuratori generali presso la S. Sede con cui collaborò: “ ‘Ho sempre un grato ricordo di Roma’. Sono le ultime parole di una lettera che P. Pietro Bianchini mi scrisse da Milano in data 28 luglio 2003, una settimana prima del suo viaggio definitivo, lui che di viaggi in Italia ne aveva fatti veramente pochi. Se si eccettuano i tre anni trascorsi a Sunningdale, Inghilterra, (uno da novizio e due da scolastico filosofo), i suoi viaggi sono stati in Italia, quasi solo in funzione della sua salute. Lo ricordo quando era giovane sacerdote e si muoveva tra i sanatori per malati di polmoni, ad Arco (Trento), Sondalo (Sondrio), Forlanini (Roma)... È l'aspetto più appariscente della sua vita, che, dall’esterno, qualcuno poteva forse giudicare di poco conto per la Missione.
Lui era cosciente del limite della sua salute gracile, sapeva di non poter fare grandi cose o assumere responsabilità di governo. Aveva accettato con serenità la sua situazione. Ho sempre ammirato la sua umiltà, associata al desiderio di essere utile agli altri, anche in cose piccole: comprare un libro, spedire dei bolli agli appassionati, procurare una benedizione papale a chiunque glielo chiedeva, rispondere ai benefattori dei missionari e della procura generale... E tutto, sempre, in punta di piedi, senza ostentazione, senza lamentarsi. Era contento di poter aiutare chiunque, dal Superiore Generale allo scolastico appena, arrivato a Roma.
Nella sua vita di preghiera era fedele e puntuale: la recita completa della liturgia delle ore, la S. Messa ogni mattina, l'adorazione quotidiana in chiesa, i suoi rosari ogni giorno, la visita al Santissimo ogni sera prima di coricarsi... Negli ultimi tre anni che ho vissuto accanto a lui di stanza e di ufficio, potevo sapere che ora era, senza bisogno di guardare l'orologio; mi bastava vedere cosa stava facendo o pregando.
Un altro valore che P. Bianchini ha sviluppato nella sua vita è la fedeltà amorosa al Santo Padre e alla Chiesa universale e missionaria. Egli che, per ragioni d'ufficio, bazzicava per il Vaticano e botteghe varie, non era per nulla interessato ai pettegolezzi curiali, ai commenti leggeri. Non vi prendeva parte e non li riportava; tirava diritto per le sue cose.
Pur essendo riservato e delicato nel comportamento in comunità e fuori, corrispondeva volentieri ai saluti con una parola, un sorriso, un gesto della mano. Era una persona austera nelle sue scelte personali, ma sostanzialmente serena: una serenità che affondava le radici nella preghiera e nell’amicizia con il Signore”.
A rappresentare tutti coloro che, fuori dell'Istituto hanno conosciuto ed ammirato P. Pierino è P. Luigi Speziale, religioso bétharramita (S.C.J.) nato nella stessa frazione di Dosso, insegnante al Seminario Patriarcale di Gerusalemme. Egli ha curato sul bollettino Comunità, delle parrocchie di Tartano, Campo e Sirta (ottobre 2003), il necrologio dal titolo: “Un 'bel' prete missionario”. Ecco alcuni brani: “Nel contesto di una scelta vocazionale il parroco don Siro guidò un gruppo di adolescenti di Campo al pre-seminario di Valle di Colorina, voluto da Don Folci. Pierino era fra questi ragazzi. Don Folci fermò lo sguardo proprio su di lui e, coprendolo col suo ampio mantello nero, disse: ‘Questo sarà prete!’. Ed ebbe ragione. Se è vero che la vocazione dei figli nasce prima nel cuore delle madri, dobbiamo pensare che così sia stato anche per la mamma Rosa che pregava e desiderava dare un figlio al Signore, ma le parole di Don Folci favorirono lo schiudersi e il maturare di questa vocazione di rara bellezza.
… Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1954 a Milano, dal Beato Card. Schuster. Ero bambino ma ricordo bene che sua mamma aveva messo un vestito nuovo per riceverlo meglio: per lei era una grande festa. Quel giovane sacerdote nelle sue celebrazioni pareva un angelo. Io ne provavo una santa invidia e dicevo tra me: un giorno voglio essere come lui!... Ero presente in casa sua la mattina in cui P. Pierino, dopo la morte della mamma, dava l'addio ai suoi cari in lacrime. Egli, forte e sereno, seppe vincere la commozione e disse solo: ‘Quando Dio concede ad una famiglia una grazia grande come quella del dono di un sacerdote, chiede sempre qualche sacrificio!’. Per lui il sacrificio è stato continuo ed intenso, anche se le sue spalle erano deboli... Ho definito P. Pierino, nel titolo di questo mio ricordo, come 'bel' prete - un'espressione cara a Don Giovanni Rossi della Pro Civitate Cristiana di Assisi -, cioè un prete riuscito, un vero amico di Dio e degli uomini...
Vero figlio di S. Daniele
Nel mese di maggio del 1946, Pierino, dalla scuola apostolica di Brescia, indirizzò a P. Antonio Vignato la domanda per essere ammesso al noviziato, insolitamente lunga, quattro facciate. Alcuni passaggi aiutano a comprendere la dimensione missionaria e comboniana della sua vocazione: “Il mio noviziato dovrà formare, plasmare l'anima mia, trasformandola in anima di sacerdote e di missionario... O missionario santo, o subito in paradiso: è la preghiera che ogni mattina rivolgo a Maria, sicuro di essere esaudito... Il Signore e la Madonna mi aiutino a non venir meno agli obblighi che questo passo richiede da me; Mons. Comboni guidi l'anima mia e la trasformi come deve essere un'anima dei suoi figli”.
A questa sicurezza e determinazione giovanile, fa riscontro un'affermazione dell'ultima settimana di vita: “Oramai sono nel numero dei nostri ammalati, ma felice di poter concelebrare la Messa. Comunque sono sempre Missionario Comboniano e son ben contento di esserlo”. Come si sia attuato il suo 'essere missionario' è stato già detto. Va aggiunto che negli anni sessanta era stato destinato all'Uganda: non poté partire. Le ricorrenti crisi a causa della delicata salute convinsero i superiori a cancellare la destinazione. Visse nelle comunità di Roma lavorando per le missioni e fra il dicembre 1976 e il gennaio 1977 si realizzò il suo sogno di visitare l'Africa. Mons. Armido Gasparini era prefetto Apostolico di Awasa, in Etiopia. Per molti anni, fino al 1973, procuratore a Roma, aveva aiutato P. Pierino e lo aveva sostenuto nella sua malattia. Il diario che scrisse al termine di quella sua esperienza lo destinò solo ai familiari e ne siamo venuti a conoscenza solo ora. Inizia con questa premessa: “Nessuna pretesa di essere completo in questo mio diario: solo impressioni di un missionario che per la prima volta, a 48 anni d'età, ha la fortuna e la gioia di poter vedere con i suoi occhi un’autentica missione ai suoi inizi, ricca di speranza per abbondanti frutti evangelici”. Questo incipit introduce bene l'atteggiamento interiore di P. Pierino che si stupisce, vede tutti i protagonisti, i Sidamo, le suore, i catechisti, i missionari in una luce eroica, in una lotta contro elementi ostili.
Un iniziale e commosso pensiero, durante la sosta dell'aereo a Khartoum, alle 3.30 del mattino, è per il Comboni, ora S. Daniele: “Mentre atterravamo la città di Khartoum mi sembrò, nel buio, un 'collage' di brillanti o una grossa perla risplendente di tutti i colori posta sul cuore di questa bella signora che ha nome Africa. L'Africa di Mons. Comboni! Qui a Khartoum questo grande apostolo lavorò intensamente, pronunciò parole di intensissimo amore per i suoi Neri e parole forti, indignate all'indirizzo di politici, di colonialisti, di negrieri. Qui egli concluse la sua vita terrena a cinquant'anni, e qui i suoi figli e figlie si avvicendano per continuarne l'opera. In questa calda e assonnata ora del mattino, mettendo piede sul suolo africano, avrei dovuto inginocchiarmi a baciare quella terra. Così facevano i missionari del passato. Ne fui dissuaso alla vista dei soldati che imbracciavano il mitra. Non era più quello il deserto percorso dalle carovane, e dov’erano i moretti tanto cari al Comboni, indifesi, abbandonati, facile preda degli schiavisti? A un secolo di distanza tutto è cambiato e trasformato. Il progresso, vero o falso, ha cancellato - o forse solo coperto - le lacrime e le fatiche del Comboni. Tocca ora ai suoi discepoli far sentire nuovamente quella voce calda di amore. Dopo un'ora di sosta l'aereo decolla e mi piace, guardando dall'oblò, pensare al Comboni come ad una di quelle perle che ancora brillano giù sotto, la più luminosa”.
Le visite alle comunità-missioni dei Sidamo coincisero con gli ultimi giorni di avvento e col Natale etiopico (7.01.1977). Awasa, Tullo, Dongora, Dilla, Fullasa, ecc. sono descritte nei loro particolari ma sono le persone ed il paesaggio che ci fanno capire ciò che lo colpisce. Le donne si caricano sulla schiena grosse anfore di acqua: durante la stagione secca spesso è perfino scarsa e non potabile. Ammira i catechisti “giovani che sanno comunicare nella loro lingua. Bravi giovani che hanno il compito di dare i primi colpi di zappa nel terreno vergine delle coscienze di questa gente... la loro”.
A Malekka partecipa ad una festa d'inaugurazione. Alla fine c'è un banchetto sul prato. Sono stati macellati due buoi. Noto un po’ timoroso e appartato, un lebbroso con il suo pezzetto di carne ben saldo tra le sue povere mani senza dita. Anche lui è venuto perché si sente figlio di Dio e invitato...”. Descrivendo il Natale si sofferma sulla vigilia, le confessioni, i preparativi. Commenta la festa: “Arrivano a gruppi; con la bandiera, cantando e pregando. Hanno percorso 10, 20 km. pur di essere presenti alla messa di Natale. Certo il Signore nasce volentieri in mezzo a loro: povero come loro, dimenticato come loro”. Delle suore è stupito perché le vede più disinvolte delle loro consorelle conosciute in Italia: sempre pronte nella loro divisa kaki ed una ha perfino un cavallo… è infermiera e se ne serve per le emergenze. Fratelli e padri li descrive capaci di tutto e disposti a tutto. Ne nomina e descrive uno che rappresenta tutti: “Cappellaccio ben calcato sulla fronte, viso stagionato dal sole, la barbetta caprina, il vestito polveroso e due scarponi che conoscono polvere e fango. Pedala per ore: si ferma solo quando è circondato dalla gente. Se può li aiuta, sempre li conforta”. Diamogli infine la parola per la conclusione: bella, singolare e di non facile interpretazione: “Sono rientrato in Italia e volente o nolente mi sono rituffato nel caos della nostra cosiddetta civiltà. Ma il ricordo è rimasto laggiù, tra i Sidamo. L'ambiente che ho visto ha una sua nota di durezza, di primordiale. I grilli, di sera e per buona parte della notte, non cantano, stridono, con prepotenza, da padroni. Gli uccelli, moltissimi e dalle forme e colori i più svariati, fanno solo versacci, come anime in pena. Perfino le stelle guardano giù dal cielo - un cielo troppo intensamente azzurro - con durezza, sono troppo scintillanti, forse per orgoglio, forse perché se ne infischiano delle nostre povere cose e avvenimenti umani? E direi che la gente di laggiù da loro la pariglia: ci sono forse poeti romantici che cantano alle stelle? Temo che la gente abbia altro da pensare. Le piante son contorte, sacrificate, in lotta perenne con l'arsura della stagione asciutta e con gli uragani della stagione delle piogge. Niente pace, solo un senso di relativo equilibrio fondato sulla lotta per la sopravvivenza. Come per i Sidamo”.
Consegnare la memoria
Si parla spesso della memoria storica, della tradizione e se ne asserisce l'importanza. L'acquisizione e la trasmissione sembrano fatti scontati e quasi automatici. Non è così. Ogni Comboniano dovrebbe sentire il dovere di lasciare, se non un testamento spirituale formale, una testimonianza sulla sua vita. Possediamo 14 volumi dei diari della vita missionaria di P. Giuseppe Zambonardi. Abbiamo i diari spirituali ricchi - ed inediti - di Fr. Angelo Viviani. Così pure P. Roberto Cona ha scritto della sua esperienza umana e spirituale. Si potrebbero citare altri nomi: ma non molti. Mentre viene steso questo necrologio giunge la notizia della scomparsa di Fr. Giovanni Zucchelli: egli è il defunto N. 1075 nella storia dell'Istituto. Questa numerosa comunità di 'viventi in Dio' e composta, per noi, di persone - in gran parte - sconosciute. P. Pierino ci aiuta a prendere coscienza di questo aspetto importante della nostra identità comboniana. Dai suoi scritti vengono tolti alcuni testi: lui che è vissuto in silenzio, ora ci parla.
Da una lettera scritta nel dicembre 1953 ai suoi compagni: “Carissimi confratelli diaconi, volge al termine la nostra ascesa al sacerdozio, la meta è a pochi passi. Sono passati 14 anni da quando la porta del seminario si è aperta con un sogno in cuore: diventare sacerdoti. Alcuni di noi passarono tutti questi anni insieme: lotte, sofferenze, speranze e gioie ce le dividemmo, come ci dividemmo il pane. Soprattutto fummo sempre un cuor solo. Il segreto della nostra unione è stata sempre Maria. Un gruppo di noi ha pensato, prima che sopraggiungano le preoccupazioni della vigilia, ad alcune semplici iniziative: preghiera quotidiana vicendevole: un’ora del breviario; ogni anno, possibilmente nello stesso giorno, una Messa per la classe; una Messa di suffragio, oltre a quella della regola, per chi ci precede; tutti ci impegniamo a diffondere la devozione mariana.” Lui ci ha lasciato nel 49° anno di sacerdozio...
Programma dell'ordinazione: “Sacerdote missionario religioso. Il mio ideale: Gesù il più bello dei figli degli uomini. Il mio proposito: amare Gesù con passione, rinchiuso nel suo Cuor. La mia lotta: combattere tutto ciò che può rovinare la mia vocazione. Il mio programma futuro: fedeltà al ministero secondo l'obbedienza. La mia domanda: consumare la mia esistenza per Gesù, con Maria”.
La sua visione cristocentrica e mariana lo porta - certo con il lessico e lo stile datato del suo tempo - all'essenziale, come in questo pensiero scritto durante un ritiro: “In che cosa consiste l'eroismo della santità? Nel compiere con costanza il proprio dovere: ha un immenso valore. Il mio dovere ogni giorno: ecco quello che vuole da me il Signore. Messo davanti alle responsabilità e ai sacrifici futuri confiderò in Dio: con Lui posso tutto. Fiaschi ne fanno tutti: perché allarmarsi? Accetto con rassegnazione dalle mani di Dio e tutto finirà a mio vantaggio”. Si sente in queste righe la croce pesante dei lunghi anni di degenza per la malattia... Il tema più ricorrente nei suoi scritti è quello della preghiera che si può riassumere in alcune sue brevi espressioni: “Il Signore non ha bisogno di molte parole... Vi sono dei gradi della preghiera: occorre progredire... Il raccoglimento e il silenzio preparano la preghiera...
La mia meditazione deve essere personale, pratica, che diriga la giornata. Solo la preghiera ed il sacrificio mi formeranno”.
Da un suo articolo su “Comunità Valtartano” (ottobre 1989), dal titolo: “La Madonnina della Caiurga”, che ricorda un’effigie della Madonna posta su una roccia, vicino alla strada. Poi la descrizione si fa preghiera: “Vergine benedetta, tu mi hai visto tante volte passare fanciullo con il mio carico sulle spalle diretto all'alpeggio e alla contrada, da solo, o più spesso con la mamma o papà e con i fratelli e sorelle, con i cugini. Hai accettato benevola il nostro breve saluto con comprensione materna, quando noi ragazzi ci attardavamo in cerca di lamponi. Tu hai sempre nei tuoi occhi materni la processione di uomini e donne con in spalla gli zaini o le gerle. Ti voglio oggi pregare: radunaci per un momento accanto a te. I vivi, ormai fatti anziani e con il loro carico di ricordi, di esperienze di vita, di anni passati lontano in terra straniera. Ti vogliamo dire che ritorniamo a te volentieri per offrirti la nostra vita con le sue ferite e gioie. Tu tutto accetti, tutto perdoni e ci consoli. E i cari morti: i figli ed i nipoti ti dicono tutta la loro riconoscenza per loro. Tu resti sempre al tuo posto, Vergine vigilante. Tu sai tutto del mio e nostro passato, e del presente e del futuro. Pensaci o Madre benedetta e non abbandonarci.”
Verso la patria in comunione con i suoi
“Ti lodino i popoli, o Dio ti lodino i popoli tutti” (Salmo 66,8) sono le parole che P. Pierino scelse per la sua immagine ricordo dell'ordinazione e continuava chiedendo alla Madonna di ricompensare parenti, superiori e benefattori. La sua vita ha continuato a svolgersi in questo orizzonte, anche se non apparivano evidenti i segni esterni di appartenenza. Scrivendo alla nipote Rosangela, nel giugno 1996, si scusava di non essere stato presente al funerale di Remo: “Ho seguito questo avvenimento nel silenzio della casa religiosa e in preghiera, e mi sono sentito molto vicino a Remo e agli altri nostri cari defunti. Come per il funerale di Remo, fratello che lui amava molto, così per altre circostanze da più di 10 anni non era tornato al paese. Egli portava come primo nome quello di Marcello, lo zio paterno che era emigrato in Australia. Con i figli e con un duro lavoro era diventato un noto costruttore: lo invitò in Australia ma egli non vi andò. Il legame si era ulteriormente stretto perché Justin Joseph, figlio di Marcello entrò in seminario a Perth, fu ordinato nel 1964 e dal 1992 è vescovo di Geraldton, diocesi suffraganea di Perth. Per lui scrisse un lungo articolo sulla rivista della valle che termina così: “La parentela di Campo gli è vicina con l'affetto e la preghiera e con un tantino di orgoglio, scusabile, vero? E penso che sia lo stesso per la popolazione della valle. Perché dopo tutto è il primo successore degli apostoli di questi paraggi”. P. Pierino era fatto così: vigile e contento di essere unito ai suoi con la preghiera ed il ricordo. A Milano sentiva la nostalgia di Roma e scriveva: “Mi sarebbe piaciuto morire a Roma ed essere sepolto assieme, si fa per dire, ai papi ed ai vescovi e sacerdoti e fedeli della capitale della cristianità. Sarò con loro, in ogni modo, dopo la mia morte”.
Ora che riposa fra i suoi monti salutiamolo con le parole di P. Luigi Speziale: “P. Pierino, ora che godi della vista. di Dio Trinità, non dimenticare il tuo paese, la tua parrocchia, i giovani, i ragazzi: ottieni che ci sia ancora qualcuno, generoso come te, che accetti di prendere il tuo posto, in quell’avventura che è lasciare tutto per seguire il Signore”. (P. Pietro Ravasio, mccj)
Nelle settimane di assistenza a Roma, durante la sua grave crisi respiratoria, le sorelle ed i familiari lo chiamavano con il nome affettuoso di Pierino che poteva maggiormente richiamarlo alla consapevolezza. Facendone memoria, useremo questo appellativo che indica quanto sentisse di appartenere ancora alla sua famiglia mentre viveva l’identità comboniana nell'Istituto.
Di fronte alla sua vita si rimane sconcertati e ci si chiede, come le anziane consorelle di S. Teresina del Bambino Gesù, “cosa si potrà dire di lei?”. Anche P. Pierino è come un iceberg: appare solo un’insignificante punta galleggiante. Per svelarne i principali valori che entreranno nel patrimonio spirituale dell'Istituto e costituiranno pure un consolante ricordo per la numerosa famiglia che ha lasciato, abbiamo due fonti. La prima sono i suoi diari e gli articoli che ha scritto per la sua amata Val Tartano. La seconda è costituita da alcune testimonianze sia documentarie che di confratelli che gli sono stati particolarmente vicini. Un'ultima premessa può essere utile. Egli è vissuto quasi nascosto e senza far sentire la sua voce, contemporaneamente si è fatto presente con i suoi servizi puntuali e perseveranti in ogni angolo dell'Istituto e a servizio di non poche Chiese locali di missione.
La trama della sua vita
Ci teneva a specificare di appartenere alla diocesi di Como, alla provincia di Sondrio, al comune di Tartano e alla parrocchia di Campo (patrono S. Agostino) ed era nato nella frazione di Dosso il 19 gennaio 1928. Era cresciuto sotto la vigile cura di mamma Rosa e papà Egidio con altri tre fratelli e quattro sorelle. Terminate le elementari, entra nella scuola apostolica di Como nel 1942 prima che fosse aperta la sede di Rebbio. Ve lo conduce lo stesso parroco, Don Siro Cabello. Prosegue la sua formazione a Crema e poi a Brescia: viene ammesso al noviziato con l'unico punto interrogativo della salute. Nel settembre 1946 è affidato alle cure di P. Stefano Patroni, a Firenze. Uno straordinario maestro spirituale che lo capisce e scrive: “Ha delle belle qualità per diventare un buon religioso e missionario. Sente molto il distacco dalla famiglia”. I superiori, successivamente, lo inviano per il secondo anno di noviziato a Sunningdale dove emette i primi voti il 7 ottobre 1948 e vi rimane per i corsi di filosofia. Ritorna in Italia, a Venegono, dal 1950 al 1954 , nel nostro scolasticato studia teologia. Emette i voti perpetui il 9 settembre 1953 ed è ordinato sacerdote dal Card. I. Schuster (ora Beato) a Milano, il 12 giugno 1954. Dal 1954 al 1960 è segretario prima di P. Antonio Todesco e poi di P. Gaetano Briani, Superiori Generali. Per la sua conoscenza dell'inglese e le sua capacità, è inviato in Inghilterra per la specializzazione in storia. Iscritto all'Università di Londra (1960-1962) deve interrompere gli studi per motivi ci salute. Da allora vivrà sempre, cioè 42 anni, nelle nostre comunità di Roma. Dal 1962, rimane per alcuni anni a S. Pancrazio dove incontra P. Armido Gasparini, superiore e procuratore presso la S. Sede... e lo aiuta. Coprirà la carica di vice superiore ed economo, ma si dovrà fermare nuovamente per curare i polmoni. La sua via crucis ha tre principali stazioni: Arco, Morbegno (Sondalo) e soprattutto Roma (Ospedale Forlanini 1964-1970). Quasi un miracolo, certo una grazia la sua guarigione che gli permette - con le dovute attenzioni - di vivere altri 32 anni. È assistente del procuratore generale: persona di assoluta fiducia e discrezione, di un instancabile servizio verso tutti. Nella primavera del 2003, quando da alcuni anni viveva quotidianamente con l'aiuto dell'ossigeno, viene colpito da una gravissima crisi respiratoria. Si riprende e può essere trasportato a Milano nella nostra comunità dove sembra rivivere ed è felice di poter concelebrare e vivere con i confratelli. Ma è una tappa molto breve: si spegne serenamente la sera del 4 agosto.
Luci autobiografiche
Senza pretesa di completezza si presentano stralci dei suoi scritti che svelano la sua storia assieme ad un indiscusso stile brioso.
Da Sunningdale scrive a P. Antonio Todesco (24.7.1948) al termine del noviziato chiedendo di essere ammesso ai voti: “Reverendissimo padre, un giorno il Signore è venuto anche a me, mi ha trovato, sperduto fra i monti, piccolo essere in preda di tanti nemici, e, come ho sempre creduto, anche a me ha rivolto le grandi parole: “Vieni e seguimi”. Di casa in casa, sempre amato ed aiutato, ho finito qui, in questo caro noviziato, che ora per me volge ormai al termine. In questi due anni, specialmente, ho potuto penetrare, sorretto dalla grazia e dai miei ottimi superiori, ciò che questa mia grande vocazione mi impone...”.
Un anno dopo sempre da Sunningdale chiede di rinnovare i voti ed ha questo significativo passaggio:
“... Amatissimo padre, mi sento tanto felice nel trovarmi su questa via, di essere Figlio del Sacro Cuore: ne ringrazio il Signore e tutti coloro che mi hanno aiutato. Ringrazio lei particolarmente per avermi ammesso nella Congregazione”.
Le montagne che aveva lasciato e le persone care restavano scolpite nella sua mente, se negli anni 1990 scriveva articoli sulla pubblicazione locale “Comunità Valtartano” che ci permettono - in brevi scorci - di ricostruirne la biografia e scoprirne i sentimenti.
Il ritorno a casa: “Il mio momento magico arriva subito dopo la stazione di Colico, quando il treno volta risolutamente verso destra: dal finestrino scruto lungo la valle fino a che non appare un costone di montagna che invade la pianura e sembra volerla chiudere. Senza scorgere i dettagli la mia fantasia galoppa. Vedo la strada che sale a zigzag, il gruppetto di case... tra queste la mia. Invisibile dal treno ma per me chiarissima: con la corte, la legna addossata alla parete, la scaletta sul lato esterno, il poggiolo…”.
Poi ricorda i fatti dell’infanzia: “Ricordo bene la strada che sale a svolte sul dorsale della montagna. L'ho percorsa tante volte e, quasi sempre con un carico sulle spalle. Assieme ai miei fratelli e sorelle si suddivideva il quintale di farina gialla riempiendo i nostri sacchi secondo il peso che ciascuno poteva portare. Il peso poggiava sulle spalle, mentre le mani sorreggevano il sacco ai due lati. Così si percorreva tutta la mulattiera: percorso duro, fatto per lo più in silenzio, i più giovani avanti...”.
Una nota gioiosa per i mesi estivi: “A giugno, la mia famiglia si trasferiva nel maggengo, cioè l'alpeggio, in Frasnì. Si portava l'occorrente per oltre due mesi: gli utensili di casa, qualche coperta, le galline, il gatto, la mucca... che era tutta la nostra ricchezza. La vita era scandita dal lavoro nei prati e dalla cura delle bestie. Di domenica si tornava al paese per la messa ed il catechismo...”.
Un commosso ricordo del papà: “Mio padre passava i mesi estivi in Svizzera per la stagione del taglio e raccolta del fieno. Tornava alla fine di agosto. Arrivava brandendo la falce come suo trofeo, indossava una camicia nuova con l'immancabile zaino in spalla. Portava sempre qualcosa, oltre ad un certo gruzzolo ben sudato e guadagnato... L'ultimo ricordo del babbo. Lo rivedo seduto sullo sgabello in mezzo alla cucina in un caldo pomeriggio. Lo sguardo assente, lontano, completamente assorto nei suoi pensieri. Terminate le sue stagioni in Svizzera, finito il lavoro di muratore in Val Gerola... Forse si sentiva ormai finito, al termine della sua vita di sacrifici, di tante rinunce, di lavoro senza ferie e senza ‘buona uscita’. Era arrivata per lui la conclusione della sua vita, un'esistenza stentata e sacrificata propria di tutto il paese fino al presente. Era giunto il tempo di concludere, di abbassare le braccia e di ritirarsi in silenzio, senza un lamento, per dare posto alla nuova generazione”.
La mamma, la ricorda per le sue premure: “Aspettavo il corredo. Preparato da mamma e sorelle e messo nel baule, sacrificato dalla famiglia per questo scopo. Arrivò a destinazione a Rebbio dopo qualche tempo. Quando mi fu consegnato lo aprii con trepidazione. Tra il vestiario trovai due paia di calze rigonfie e le accarezzai. Contenevano la noci, i buoni frutti del nostro noce sopra la casa. Li aspettavo, la mamma me li aveva promessi. Forse nel baule c'erano anche le caramelle, ma per me, in quel momento, quelle noci non ancora secche valevano più di qualsiasi dolciume”.
Infine un ricordo riconoscente al parroco: “Ricordo con riconoscenza Don Siro Cabello mio parroco e solerte sostenitore della mia vocazione sacerdotale-missionaria, fin dagli anni della seconda guerra mondiale. Fu lui che mi accompagnò a Rebbio di Como, nel lontano 1942 e mi presentò al superiore di quel nostro piccolo seminario. Più volte venne a farmi visita e mi riaccompagnò a casa per le vacanze estive, assieme al nutrito stuolo dei miei compagni valtellinesi. Durante le vacanze, per quel mesetto che potevo trascorrere a Campo il buon parroco non mi perdeva di vista. Un anno egli mi ospitò in canonica per la notte. Con lui e qualche altro seminarista ebbi modo di far visita alle montagne ed agli alpeggi. Al mattino messa all'aperto, al cospetto delle cime tutt'intorno. Curava molto la catechesi in parrocchia per ogni categoria: piccoli, giovani ed adulti. Costruì davvero una parrocchia cristiana”. Non ci si meraviglia se l'identità cristiana fosse già saldamente radicata in lui che proveniva da un simile ambiente cristiano.
Testimonianze dei confratelli
Era unanime la stima di cui godeva sia nella comunità che presso le persone che lo avvicinavano: religioso di grande pietà, servizievole fino al sacrificio, paziente nell'infermità, discreto e silenzioso. Manifestava la gioia di essere Comboniano.
Le tre testimonianze che vengono presentate sono state scritte da confratelli che, a titolo diverso, gli sono stati vicino e hanno condiviso con lui la vita di comunità.
P. Pietro Chiocchetta scrive: “I miei ricordi di P. Bianchini risalgono al periodo del mio insegnamento nello scolasticato di Venegono: 1949-1953. Venne un giorno a trovarlo suo papà che lo rievocava: fisicamente, nella modestia, nella semplicità. Si adattò all'ospitalità del 'castello' non ancora attrezzato, ma grandemente superato dalla sensibilità di accoglienza. Lo ricordo come studente molto preciso: un certo ‘stile inglese’ nel comportamento, il tatto nell'incontro e nella collaborazione anche nei lavori più umili. Certo i due scolastici inglesi Cristoforo Hierons e Stanislao Woods vennero molto aiutati da lui. Non ricordo quando si ammalò, lavorando con gli scout. Ricordo bene che a Roma P. Gabriele Bevilacqua mi chiese s e potevo motivare il curriculum di studi per l'assenza di certi esami (ero stato a Venegono prefetto degli studi). Non solo non ebbi difficoltà, ma elogiai i talenti del soggetto. Mi giunse, tempo dopo, una lettera di P. Pietro: discretamente aveva saputo del mio interessamento e ringraziava. Questo suo 'andare in punta di piedi', affrontare con coraggio la malattia, il suo riuscire a vincere fino alla fine le resistenze, e nel frattempo rispondere silenziosamente e costantemente alle richieste anche più importune, fu uno stile che mai smentì negli anni romani. Personalmente conservo ancora il foglio di riduzione ferroviaria da lui dattiloscritto per partire il 15.2.1964 per Verona, appena giunta la notizia della morte di mia mamma. Preparavo velocemente la borsa da viaggio, batté alla porta della mia stanza a S. Pancrazio: mi presentò il documento con un breve inchino e una parola di cristiano coraggio, ritirandosi poi subito. Quest'episodio sul suo stile è modello di tutto un vissuto con i vari procuratori generali (P. Armido Gasparini, P. Domenico Ghirotto, P. Antonio Valdameri, P. Romeo Ballan) con vivo senso di corresponsabilità. Ricordo com'era stimato e di lui ci si fidava pienamente presso i vari dicasteri che frequentava. Era un 'servizio' che illustrava positivamente l'Istituto. Era la 'perla silenziosa e nascosta' della casa generalizia a Roma: della sua gentilezza, qualità apparentemente poco espansiva ma franca e sempre concludente, ebbero esperienza (forse dimenticata) quanti da tutte le missioni ebbero a trattare (o meglio a ricorrere) a lui.
Quando approfittavo d'un suo servizio, nella piccola auto, sempre il S. Rosario irrigava l'andare e il venire. E chi non ricorda quella piccola figura che ogni pomeriggio si calava a lungo nelle sue pratiche di pietà? Affioravano gli insegnamenti di famiglia, del noviziato, degli esercizi annuali. E tutto questo non per consuetudine, ma a ragion veduta e con senso critico.
Ebbe modo di fare un giro in Africa (Sidamo, Etiopia): continuava e ripetere che non poteva non essere riconoscente ai superiori per questo bel dono… 'per quel poco che faceva'.
Concludo ricordando come vibrasse spiritualmente quando parlava del suo paese natale, della sua terra. In noviziato più volte l'ho visto rileggere la biografia di Fr. Giosuè dei Cas che riecheggiava luoghi d'origine. Presso i quali, dopo la morte, si vide quanto fosse ricordato. ‘Il giusto sarà sempre ricordato’. Questo l'epitaffio sul vissuto umile e forte di P. Pietro, uno di quei 'piccoli' ai quali si rivelano dall'alto i misteri del Regno”.
La seconda testimonianza è di P. Tarcisio Agostoni che, Superiore Generale, nel 1970 accolse la proposta di P. Armido Gasparini di tenere P. Bianchini a Roma. Egli, in quell'anno, lasciava dopo una lunga cura l'ospedale Forlanini di Roma.
“Si dice che il 50% del lavoro nelle curie degli Istituti religiosi è portato avanti da persone che hanno disturbi di salute. Uno di questi fu P. Bianchini. Faceva fatica a vivere, non godendo della piena funzione dei suoi polmoni. Ma la volontà di vivere e di realizzarsi come Comboniano, era la sua molla. E visse da religioso-missionario prezioso nel suo genere. Ogni mattino la sua piccola auto era piena di commissioni ricevute dalla casa e dalle missioni: librerie, banche, negozi di oggetti religiosi, benedizioni papali ecc., questo era il suo solito giro. Ogni giorno la mattinata era piena. Nel pomeriggio doveva riposarsi, è vero, ma era pure occupato ad addebitare, accreditare e scrivere ai confratelli. Questo lavoro aveva un fiume nascosto, una centralina di energia che produceva corrente continua: la sua preghiera, il suo silenzio ed il suo amore. Il silenzio nutriva la preghiera e questa il suo amore. Ascoltava ma passava silenzioso tra i chiassosi confratelli. Sembrava si isolasse: ma era con Dio e per mezzo di Lui era con i confratelli. Anche i Comboniani hanno la memoria corta e molti non si cureranno di lui. Ma chi lo ha conosciuto non si dimenticherà di lui perché vive nel ricordo della sua carità senza preferenze”.
P. Romeo Ballan è, in ordine di tempo, l'ultimo dei procuratori generali presso la S. Sede con cui collaborò: “ ‘Ho sempre un grato ricordo di Roma’. Sono le ultime parole di una lettera che P. Pietro Bianchini mi scrisse da Milano in data 28 luglio 2003, una settimana prima del suo viaggio definitivo, lui che di viaggi in Italia ne aveva fatti veramente pochi. Se si eccettuano i tre anni trascorsi a Sunningdale, Inghilterra, (uno da novizio e due da scolastico filosofo), i suoi viaggi sono stati in Italia, quasi solo in funzione della sua salute. Lo ricordo quando era giovane sacerdote e si muoveva tra i sanatori per malati di polmoni, ad Arco (Trento), Sondalo (Sondrio), Forlanini (Roma)... È l'aspetto più appariscente della sua vita, che, dall’esterno, qualcuno poteva forse giudicare di poco conto per la Missione.
Lui era cosciente del limite della sua salute gracile, sapeva di non poter fare grandi cose o assumere responsabilità di governo. Aveva accettato con serenità la sua situazione. Ho sempre ammirato la sua umiltà, associata al desiderio di essere utile agli altri, anche in cose piccole: comprare un libro, spedire dei bolli agli appassionati, procurare una benedizione papale a chiunque glielo chiedeva, rispondere ai benefattori dei missionari e della procura generale... E tutto, sempre, in punta di piedi, senza ostentazione, senza lamentarsi. Era contento di poter aiutare chiunque, dal Superiore Generale allo scolastico appena, arrivato a Roma.
Nella sua vita di preghiera era fedele e puntuale: la recita completa della liturgia delle ore, la S. Messa ogni mattina, l'adorazione quotidiana in chiesa, i suoi rosari ogni giorno, la visita al Santissimo ogni sera prima di coricarsi... Negli ultimi tre anni che ho vissuto accanto a lui di stanza e di ufficio, potevo sapere che ora era, senza bisogno di guardare l'orologio; mi bastava vedere cosa stava facendo o pregando.
Un altro valore che P. Bianchini ha sviluppato nella sua vita è la fedeltà amorosa al Santo Padre e alla Chiesa universale e missionaria. Egli che, per ragioni d'ufficio, bazzicava per il Vaticano e botteghe varie, non era per nulla interessato ai pettegolezzi curiali, ai commenti leggeri. Non vi prendeva parte e non li riportava; tirava diritto per le sue cose.
Pur essendo riservato e delicato nel comportamento in comunità e fuori, corrispondeva volentieri ai saluti con una parola, un sorriso, un gesto della mano. Era una persona austera nelle sue scelte personali, ma sostanzialmente serena: una serenità che affondava le radici nella preghiera e nell’amicizia con il Signore”.
A rappresentare tutti coloro che, fuori dell'Istituto hanno conosciuto ed ammirato P. Pierino è P. Luigi Speziale, religioso bétharramita (S.C.J.) nato nella stessa frazione di Dosso, insegnante al Seminario Patriarcale di Gerusalemme. Egli ha curato sul bollettino Comunità, delle parrocchie di Tartano, Campo e Sirta (ottobre 2003), il necrologio dal titolo: “Un 'bel' prete missionario”. Ecco alcuni brani: “Nel contesto di una scelta vocazionale il parroco don Siro guidò un gruppo di adolescenti di Campo al pre-seminario di Valle di Colorina, voluto da Don Folci. Pierino era fra questi ragazzi. Don Folci fermò lo sguardo proprio su di lui e, coprendolo col suo ampio mantello nero, disse: ‘Questo sarà prete!’. Ed ebbe ragione. Se è vero che la vocazione dei figli nasce prima nel cuore delle madri, dobbiamo pensare che così sia stato anche per la mamma Rosa che pregava e desiderava dare un figlio al Signore, ma le parole di Don Folci favorirono lo schiudersi e il maturare di questa vocazione di rara bellezza.
… Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1954 a Milano, dal Beato Card. Schuster. Ero bambino ma ricordo bene che sua mamma aveva messo un vestito nuovo per riceverlo meglio: per lei era una grande festa. Quel giovane sacerdote nelle sue celebrazioni pareva un angelo. Io ne provavo una santa invidia e dicevo tra me: un giorno voglio essere come lui!... Ero presente in casa sua la mattina in cui P. Pierino, dopo la morte della mamma, dava l'addio ai suoi cari in lacrime. Egli, forte e sereno, seppe vincere la commozione e disse solo: ‘Quando Dio concede ad una famiglia una grazia grande come quella del dono di un sacerdote, chiede sempre qualche sacrificio!’. Per lui il sacrificio è stato continuo ed intenso, anche se le sue spalle erano deboli... Ho definito P. Pierino, nel titolo di questo mio ricordo, come 'bel' prete - un'espressione cara a Don Giovanni Rossi della Pro Civitate Cristiana di Assisi -, cioè un prete riuscito, un vero amico di Dio e degli uomini...
Vero figlio di S. Daniele
Nel mese di maggio del 1946, Pierino, dalla scuola apostolica di Brescia, indirizzò a P. Antonio Vignato la domanda per essere ammesso al noviziato, insolitamente lunga, quattro facciate. Alcuni passaggi aiutano a comprendere la dimensione missionaria e comboniana della sua vocazione: “Il mio noviziato dovrà formare, plasmare l'anima mia, trasformandola in anima di sacerdote e di missionario... O missionario santo, o subito in paradiso: è la preghiera che ogni mattina rivolgo a Maria, sicuro di essere esaudito... Il Signore e la Madonna mi aiutino a non venir meno agli obblighi che questo passo richiede da me; Mons. Comboni guidi l'anima mia e la trasformi come deve essere un'anima dei suoi figli”.
A questa sicurezza e determinazione giovanile, fa riscontro un'affermazione dell'ultima settimana di vita: “Oramai sono nel numero dei nostri ammalati, ma felice di poter concelebrare la Messa. Comunque sono sempre Missionario Comboniano e son ben contento di esserlo”. Come si sia attuato il suo 'essere missionario' è stato già detto. Va aggiunto che negli anni sessanta era stato destinato all'Uganda: non poté partire. Le ricorrenti crisi a causa della delicata salute convinsero i superiori a cancellare la destinazione. Visse nelle comunità di Roma lavorando per le missioni e fra il dicembre 1976 e il gennaio 1977 si realizzò il suo sogno di visitare l'Africa. Mons. Armido Gasparini era prefetto Apostolico di Awasa, in Etiopia. Per molti anni, fino al 1973, procuratore a Roma, aveva aiutato P. Pierino e lo aveva sostenuto nella sua malattia. Il diario che scrisse al termine di quella sua esperienza lo destinò solo ai familiari e ne siamo venuti a conoscenza solo ora. Inizia con questa premessa: “Nessuna pretesa di essere completo in questo mio diario: solo impressioni di un missionario che per la prima volta, a 48 anni d'età, ha la fortuna e la gioia di poter vedere con i suoi occhi un’autentica missione ai suoi inizi, ricca di speranza per abbondanti frutti evangelici”. Questo incipit introduce bene l'atteggiamento interiore di P. Pierino che si stupisce, vede tutti i protagonisti, i Sidamo, le suore, i catechisti, i missionari in una luce eroica, in una lotta contro elementi ostili.
Un iniziale e commosso pensiero, durante la sosta dell'aereo a Khartoum, alle 3.30 del mattino, è per il Comboni, ora S. Daniele: “Mentre atterravamo la città di Khartoum mi sembrò, nel buio, un 'collage' di brillanti o una grossa perla risplendente di tutti i colori posta sul cuore di questa bella signora che ha nome Africa. L'Africa di Mons. Comboni! Qui a Khartoum questo grande apostolo lavorò intensamente, pronunciò parole di intensissimo amore per i suoi Neri e parole forti, indignate all'indirizzo di politici, di colonialisti, di negrieri. Qui egli concluse la sua vita terrena a cinquant'anni, e qui i suoi figli e figlie si avvicendano per continuarne l'opera. In questa calda e assonnata ora del mattino, mettendo piede sul suolo africano, avrei dovuto inginocchiarmi a baciare quella terra. Così facevano i missionari del passato. Ne fui dissuaso alla vista dei soldati che imbracciavano il mitra. Non era più quello il deserto percorso dalle carovane, e dov’erano i moretti tanto cari al Comboni, indifesi, abbandonati, facile preda degli schiavisti? A un secolo di distanza tutto è cambiato e trasformato. Il progresso, vero o falso, ha cancellato - o forse solo coperto - le lacrime e le fatiche del Comboni. Tocca ora ai suoi discepoli far sentire nuovamente quella voce calda di amore. Dopo un'ora di sosta l'aereo decolla e mi piace, guardando dall'oblò, pensare al Comboni come ad una di quelle perle che ancora brillano giù sotto, la più luminosa”.
Le visite alle comunità-missioni dei Sidamo coincisero con gli ultimi giorni di avvento e col Natale etiopico (7.01.1977). Awasa, Tullo, Dongora, Dilla, Fullasa, ecc. sono descritte nei loro particolari ma sono le persone ed il paesaggio che ci fanno capire ciò che lo colpisce. Le donne si caricano sulla schiena grosse anfore di acqua: durante la stagione secca spesso è perfino scarsa e non potabile. Ammira i catechisti “giovani che sanno comunicare nella loro lingua. Bravi giovani che hanno il compito di dare i primi colpi di zappa nel terreno vergine delle coscienze di questa gente... la loro”.
A Malekka partecipa ad una festa d'inaugurazione. Alla fine c'è un banchetto sul prato. Sono stati macellati due buoi. Noto un po’ timoroso e appartato, un lebbroso con il suo pezzetto di carne ben saldo tra le sue povere mani senza dita. Anche lui è venuto perché si sente figlio di Dio e invitato...”. Descrivendo il Natale si sofferma sulla vigilia, le confessioni, i preparativi. Commenta la festa: “Arrivano a gruppi; con la bandiera, cantando e pregando. Hanno percorso 10, 20 km. pur di essere presenti alla messa di Natale. Certo il Signore nasce volentieri in mezzo a loro: povero come loro, dimenticato come loro”. Delle suore è stupito perché le vede più disinvolte delle loro consorelle conosciute in Italia: sempre pronte nella loro divisa kaki ed una ha perfino un cavallo… è infermiera e se ne serve per le emergenze. Fratelli e padri li descrive capaci di tutto e disposti a tutto. Ne nomina e descrive uno che rappresenta tutti: “Cappellaccio ben calcato sulla fronte, viso stagionato dal sole, la barbetta caprina, il vestito polveroso e due scarponi che conoscono polvere e fango. Pedala per ore: si ferma solo quando è circondato dalla gente. Se può li aiuta, sempre li conforta”. Diamogli infine la parola per la conclusione: bella, singolare e di non facile interpretazione: “Sono rientrato in Italia e volente o nolente mi sono rituffato nel caos della nostra cosiddetta civiltà. Ma il ricordo è rimasto laggiù, tra i Sidamo. L'ambiente che ho visto ha una sua nota di durezza, di primordiale. I grilli, di sera e per buona parte della notte, non cantano, stridono, con prepotenza, da padroni. Gli uccelli, moltissimi e dalle forme e colori i più svariati, fanno solo versacci, come anime in pena. Perfino le stelle guardano giù dal cielo - un cielo troppo intensamente azzurro - con durezza, sono troppo scintillanti, forse per orgoglio, forse perché se ne infischiano delle nostre povere cose e avvenimenti umani? E direi che la gente di laggiù da loro la pariglia: ci sono forse poeti romantici che cantano alle stelle? Temo che la gente abbia altro da pensare. Le piante son contorte, sacrificate, in lotta perenne con l'arsura della stagione asciutta e con gli uragani della stagione delle piogge. Niente pace, solo un senso di relativo equilibrio fondato sulla lotta per la sopravvivenza. Come per i Sidamo”.
Consegnare la memoria
Si parla spesso della memoria storica, della tradizione e se ne asserisce l'importanza. L'acquisizione e la trasmissione sembrano fatti scontati e quasi automatici. Non è così. Ogni Comboniano dovrebbe sentire il dovere di lasciare, se non un testamento spirituale formale, una testimonianza sulla sua vita. Possediamo 14 volumi dei diari della vita missionaria di P. Giuseppe Zambonardi. Abbiamo i diari spirituali ricchi - ed inediti - di Fr. Angelo Viviani. Così pure P. Roberto Cona ha scritto della sua esperienza umana e spirituale. Si potrebbero citare altri nomi: ma non molti. Mentre viene steso questo necrologio giunge la notizia della scomparsa di Fr. Giovanni Zucchelli: egli è il defunto N. 1075 nella storia dell'Istituto. Questa numerosa comunità di 'viventi in Dio' e composta, per noi, di persone - in gran parte - sconosciute. P. Pierino ci aiuta a prendere coscienza di questo aspetto importante della nostra identità comboniana. Dai suoi scritti vengono tolti alcuni testi: lui che è vissuto in silenzio, ora ci parla.
Da una lettera scritta nel dicembre 1953 ai suoi compagni: “Carissimi confratelli diaconi, volge al termine la nostra ascesa al sacerdozio, la meta è a pochi passi. Sono passati 14 anni da quando la porta del seminario si è aperta con un sogno in cuore: diventare sacerdoti. Alcuni di noi passarono tutti questi anni insieme: lotte, sofferenze, speranze e gioie ce le dividemmo, come ci dividemmo il pane. Soprattutto fummo sempre un cuor solo. Il segreto della nostra unione è stata sempre Maria. Un gruppo di noi ha pensato, prima che sopraggiungano le preoccupazioni della vigilia, ad alcune semplici iniziative: preghiera quotidiana vicendevole: un’ora del breviario; ogni anno, possibilmente nello stesso giorno, una Messa per la classe; una Messa di suffragio, oltre a quella della regola, per chi ci precede; tutti ci impegniamo a diffondere la devozione mariana.” Lui ci ha lasciato nel 49° anno di sacerdozio...
Programma dell'ordinazione: “Sacerdote missionario religioso. Il mio ideale: Gesù il più bello dei figli degli uomini. Il mio proposito: amare Gesù con passione, rinchiuso nel suo Cuor. La mia lotta: combattere tutto ciò che può rovinare la mia vocazione. Il mio programma futuro: fedeltà al ministero secondo l'obbedienza. La mia domanda: consumare la mia esistenza per Gesù, con Maria”.
La sua visione cristocentrica e mariana lo porta - certo con il lessico e lo stile datato del suo tempo - all'essenziale, come in questo pensiero scritto durante un ritiro: “In che cosa consiste l'eroismo della santità? Nel compiere con costanza il proprio dovere: ha un immenso valore. Il mio dovere ogni giorno: ecco quello che vuole da me il Signore. Messo davanti alle responsabilità e ai sacrifici futuri confiderò in Dio: con Lui posso tutto. Fiaschi ne fanno tutti: perché allarmarsi? Accetto con rassegnazione dalle mani di Dio e tutto finirà a mio vantaggio”. Si sente in queste righe la croce pesante dei lunghi anni di degenza per la malattia... Il tema più ricorrente nei suoi scritti è quello della preghiera che si può riassumere in alcune sue brevi espressioni: “Il Signore non ha bisogno di molte parole... Vi sono dei gradi della preghiera: occorre progredire... Il raccoglimento e il silenzio preparano la preghiera...
La mia meditazione deve essere personale, pratica, che diriga la giornata. Solo la preghiera ed il sacrificio mi formeranno”.
Da un suo articolo su “Comunità Valtartano” (ottobre 1989), dal titolo: “La Madonnina della Caiurga”, che ricorda un’effigie della Madonna posta su una roccia, vicino alla strada. Poi la descrizione si fa preghiera: “Vergine benedetta, tu mi hai visto tante volte passare fanciullo con il mio carico sulle spalle diretto all'alpeggio e alla contrada, da solo, o più spesso con la mamma o papà e con i fratelli e sorelle, con i cugini. Hai accettato benevola il nostro breve saluto con comprensione materna, quando noi ragazzi ci attardavamo in cerca di lamponi. Tu hai sempre nei tuoi occhi materni la processione di uomini e donne con in spalla gli zaini o le gerle. Ti voglio oggi pregare: radunaci per un momento accanto a te. I vivi, ormai fatti anziani e con il loro carico di ricordi, di esperienze di vita, di anni passati lontano in terra straniera. Ti vogliamo dire che ritorniamo a te volentieri per offrirti la nostra vita con le sue ferite e gioie. Tu tutto accetti, tutto perdoni e ci consoli. E i cari morti: i figli ed i nipoti ti dicono tutta la loro riconoscenza per loro. Tu resti sempre al tuo posto, Vergine vigilante. Tu sai tutto del mio e nostro passato, e del presente e del futuro. Pensaci o Madre benedetta e non abbandonarci.”
Verso la patria in comunione con i suoi
“Ti lodino i popoli, o Dio ti lodino i popoli tutti” (Salmo 66,8) sono le parole che P. Pierino scelse per la sua immagine ricordo dell'ordinazione e continuava chiedendo alla Madonna di ricompensare parenti, superiori e benefattori. La sua vita ha continuato a svolgersi in questo orizzonte, anche se non apparivano evidenti i segni esterni di appartenenza. Scrivendo alla nipote Rosangela, nel giugno 1996, si scusava di non essere stato presente al funerale di Remo: “Ho seguito questo avvenimento nel silenzio della casa religiosa e in preghiera, e mi sono sentito molto vicino a Remo e agli altri nostri cari defunti. Come per il funerale di Remo, fratello che lui amava molto, così per altre circostanze da più di 10 anni non era tornato al paese. Egli portava come primo nome quello di Marcello, lo zio paterno che era emigrato in Australia. Con i figli e con un duro lavoro era diventato un noto costruttore: lo invitò in Australia ma egli non vi andò. Il legame si era ulteriormente stretto perché Justin Joseph, figlio di Marcello entrò in seminario a Perth, fu ordinato nel 1964 e dal 1992 è vescovo di Geraldton, diocesi suffraganea di Perth. Per lui scrisse un lungo articolo sulla rivista della valle che termina così: “La parentela di Campo gli è vicina con l'affetto e la preghiera e con un tantino di orgoglio, scusabile, vero? E penso che sia lo stesso per la popolazione della valle. Perché dopo tutto è il primo successore degli apostoli di questi paraggi”. P. Pierino era fatto così: vigile e contento di essere unito ai suoi con la preghiera ed il ricordo. A Milano sentiva la nostalgia di Roma e scriveva: “Mi sarebbe piaciuto morire a Roma ed essere sepolto assieme, si fa per dire, ai papi ed ai vescovi e sacerdoti e fedeli della capitale della cristianità. Sarò con loro, in ogni modo, dopo la mia morte”.
Ora che riposa fra i suoi monti salutiamolo con le parole di P. Luigi Speziale: “P. Pierino, ora che godi della vista. di Dio Trinità, non dimenticare il tuo paese, la tua parrocchia, i giovani, i ragazzi: ottieni che ci sia ancora qualcuno, generoso come te, che accetti di prendere il tuo posto, in quell’avventura che è lasciare tutto per seguire il Signore”. (P. Pietro Ravasio, mccj)