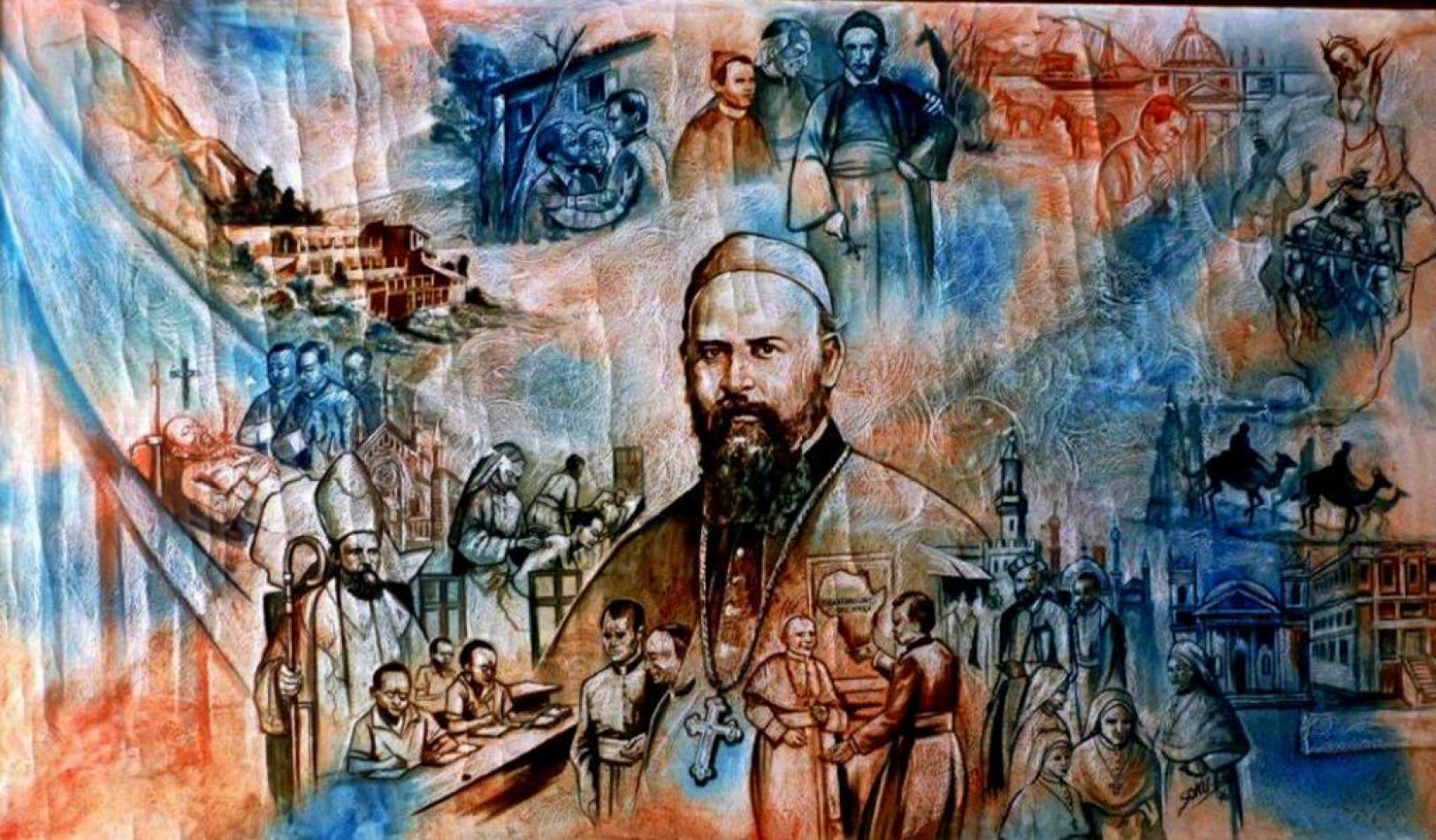Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
STUDI ED ESPERIENZE
P. Mariano Tibaldo
01 – Alla Ricerca di una Ratio Missionis: un lungo processo
Il progetto di una Ratio Missionis non è nato nel Capitolo del 2003. L’idea è molto più datata: si potrebbe farla risalire ai primi anni ’80 del secolo scorso, e precisamente all’intercapitolare del 1982, quando il Consiglio Generale di allora si impegnò a promuovere “la riflessione e la ricerca sul carisma comboniano, spiritualità e metodologia missionaria” (Assemblea Intercapitolare 1982. Mozioni e Orientamenti, p. 4, Roma Archivio Missionari Comboniani, D/613/30.).
I Capitoli Generali, a cominciare da quello del 1969, furono all’origine di questa ricerca. Il Capitolo del 1979, in particolare, demandò al CG il compito di rivedere “il nostro tipo di presenza in ogni campo di lavoro con i seguenti criteri: situazione dell’evangelizzazione, possibilità di vita comunitaria e conformità con il fine dell’Istituto” (Atti Capitolari 1979; n. 10.1.).
Queste furono alcune delle ragioni che dettero un impulso ad uno studio che qualificasse e desse le linee essenziali di un metodo missionario; un tema che, negli anni a seguire, assunse diverse caratteristiche: ricerca di una metodologia missionaria comboniana (abbinando quindi la missione alla nostra identità comboniana), tentativi di un piano per preparare una Ratio Evangelizationis per sfociare, poi, nella Ratio Missionis attuale.
02 – Il problema della duplice appartenenza
Qualche mese fa ero al Cairo per partecipare all’assemblea provinciale. L’intenzione iniziale era di andare anche a Khartoum per la seconda parte dell’assemblea. Il tanto sospirato visto, però, non mi era stato rilasciato dall’ambasciata sudanese. Una grande delusione! La data del mio ritorno a Roma era fissata per la settimana successiva, quindi avevo otto giorni da passare in Egitto. Ne ho approfittato per visitare alcuni Istituti che si impegnano nel dialogo interreligioso e studiano la realtà dei cristiani in Medio Oriente. Mi premeva far visita, oltre che al Centro Francescano di Studi Orientali Cristiani, all’Istituto Domenicano per gli Studi Orientali (IDEO). Avevo sentito parlare di quest’ultimo come una delle più importanti istituzioni in terra d’Egitto per quanto riguarda la conoscenza dell’Islam e l’approfondimento del dialogo tra musulmani e cristiani. Vi sono andato accompagnato da due confratelli, P. Giuseppe Scattolin e P. Alberto Modonesi. Ad accoglierci abbiamo trovato P. Jean Druel, giovane domenicano francese e rettore dell’Istituto. Abbiamo visitato gli ambienti dell’Istituto conversando amichevolmente con P. Jean. Mi ha impressionato la biblioteca sia per l’ordine meticoloso che vi regnava che per la quantità di volumi e pubblicazioni che coprivano tutte le discipline degli studi islamici, ciò che era stato scritto sull’Islam da autori musulmani e non, dal 1700! Ma quello che mi ha particolarmente colpito è stata una frase di P. Jean il quale, parlando della sua relazione con l’Islam, ha fatto un’affermazione che mi ha lasciato alquanto perplesso ma con una gran voglia di approfondire il discorso. In estrema sintesi, P. Jean difendeva la plausibilità di una duplice appartenenza: alla fede cristiana e all’Islam. Affermazione per me alquanto sconcertante e apparentemente contraddittoria. Purtroppo, la questione è rimasta a livello di enunciato e tutto è terminato lì.
L’argomento della duplice appartenenza non mi era nuovo. Ne avevo sentito parlare anche in altri contesti culturali e religiosi. In Brasile, per esempio, ero venuto a conoscere il lavoro del comboniano P. Ettore Frisotti e del sacerdote francese François de Espinay: ambedue si erano inseriti nella realtà afro-brasiliana ed erano stati ‘iniziati’ alla religione del candomblé di cui condividevano riti e molti dei principi ispiratori. Ne parlava P. Paolo Dall’Oglio, gesuita e fondatore della comunità monastica di Deir Mar Musa in Siria, a proposito del suo rapporto con l’Islam. Il problema della duplice appartenenza era una questione che mi sarebbe piaciuto esaminare perchè faceva appello non solo a mera curiosità intellettuale, ma anche al mio mondo profondo, a quello, cioè, degli ideali, dei valori, delle certezze su cui avevo scommesso la vita, quindi anche al mondo emotivo. Com’è possibile essere cristiani e musulmani, o altro, allo stesso tempo? Che cosa vuol dire duplice appartenenza? In che cosa consiste?
La duplice appartenenza non è solo quel sincretismo popolare e, per così dire, intuitivo che consiste nella fusione di dottrine e pratiche religiose non giustificata razionalmente ma appartenente alla dinamica dell’inconscio. È molto di più: è lo sforzo razionale e cosciente di appartenere a due mondi apparentemente non conciliabili perché hanno la stessa pretesa (almeno per quanto riguarda il cristianesimo e l’Islam) di verità e assolutezza. Com’è possibile, dunque, appartenere a due verità così esclusive? A margine, il discorso coinvolgeva la profondità e il significato del dialogo interreligioso e dell’inculturazione.
Avevo letto il libro di P. Ettore, Religioni afro-brasiliane nel dialogo con la Chiesa cattolica. Il libro, pur con tutti i suoi meriti, non affrontava direttamente la questione. Non avevo approfondito la complessa articolazione dell’opera del teologo Jacques Dupuis sul dialogo interreligioso, pur avendo letto alcuni suoi articoli. Mi sono interessato, invece, al libro di P. Paolo Dall’Oglio, Innamorato dell’Islam e credente in Gesù, un libro che fissa in intuizioni, pensieri e riflessioni la lunga esperienza di dialogo e convivenza dell’autore con i musulmani nel monastero siriano di Deir Mar Musa. Non è quindi un trattato teologico organico e articolato. Nelle argomentazioni di P. Dall’Oglio si percepiscono la sua passione e ammirazione per l’Islam; alcune intuizioni, però, andrebbero elaborate e indagate più a fondo; altre asserzioni, che sottolineano corrispondenze tra la religione ebraico-cristiana e quella islamica, mi sembra non diano ragione delle pur notevoli differenze, mentre altre affermazioni, dove l’autore dà l’impressione di voler mitigare giudizi negativi su alcuni fatti della storia islamica associandoli a fatti altrettanto negativi tratti dalla storia del cristianesimo, non mi convincono totalmente.
È mia intenzione, in questo articolo, presentare ciò che P. Paolo Dall’Oglio intende per ‘duplice appartenenza’, quali sono gli elementi qualificanti e come egli possa far ‘convivere’ due appartenenze che richiedono un’adesione totale da parte dei propri membri. Non ho la pretesa di interpretare il pensiero del gesuita: dopotutto, come ho avuto modo di sottolineare in un altro articolo, l’oggettività è sempre filtrata attraverso punti di vista soggettivi che, se da un lato potrebbero limitare la comprensione di un autore, dall’altro, però, possono rilevare in un testo nuove sfumature e connessioni che ne approfondiscono l’intelligenza.
P. Antonio Vignato, nel Sudan dei primi anni del secolo scorso successivi alla Mahdia, si domandava come si potesse organizzare una missione, considerando che non si avevano modelli da imitare e nessuno dei missionari presenti aveva un’esperienza da condividere al riguardo; infatti, la rivoluzione del Mahdi aveva cancellato il lavoro missionario per quasi un ventennio e non esistevano, nel Sudan, manuali che guidassero l’attività missionaria.
Nelle tre missioni del sud si erano affermati due criteri di lavoro: quello di chi affermava che, per ‘fare’ i cristiani, “bisognava prima fare gli uomini” – quindi dando priorità all’”assistenza caritativa”; e di chi, invece, asseriva che prima bisognava “fare dei buoni cristiani” per ottenere “bravi uomini” – e, perciò, la formazione religiosa doveva essere prioritaria rispetto alla cosiddetta “beneficenza” (A. Vignato, Note storiche sulla missione del Bahr-el-Gazal, in Bollettino della congregazione, (1959)33, pag. 1252-1253). Naturalmente, le questioni poste non erano di pura teoria missionaria ma erano frutto di un particolare contesto in cui lavoravano i primi missionari, a contatto con una popolazione abbrutita da anni di schiavitù, afflitta dalla distruzione delle culture e della coesione sociale, e falcidiata dalla fame e dalle malattie. Due metodi di “organizzare una missione”, ciascuno promosso da due figure straordinarie: il Vicario Apostolico Franz Xaver Geyer propendeva per la promozione umana come primo passo per arrivare, in seguito, alla formazione religiosa; il Vignato favoriva invece, come suaccennato, un approccio in cui l’insegnamento religioso doveva essere il compito primario.
Il principio del Vignato sarà quello adottato nelle nostre missioni sia del Sudan che in quelle dell’Uganda; un principio che, poi, si sarebbe arricchito di un metodo missionario vero e proprio che sarebbe stato esposto nella sua Raccolta di suggerimenti e dottrine per utilità pratica del giovane missionario.
Il metodo su ‘come organizzare una missione’ rimase invariato (almeno nelle missioni del Sudan e dell’Uganda) fino agli anni sessanta del secolo scorso quando, sotto la spinta dei cambiamenti in atto nella società africana e nella Chiesa e a contatto con nuovi campi di lavoro, si cominciò a porre in questione questo metodo e cercare vie nuove di presenza. Non solo. L’accento posto sulla primigenia inspiratio e, quindi, sulla particolarità carismatica dell’essere missionario comboniano, fece sorgere la domanda se esistesse pure una peculiarità di metodo di lavoro. Ecco, quindi, gli sforzi di specificare, negli anni seguenti, il metodo comboniano di attività missionaria attraverso varie formulazioni del tema, con relativi tentativi di risposta: metodo di apostolato, metodologia missionaria, metodologia missionaria comboniana, ratio evangelizationis, ratio missionis.
Finora, però, il lungo processo non ha portato a formulazioni conclusive e il tema, ad essere proprio sinceri, sembra ormai logoro. Oltretutto, è un fatto ormai assodato che l’epoca dei manuali, come la pretesa di imbrigliare la missione in particolari principi, norme e regole, sia superata. Ma questo non ci esime dal domandarci se veramente esista una nostra specificità di metodo di lavoro e in che cosa essa consista.
Le tematiche di fondo
Ci sono due assi portanti che hanno qualificato l’identità del missionario comboniano e che sono chiaramente elaborati dal 1969 in poi: il Comboni come figura di fondazione e orizzonte ideale e la missione/evangelizzazione ad gentes come criterio delle scelte di vita dell’Istituto.
“Nato dalla missione e per la missione – afferma il Capitolo del 1969 – è alla missione che l’Istituto deve continuamente riferirsi. Tutte le sue strutture, le opere, le Costituzioni che lo reggono, la formazione dei suoi membri, il genere di vita e di attività che essi svolgono… devono ispirarsi ad un fine esclusivamente missionario. La sua stessa spiritualità è legata al carisma della vocazione missionaria […] nel modo che ha qualificato la vita del Comboni e dei membri più rappresentativi dell’Istituto” (Documenti Capitolari 1969, Parte Prima, n. 65.).
Indagare sull’evangelizzazione/missione ad gentes e analizzare, per quanto sia possibile, come alcune tematiche di fondo legate a tale dimensione siano state elaborate, è l’obbiettivo di questo lavoro. Tali tematiche – seguendo, in linea di massima, la struttura dell’enciclica Redemptoris Missio – sono le seguenti: fine e natura dell’evangelizzazione, i suoi ambiti e orizzonti (cioè a chi e dove si indirizza l’azione missionaria, quindi il contesto in cui si svolge tale attività); le vie dell’evangelizzazione (pertanto le modalità attraverso cui essa si esplica); i responsabili dell’evangelizzazione e le dimensioni spirituali del missionario. Ritengo che le tematiche sull’evangelizzazione/missione ad gentes si siano arricchite, negli anni, di sfumature differenti perché diversi erano i contesti politici, sociali, religiosi e istituzionali in cui l’Istituto e i suoi membri operavano.
Naturalmente, bisognerebbe studiare la storia generale dell’evangelizzazione nell’Istituto per avere un quadro generale degli argomenti in questione. Penso sia possibile, però, studiare tali tematiche in ciò che “è l’autorità suprema dell’Istituto, esercitata in maniera straordinaria e collegiale, [che] esprime la partecipazione di tutti i missionari alla vita dell’Istituto” (Regola di Vita, 146), cioè i Capitoli Generali, e vedere come sono state elaborate nel corso egli anni.
Vorrei prendere in esame gli Atti Capitolari dal 1969 al 2009. Parto dal 1969 perché è da quell’assise capitolare che lo ‘specifico’ del missionario comboniano diventa oggetto di riflessione. Per evidenti limiti di comprensione della lingua tedesca da parte mia, indagherò solo gli Atti dei Capitoli dei FSCJ e non quelli della Congregazione dei MFSC. L’unione delle due Congregazioni sarà definitivamente sancita, come è noto, nel Capitolo Generale del 1979.
Un elemento importante da chiarire è cosa si intenda per ‘contesto’ quando si parla di Capitoli Generali. È indubbio che vi sia un contesto generale dato dalla situazione della Chiesa e dell’Istituto, ma è altrettanto evidente che ognuno dei delegati al Capitolo porti con sé, potremmo dire, un particolare contesto dato sia dal luogo in cui il missionario opera sia dalla sua geografia di provenienza familiare. Un confratello che lavora in America Latina con i popoli indigeni avrà un modo particolare di declinare l’impegno missionario ad gentes, così come diversa sarà la maniera di attuarlo di un confratello che lavora con i popoli pastori dell’Africa dell’Est; diverse saranno le sensibilità circa le strutture di missione di un confratello africano da un europeo. Cioè, fermo restando che la ‘missione come evangelizzazione ad gentes’ faccia parte della nostra identità, i punti di vista teorici e le esplicitazioni pratiche di tale principio costituente diventeranno più differenziate nelle varie situazioni. E ciò ha delle ripercussioni non indifferenti in un Capitolo Generale. Sono convinto che più la composizione geografica e di lavoro dei partecipanti ad un Capitolo si diversifica, più i temi tendono ad assumere sfumature diverse (quando non precomprensioni differenti); questo può creare conflitti ma anche nuovi arricchimenti nella comprensione stessa della missione.
Due note in chiusura. Le tematiche di ogni Capitolo sono precedute da una breve (necessariamente incompleta) descrizione del contesto politico-ecclesiale mondiale e della situazione delle missioni comboniane: il contesto ‘situa’ il Capitolo e ne dà le coordinate storiche che, parzialmente, ne spiegano le decisioni.
Nel corso dell’elaborato le parole ‘evangelizzazione ad gentes’, ‘evangelizzazione’, ‘attività missionaria’, ‘azione missionaria’, ‘missione’ sono praticamente intercambiabili e usate con lo stesso significato.
04 – La scelta preferenziale dei poveri e l’impegno sociale nell’Istituto dei Missionari Comboniani
Sono passati cinquant’anni dallo storico Patto delle Catacombe sancito il 16 novembre del 1965 nelle catacombe di S. Domitilla a Roma. Il Patto non era altro che un impegno, sottoscritto da una quarantina di vescovi, partecipanti al Concilio Vaticano II, a vivere la vita semplice della gente, rinunciare ad ogni forma di potere, di ricchezza e di privilegio: “Cercheremo di vivere come vive ordinariamente la nostra popolazione per quanto riguarda l’abitazione, l’alimentazione, i mezzi di locomozione e tutto il resto che da qui discende”, “Rinunciamo per sempre agli abiti (stoffe ricche, colori sgargianti)”, “Non possederemo a nostro nome beni immobili, né mobili, né conto in banca”. Inoltre i vescovi si impegnavano ad un’azione politica presso i governi perché attuassero strutture di giustizia, uguaglianza, sviluppo; a liberarsi dalla gestione finanziaria della diocesi che sarebbe stata affidata ai laici per essere più liberi per il lavoro pastorale e per servire i poveri; a condividere la propria vita con i sacerdoti, religiosi, laici. Insomma, un impegno storico e altamente profetico a quel tempo che legava alcuni vescovi alla povertà e alla sobrietà come dimensione propria della loro vita e ai poveri come priorità nel loro servizio apostolico e pastorale.
I vescovi che sottoscrissero il Patto – tra cui figuravano personalità del calibro di Hélder Câmara, Leonidas Proaño, Antonio Fragoso, José Maria Pires, Luigi Bettazzi, il vescovo argentino Enrique Angelelli, assassinato nel 1976 – erano parte di un gruppo informale che si riuniva nel Collegio belga dal 1962 intorno al tema ‘Chiesa dei Poveri’. Questo gruppo, il cui animatore era Charles M. Himmer, vescovo di Tournai, si ispirava al teologo Paul Gauthier e alla religiosa carmelitana Marie-Thérèse Lescase; il gruppo prese il nome da una frase di papa Giovanni XXIII che, nel radiomessaggio dell’11 settembre 1962, a un mese dall’inizio del Concilio, dichiarò: “Di fronte ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri”.
Ma il tema della povertà della Chiesa non fu un tema particolarmente avvertito al Concilio Vaticano II, nonostante le insistenze del Card. Giacomo Lercaro, che avrebbe voluto che il povero e la povertà della Chiesa fossero al centro delle preoccupazioni dell’assise conciliare. L’appello di Lercaro, invero, fu recepito in un brano della Lumen Gentium n. 8,3 – che parla della Chiesa come di colei che “riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne l’indigenza e in loro cerca di servire il Cristo” – ma il significato rivoluzionario di quella frase non fu portato alle sue conseguenze pastorali né venne veramente assimilato. Oltretutto Paolo VI temeva che la questione della povertà avesse delle ricadute politiche (erano i tempi della ‘guerra fredda’ e della paura del comunismo); il Papa, comunque, si impegnò a riprendere i suggerimenti di Mons. Lercaro in un secondo momento, dopo l’evento conciliare. Questo impegno avrebbe preso la forma di un’enciclica, la ‘Populorum Progressio’ (J. Sobrino, La «Chiesa dei poveri» non ha avuto sviluppo al Vaticano II, in Il Patto delle Catacombe, a cura di X. Pikaza e J. Antunes da Silva, Bologna, EMI, 2015, pp. 133-145; cfr. anche J. Planella Baronsell, Gli artefici del Patto. Origine, evoluzione e tramonto del gruppo chiamato «Chiesa dei poveri», ibid. pp. 73-102.).
La povertà della Chiesa ebbe, invece, una trattazione articolata e l’azione della Chiesa fu pensata a partire dai poveri, considerati nella loro povertà esistenziale, nella seconda Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano a Medellin (Colombia) nel 1968; “La povertà della Chiesa e dei suoi membri in America Latina – si legge nel documento finale di Medellin – deve essere segno e impegno. Segno inestimabile del valore dei poveri agli occhi di Dio; impegno per la solidarietà con coloro che soffrono” (XIV, 7). E ancora “l’evangelizzazione ha bisogno, come supporto, di una chiesa-segno” (VII, 13). Nella terza Conferenza generale a Puebla (Messico), nel 1979, uno dei criteri e segni dell’evangelizzazione sarà “l’amore preferenziale e la sollecitudine per i poveri e i bisognosi” (n. 381).
Il Patto delle Catacombe assume una valenza epocale perché rompe con il patto costantiniano di alleanza tra trono e altare e diventa la chiave ermeneutica di una Chiesa che vuole liberarsi dalla commistione con il potere e il prestigio. L’impegno che, nelle intenzioni del Patto, era limitato ad una scelta personale di alcuni vescovi sarebbe diventato, negli anni a venire, una sfida per tutta la Chiesa: la povertà come dimensione propria della sua vita e i poveri come scelta preferenziale; una scelta che è allo stesso tempo teologica e cristologica perché, diceva Papa Benedetto XVI, “la scelta per il povero è radicata nella fede in un Dio che si è fatto povero in Cristo”. È una sfida che ancora fatica a trasformarsi in realtà ma che nondimeno è diventata parte integrante della coscienza che la Chiesa ha di se stessa. È la sfida di Papa Francesco: “Desidero una Chiesa povera per i poveri” (Evangelii Gaudium n. 198).
In questo articolo vorrei indagare sul senso che l’Istituto comboniano dà alla parola ‘povertà’ in quanto dimensione essenziale dell’essere missionario, quale l’identità del ‘povero’ nella missione ad gentes e attraverso quale processo i poveri, da ‘referenti privilegiati’ dell’evangelizzazione, si trasformano in soggetti dell’evangelizzazione stessa; infine, su come la prospettiva dell’Istituto circa l’impegno sociale sia cambiata nel corso degli anni. Questa indagine prenderà in considerazione i documenti principali dell’Istituto (soprattutto gli Atti Capitolari) dal 1969 al 2015. Gli Atti Capitolari del 1969 e del 1975 saranno solo quelli dei Figli del Sacro Cuore di Gesù (FSCJ) con membri in maggioranza italiani.
Nel dicembre del 1965 veniva promulgata la Costituzione Pastorale ‘Gaudium et Spes’ (GS). Un documento che non era stato preparato dalle commissioni preconciliari ma era lentamente maturato nel corso del Concilio Vaticano II. La GS era il frutto maturo dell’evento conciliare, un documento che ne captava, in un certo modo, ‘lo spirito’: quello di una Chiesa che ascoltava il mondo e dialogava con esso partecipando alle sue vicende e alle sue lotte.
L’esortazione apostolica Evangelii gaudium (EG) di Papa Francesco è giustamente considerata la ‘magna charta’ del suo pontificato, un documento che ne traccia le linee guida. La Chiesa, afferma Francesco, è essenzialmente una Chiesa ‘in uscita’ per cui “tutti siamo chiamati a questa nuova ‘uscita’ missionaria” (EG 20); la missione si radica e trova il suo punto di partenza nell’incontro con l’amore di Dio che ci riscatta “dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità” (8). Un vero rinnovamento della Chiesa e, perciò, di ogni comunità cristiana, scrive il Pontefice, trova il suo punto di partenza e la sua ragione d’essere nella gioia del Vangelo e in quella passione missionaria di renderlo presente nelle periferie sociali e geografiche del mondo: “Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione”(27).
Nel capitolo quarto dell’esortazione, il Papa esamina la dimensione sociale dell’evangelizzazione, essenziale per una missione evangelizzatrice che sia “autentica e integrale” e che renda presente il Regno di Dio sulla terra di cui il bene comune e la pace sociale sono i frutti. Ed è proprio per orientare la “costruzione di un popolo in pace, giustizia e fraternità” (221) che il Pontefice propone quattro principi-guida dandone una spiegazione articolata: il tempo è superiore allo spazio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà è più importante dell’idea e il tutto è superiore alla parte. Principi che sono applicabili anche alla dimensione missionaria della Chiesa e, direi, alla vita dell’Istituto comboniano.
Vorrei commentare i primi due con alcuni riferimenti alla situazione dell’Istituto oggi.
Il convegno organizzato a Nemi, in provincia di Roma, dal SEDOS (Service on Documentation and Study) aveva come tema la nuova evangelizzazione nei paesi occidentali [Per comodità si è preferito impiegare l’aggettivo ‘occidentale’ per parlare di zone che, secondo un’altra terminologia, forse meno carica di giudizi culturali, appartengono al Nord Globale.] (Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda), le sfide e le possibili soluzioni. Diversi esperti si sono succeduti nel corso del convegno, provenienti dai vari continenti e paesi che, culturalmente e socialmente, si possono definire occidentali. Ciò che gli interventi hanno fatto percepire è come le situazioni e le problematiche – nonostante alcune evidenti diversità – fossero simili e simili potessero essere le soluzioni o, almeno, le proposte di nuovi sbocchi pastorali. Un’altra impressione è che il ‘travaglio’ di una nuova presenza evangelizzatrice sia appena agli inizi e che, mentre si esplorano nuove vie di testimonianza cristiana, in molti ambienti di Chiesa si faccia difficoltà ad accettare una situazione totalmente nuova, dove la Chiesa è spinta ‘ai margini’, ma dove le domande di senso, di vita, di spiritualità sono altrettanto forti: domande non più ancorate ad un ambiente di ‘cristianità’ ma nondimeno presenti nelle società occidentali. È qui che si gioca la presenza cristiana. La nostalgia di un mondo passato o la critica negativa, fine a se stessa, delle società post-moderne e secolarizzate sono indici, in questo momento di profonda crisi, di mentalità sclerotizzate, irrigidite dalla paura; ciò che è necessario, invece, è una lettura sapienziale dei segni dei tempi che intravede, nelle contraddizioni di società apparentemente appagate e sicure di sé ma, nonostante tutto, intimamente segnate dalla paura e dall’incertezza, l’anelito alla trascendenza e la domanda di vita.
Questo contributo è suddiviso in quattro parti: la prima parte descrive la situazione delle società occidentali (socioculturale e della Chiesa); la seconda e la terza presentano alcuni approfondimenti teologici sulla nuova evangelizzazione e le basi spirituali per un lavoro di nuova evangelizzazione; infine, nella quarta, si espongono alcuni principi di lavoro pastorale possibili in società postmoderne, secolarizzate, tecnologiche e multiculturali come quelle occidentali. L’analisi della situazione, come le riflessioni teologico-spirituali e le proposte pastorali, sono una sintesi degli interventi al convegno di Nemi.
La rivista Missiology ha dedicato il numero di aprile al fenomeno della Missione a Breve Termine (MBT). Un tema che non sembra appassionare le riviste missionarie italiane ma che sta interessando gli ambienti accademici e missionari al di là dell’Atlantico. Il fenomeno della MBT è in aumento anche in Europa attraverso un numero crescente di giovani che spendono parte delle loro vacanze o del loro tempo lavorativo nelle missioni: quello della MBT è, infatti, un fenomeno tipicamente giovanile. Ciò che gli studiosi d’oltreoceano rilevano è che non si tratta di un’esperienza transitoria ma di un altro modo di essere missionari in un mondo post-moderno, dove impegni ad vitam o, comunque, di lunga durata diventano sempre più problematici. La MBT è anche associata alla trasformazione dell’immagine stessa di missione, ambito non più riservato a una élite ma, per così dire, in via di ‘democratizzazione’, giacché anche i laici sentono di potervi dare un contributo. Mi sembra perciò opportuno vedere la natura, la storia e gli elementi sia positivi sia negativi della MBT.
La bibliografia consultata in questo articolo è essenzialmente quella dell’area nordamericana e protestante. È importante tenerne conto nella lettura, perché i diversi modi e le problematiche della MBT si riferiscono a questa zona ed esperienza cristiana. Naturalmente sarebbe interessante vedere le differenze e le particolarità di questo fenomeno in ambito europeo e studiarne le fisionomie particolari nei diversi paesi. Questo, per il momento, non è possibile.
09 – Paradigmi, nuovi paradigmi missionari e problematiche aperte
Oggi si parla molto di nuovi paradigmi missionari e di modelli interpretativi della missione. E a ragione. La situazione del mondo e della Chiesa cambia e, con essa, il modo di fare missione. Esattamente per questo motivo abbiamo bisogno di ridare una sistemazione razionale ai mutevoli flussi storici, di comprendere gli eventi fissandoli in quadri d’interpretazione, in immagini riflesse e critiche che ne riassumano le linee essenziali, cioè sentiamo la necessità di elaborare nuovi modelli di missione. Particolari modelli diventano dominanti in alcune epoche storiche e sono indicati, secondo il teologo A. Dulles, con il nome di paradigmi.
10 – Una missione ‘nuova’. Sintesi di un questionario
In aprile del 2013 abbiamo partecipato a un seminario organizzato dal SEDOS (Service of Documentation and Study on Global Mission). Il titolo del seminario era: “Vino nuovo in otri nuovi: la nuova evangelizzazione in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda”.
Terminato il seminario, avevamo pensato di coinvolgere le consorelle e i confratelli per conoscere quali fossero le loro impressioni sul tema dell’evangelizzazione nelle società occidentali e quali scelte concrete si sarebbero prospettate per noi Comboniani. Sapevamo che il problema della presenza comboniana in Europa non era nuovo: le province comboniane europee stavano riflettendo da tempo sull’argomento e i simposi di Limone avevano lo scopo di ‘rivisitare’ il Comboni nella prospettiva della missione in Europa e proporre possibili sbocchi operativi.
Questa relazione è stata presentata durante il workshop sul Piano del Comboni (Roma, 15-19 settembre 2014). Tale presentazione ha lo scopo, come indica il titolo, di definire e precisare problematiche dell’Istituto comboniano ancora ambigue – lasciate, perciò, a interpretazioni soggettive – oppure ancora incompiute nella realizzazione pratica. Le problematiche da precisare, precedute da una breve introduzione storica che ne fonda lo sviluppo, sono le seguenti: la ‘durata’ dell’impegno missionario e l’identità dei ‘poveri e abbandonati’; la necessità di attenzione alla storia e alla lettura dei segni dei tempi; la missione come evento di comunità e di collaborazione. Inoltre la relazione sottolinea due sfide per l’autorità dell’Istituto: favorire il dialogo tra le varie culture che lo compongono, in vista di una vera interculturalità, e favorire il collegamento e la messa in comune delle varie esperienze di missione – la quale ha sempre più un carattere poliedrico e contestuale – perché queste diventino patrimonio comune e condiviso.
01_Alla Ricerca di una Ratio Missionis_un lungo processo
02_Il problema della duplice appartenenza
03_Evangelizzazione ad gentes nei capitoli generali I parte
03_Evangelizzazione ad gentes nei capitoli generali II parte
03_Evangelizzazione ad gentes nei capitoli generali III parte
04_La scelta preferenziale dei poveri e l’impegno sociale nell’Istituto comboniano
05_Il dono dell' incertezza
06_Il tempo è superiore allo spazio e l’unità prevale sul conflitto
07_La nuova evangelizzazione nelle società occidentali_situazione, sfide, proposte
08_Missione a breve termine
09_Paradigmi, nuovi paradigmi missionari e problematiche aperte
10_Una missione ‘nuova’. Sintesi di un questionario
11_Urgenze e sfide missionarie dei Comboniani nel mondo d’oggi